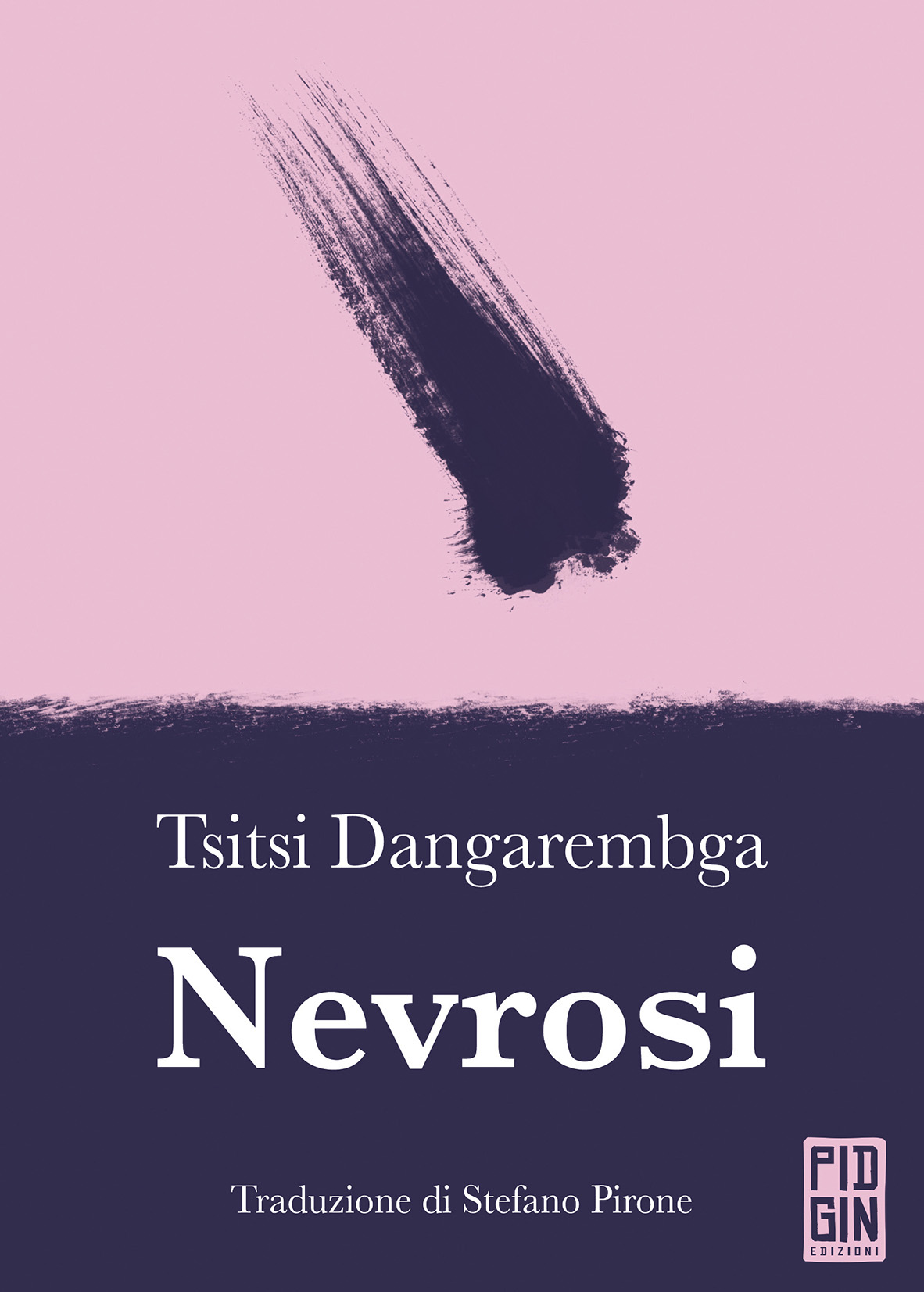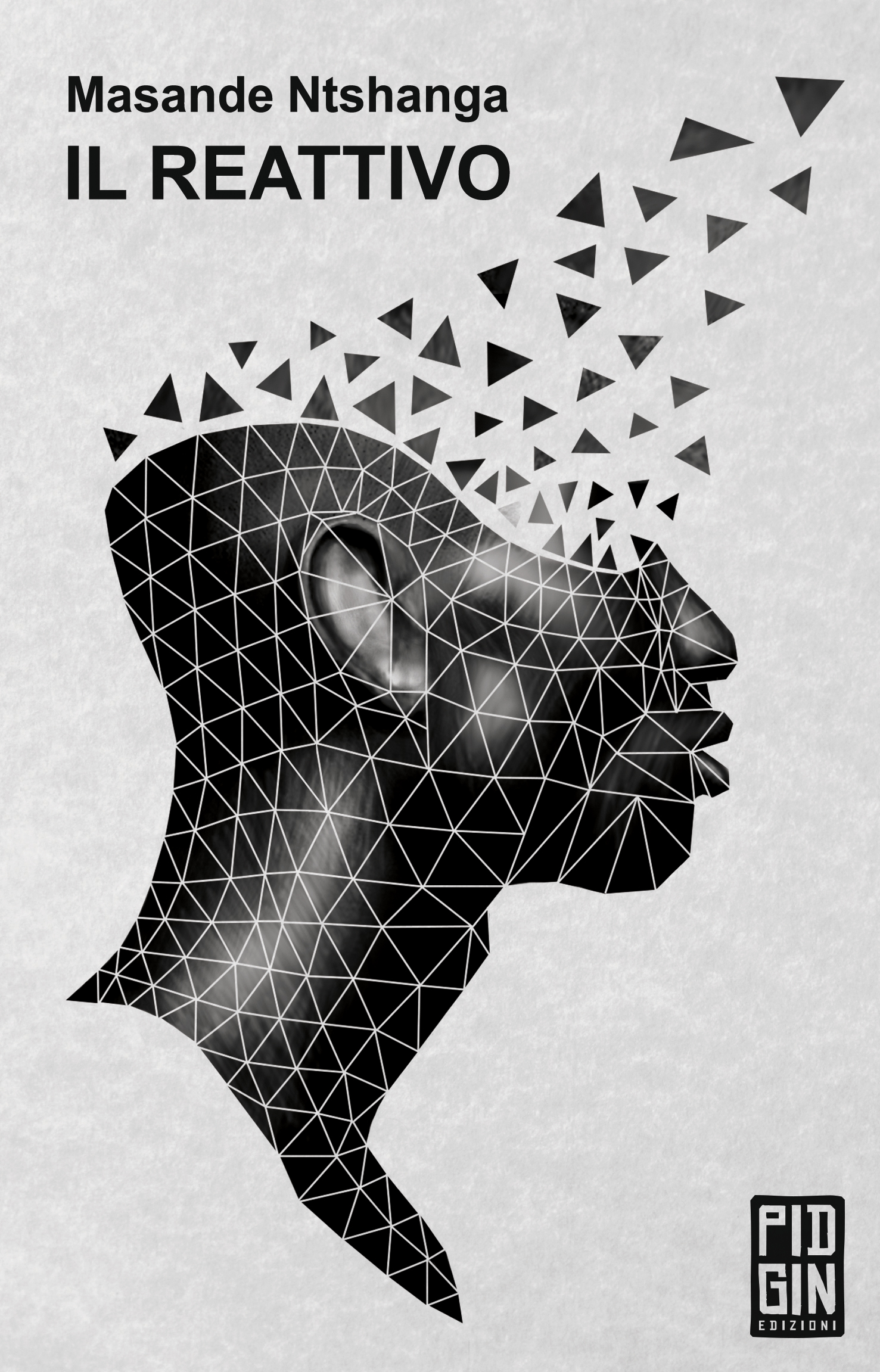Nevrosi – Tsitsi Dangarembga
Uno dei 100 romanzi che hanno cambiato il mondo secondo la BBC
Libro vincitore del Commonwealth Writers Prize nel 1989
Traduzione di Stefano Pirone.
Tambudzai è una ragazzina che sogna di ricevere un’educazione che le permetta di emanciparsi dalle limitazioni della sua vita in un villaggio rurale della Rhodesia, l’attuale Zimbabwe. L’occasione le si presenta quando il fratello Nhamo, unico figlio maschio della famiglia, muore improvvisamente. Lo zio Babamukuru, preside di una missione cristiana, le permette allora di studiare al posto del fratello, aprendole così le porte a una vita più agiata. Sulle spalle di Tambu gravano le aspettative e il futuro dell’intera famiglia, ma lei accetta volentieri il fardello inseguendo il sogno di un’educazione superiore. Tuttavia, alla missione, grazie anche alla convivenza con la cugina Nyasha, educata in Inghilterra e più consapevole delle problematiche legate alla colonizzazione e al patriarcato, comincia a dubitare che l’emancipazione tanto desiderata possa essere realmente raggiunta e che le opportunità ricevute siano motivate da pura generosità. Scritto con una lingua allo stesso tempo evocativa e dura, “Nevrosi” di Tsitsi Dangarembga è un romanzo potente che esplora la sottomissione in diverse forme – razziale, di genere, di classe – e la nevrosi della condizione postcoloniale.
In libreria dal 21 novembre, ma già ordinabile in prevendita sul nostro sito con spedizioni gratuite!
18,00€
Disponibile
Descrizione
Hanno detto di questo libro:
“Indimenticabile.” – Alice Walker
“Un capolavoro.” – Madeleine Thien
“Sensazionale.” – Kwame Anthony Appiah
“Il libro che stavo aspettando.” – Doris Lessing
“Un libro unico e prezioso.” – Booklist
Potrai ordinare il libro anche su Bookdealer dalla tua libreria preferita.
Preferisci l’ebook? Lo troverai in tutti gli store digitali!
Hai una libreria e ti interessa ordinare questo libro? Contattaci all’indirizzo ordini@pidgin.it oppure ordina il libro su Librostore.
Informazioni aggiuntive
| Scritto da | |
|---|---|
| Tradotto da | |
| Collana | |
| Formato | Cartaceo, copertina morbida, 15 x 21 cm |
| Pagine | 220 |
| Anno di pubblicazione | 2024 |
Estratto
(Incipit di “Nevrosi” di Tsitsi Dangarembga, traduzione di Stefano Pirone)
1
Non provai dispiacere quando mio fratello morì. E non intendo scusarmi per la mia freddezza, come la si può definire, la mia mancanza di sentimenti. Perché non sono affatto insensibile. Provo molte cose oggigiorno, molte più di quelle che potevo provare ai tempi della mia giovinezza e della morte di mio fratello, e ciò ha ragioni che vanno oltre le semplici conseguenze dell’età. Perciò non mi scuserò, ma comincerò a rievocare i fatti che portarono alla scomparsa di mio fratello, gli eventi che mi hanno messa in condizione di scrivere questo racconto. Sebbene la sua morte e le mie vicissitudini non possano essere separate, questa non è una storia di morte, ma la storia della fuga mia e di Lucia, della schiavitù di mia madre e di Maiguru, e della ribellione di Nyasha – la figlia di mio zio, idealista e isolata, la cui ribellione, alla fine, potrebbe non essersi rivelata un successo.
Avevo tredici anni quando morì mio fratello. Accadde nel 1968. Era la fine del trimestre scolastico e aspettavamo che tornasse a casa con l’autobus del pomeriggio che attraversava il nostro villaggio alle tre. Mio fratello studiava alla missione di cui era preside mio zio e che si trovava a una trentina di chilometri dal villaggio, a ovest, in direzione della cittadina di Umtali. A volte, quando mio zio non era troppo impegnato con le pagelle e le pratiche amministrative di fine trimestre, usciva dall’ufficio alle tre del pomeriggio, sacrificando le ore rimanenti della giornata per portare Nhamo a casa. Mio fratello preferiva così. Non gli piaceva viaggiare in autobus perché secondo lui era troppo lento. E poi le donne puzzavano di malsani odori riproduttivi, i bambini erano propensi a scaricare le loro viscere irritate per terra e gli uomini emanavano forti aromi di lavoro produttivo. Non gli piaceva condividere il veicolo con generi vari di frutta e verdura dalla dubbia freschezza, con galline impaurite, con l’occasionale capra dall’odore intenso. «Noi dovremmo avere un autobus speciale», si lamentava, «come quello riservato agli studenti che vivono a Fort Victoria e a Salisbury», dimenticando che quelle erano città, centri urbani autonomi, mentre la nostra casa si trovava nelle terre comunali che circondano Umtali, e che, siccome la missione di mio zio era considerata all’interno di Umtali, non c’era motivo di istituire un autobus speciale per trasportare lui e l’altro studente che viveva nella nostra zona.
E dopotutto, anche in quel caso, il viaggio di fine trimestre non sarebbe stato sufficientemente comodo per mio fratello. Il capolinea degli autobus – in corrispondenza del mercato, con le sue pallide botteghe sporche, buie e squallide all’interno, che chiamiamo magrosa, e le donne sotto gli alberi di msasa che vendono uova sode, verdure, frutta di stagione, pollo bollito che a volte viene cucinato al curry e a volte no, e qualsiasi altra cosa gli abitanti del villaggio o i viaggiatori potrebbero voler acquistare – dista almeno tre chilometri dalla nostra cascina. Anche istituendo un autobus per gli studenti della missione, mio fratello avrebbe comunque dovuto percorrere tre chilometri a piedi per arrivare a casa. Quel cammino era un altro aspetto del suo ritorno che mio fratello desiderava evitare.
Non intraprendendo quel viaggio ogni inizio e fine trimestre, io non riuscivo a capire perché mio fratello detestasse tanto camminare, soprattutto dopo essere rimasto chiuso così a lungo in un autobus senz’aria: il tragitto fino alla missione durava quasi un’ora. Oltre al sollievo di potersi sgranchire le gambe dopo un tale viaggio, il cammino verso casa dal capolinea dell’autobus non era certo troppo lungo se non avevi motivo di affrettarti ad arrivare a destinazione. La strada serpeggiava tra i campi, dove c’era sempre qualcuno con cui passare dieci minuti della tua giornata – facendo domande sulla sua salute e su quella della sua famiglia, ammirando l’abbondanza del raccolto di mais dalle ampie foglie quando era buono, prevedendo quanti sacchi avrebbe fruttato il campo o chiedendosi se le piante avevano formato i loro pennacchi troppo presto o troppo tardi. E sebbene il tratto di strada tra i campi e il capolinea fosse esposto al sole e, da settembre ad aprile, a meno che non piovesse, l’aria fosse aspra e rovente tanto che il riverbero della sabbia graffiava gli occhi, c’era sempre ombra vicino ai campi, dove venivano lasciati volutamente alcuni gruppetti di alberi sotto cui ripararsi mentre si mangiava o ci si riposava tra un lavoro e l’altro sulle strisce di terreno.
Dai campi in poi la strada si faceva più ombreggiata da arbusti e alberi. Acacie, lantane, msasa e mopani crescevano su ciascun lato. Se avevi tempo, potevi allontanarti dalla strada e inoltrarti in punti più alberati per cercare i frutti di matamba e matunduru. Dolci e aspri. Deliziosi. Da questo tratto boschivo la strada scendeva in una gola poco profonda, una valle fluviale il cui fondo era sapientemente decorato di massi lisci e piatti che costituivano un’eccitante attrezzatura per ogni genere di gioco della nostra infanzia. Attorno e al di là dei più bassi di questi massi, il fiume scorreva miseramente nella stagione secca, ma quando le piogge erano abbondanti aveva una profondità sufficiente in alcuni punti da arrivare a coprire la testa dei bambini e a inghiottire me fino ai capezzoli.