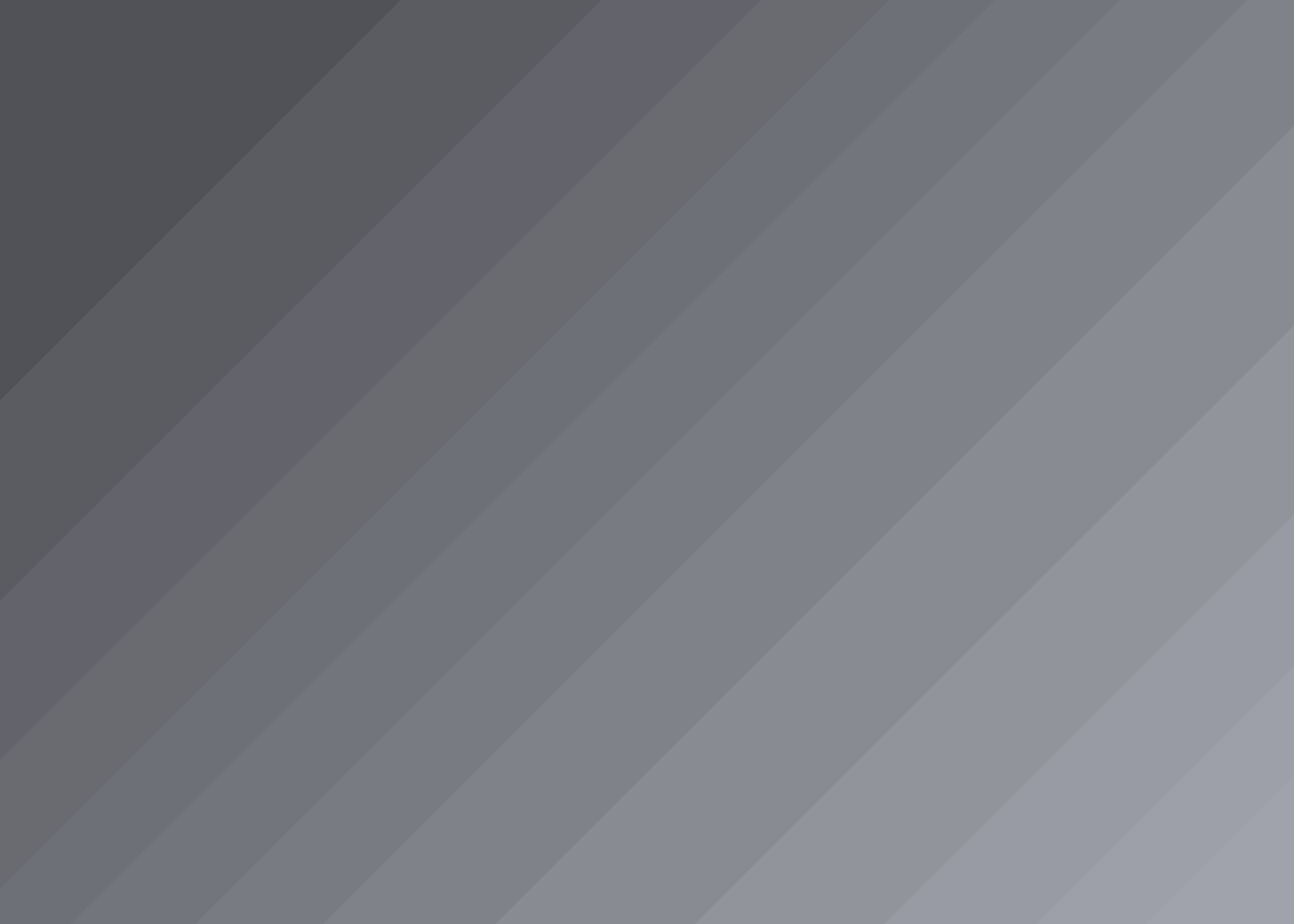La fuga dei corpi (estratto)
(Prime pagine del romanzo “La fuga dei corpi” di Andrea Gatti, pubblicato da Pidgin Edizioni nel settembre 2021. Ulteriori informazioni qui.)
Chi racconterà la tragedia dei nostri anni di pace?
–
Mi sveglio con questa domanda in testa, in questa casa che non conosco ma che qualcuno una volta deve aver abitato, perché i letti sono sfatti e le pentole ancora nel lavandino, coperte da uno strato di polvere gommosa che fa passare la voglia di mettersi a cucinare. E Daniel dorme anche adesso che il sole è entrato. Lo sento russare al di là del muro. Stanotte ha detto mangia mangia capelli, o pancia pancia cappelli, non capivo bene. Mi sono alzato in punta di piedi e sono andato nella stanza dove dormiva, rannicchiato nel sacco a pelo e con la bocca aperta, come quando si meraviglia delle cose; coi denti storti che sporgono all’infuori e quel pomo di Adamo che potrebbe usare come arma contro il mondo – e spesso lo fa, con quel suo parlare incessante, ma non se ne rende conto. Gli ho detto: Ehi? Non ha risposto. Speravo dicesse anche qualcos’altro.
–
Corriamo lungo l’Aurelia deserta, con le lacrime agli occhi e mezza faccia abbrustolita dal riflesso del sole che rimbalza sul Mediterraneo, spunta tra un palazzo e l’altro tipo strobo al naturale della discoteca-Liguria, entra con prepotenza nel camioncino dell’angelo, scompare di nuovo. Chiamiamo angelo chiunque si fermi a darci un passaggio, non importa se uomo o donna. Quello di stamattina ci ha raccolto tra Livorno e Calafuria e non ha ancora smesso di parlare. Alla fine di ogni frase batte due volte il pugno sul volante e urla Capite? Ha le dita ricoperte di anelli e un tatuaggio sul braccio destro con la scritta gypsy boy.
Daniel gli è seduto accanto e colpisce il tamburello con le nocche. Io mi sporgo sugli zaini e riesco a intravedere il punto in cui il cemento lascia spazio al verde Appennino. Poi abbasso lo sguardo e vedo Genova: un enorme formaggio arroccato tra le colline e il mare, col sole che batte sulle facciate delle case gialle e l’odore del pesce che sale dal golfo ai caruggi.
Esclamo un ovvio Siamo arrivati, con Daniel che prende a battere più forte sul tamburello e il nostro angelo quotidiano che annuisce e sussurra Casa dolce casa come se gli fosse appena passata una nuvola davanti agli occhi.
A piedi è tutt’altra cosa.
Camminiamo lungo il porto antico, tra i turisti e le carcasse dei pesci lasciate ai gatti, il fruttivendolo che rovescia una busta dentro il cassonetto strapieno, i venditori di borse che richiudono in fretta la merce nei lenzuoli bianchi alle spalle di un vigile distratto. Facciamo in tempo a mangiare un cartoccio di calamari a un banco con la serranda mezza abbassata da una signora che non sembra molto contenta di servirci. La sirena di un traghetto squarcia l’aria. Uno stormo di gabbiani si allontana. La donna ci serve dei calamari freddi, probabilmente di ieri. Daniel chiede se ci sia abbastanza sale e quella dice di no, soltanto No. Ringraziamo e le auguriamo una buonissima giornata, poi ce ne andiamo risalendo per i caruggi all’ombra, mangiando e ridendo. Sulla croce verde di una farmacia c’è scritto che fanno ventisette gradi. È il primo settembre.
Siamo in viaggio da una settimana e mi pare ancora impossibile. Daniel ha già sperimentato cosa vuol dire dormire per strada, suonare per strada, vivere mangiare giocare per strada, non passare mai due volte per lo stesso punto. I suoi occhi guizzano da un lato all’altro del paesaggio e sanno già cosa selezionare, inseguire, assorbire, abbandonare; a quali forze è bene concedersi e da quali è meglio tenersi alla larga. Dice sempre Sì. Sì a tutto. Anche ai calamari freddi. Dice che quando si viaggia non servono soldi, ma sguardo e presenza. Che la felicità è destrezza di mani e di mente. Che non dobbiamo preoccuparci, ma occuparci delle cose. Seguo la sua scia come farei con un’ambulanza a sirene spiegate che avanza nel traffico del mezzogiorno.
Un gruppetto di ragazzi dalle labbra schioccanti amigo marijuana coca speed hanno le schiene poggiate al muro su cui qualcuno ha scritto un verso della canzone di De André, quella che dice Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane / Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Le graziose se ne stanno a fumare sulle porte in tuta da ginnastica, le unghie dei tentacoli smaltate di viola. Non è così che me l’aspettavo, la Città Vecchia.
Lo dico a Daniel, che si limita a fare spallucce, sorride e riprende a camminare. Capita spesso che mi guardi e sorrida. Gli chiedo il perché e lui non risponde. Allora mi accorgo, dopo un po’, che sotto sotto lo sapevo, il perché.
Da quando siamo in viaggio non ho ancora fatto una doccia, e comunque non ho niente di pulito da mettermi. Prima di partire mi ero preoccupato tanto nello scegliere cosa portare da ritrovarmi con uno zaino di quindici chili. Daniel aveva detto è decisamente troppo, togli qualcosa. E cosa? Io per esempio non porto le mutande, aveva annunciato. Mi ero messo a ridere. Come, non porti le mutande? Assolutamente, aveva concluso con fierezza.
Era soltanto due settimane fa. Sapevo che non sarebbe stata una vacanza. Mentre buttavo tutto quel che non mi serviva, guardavo l’alone dei poster sul muro bianco – quel muro che mi ero sforzato di far sembrare mio durante gli anni dell’università – e mi chiedevo se stessi facendo la cosa giusta. Quando sono arrivato alle mutande mi sono fermato a pensare se portarle o meno. Per fare una prova, mi sono infilato i pantaloncini e sono uscito. Bologna era deserta. All’inizio mi dava fastidio che la punta del pene strusciasse contro la patta, ma poi ci ho fatto l’abitudine. Tornato a casa ho messo tutte le mutande in uno degli scatoloni che ho spedito a Roma assieme al resto della roba. Ho pensato: Non c’è nulla di cui vergognarsi. È quando si ha troppo che ci si dovrebbe vergognare, non quando si ha troppo poco.
Davanti alla vetrina di un negozio del centro trovo una banconota da cinque euro e mi fermo a raccoglierla, ma Daniel scuote la testa e continua ad avanzare con la sua andatura fluida e dinoccolata tra i turisti della domenica, il tamburello legato alla cinghia dei bermuda e lo zaino ben saldo sulle spalle, le scapole che spuntano come ali dalla canottiera.
Ci sono poche regole fra noi; una di queste è non fare la figura dei mendicanti. Regalo i soldi a un barbone e affretto il passo.
Sulla strada i motorini sciamano come insetti tra le vetture ferme al semaforo. Se non fosse per la puzza di smog si riuscirebbe ancora a sentire l’odore di pesce e formaggio che pare sprigionarsi da tutti i tombini della città. Sembra anche qualcos’altro. Sangue e sperma, secondo Daniel.
Lo osservo rallentare il passo e fiutare l’aria, avvicinarsi a una colonna, metterci una mano sopra e mormorare qualcosa a occhi chiusi. Io mi tolgo i mocassini e li poggio sul marmo freddo del porticato. Sui piedi ho delle vesciche grandi come monete. Dovrei tagliarmi le unghie.
Qui è perfetto, dice Daniel sganciando le cinghie dello zaino e posandolo nella zona d’ombra.
Mentre estraggo la chitarra, a cui manca una corda da giorni, mi riscaldo la voce con dei gorgoglii ma sento un principio di mal di gola in fondo alla laringe. C’è del sangue nella cassa armonica, piccole goccioline di sangue nero. Bevo un sorso d’acqua dalla borraccia, poi m’infilo la maschera e aspetto che Daniel finisca di tracciare il cerchio col gessetto. Nessuno deve poter entrare nel nostro campo di forze: è sacro.
Il calore dell’asfalto crea piccoli giochi di luce. Mia nonna chiamava questo momento della giornata l’ora del silenzio, quell’intervallo di tempo tra le due e le quattro in cui non bisogna far chiasso, che la gente sta riposando. In estate, nella casa al mare dei nonni, ero letteralmente terrorizzato dalla possibilità di violare quella regola. Ho imparato a camminare a piedi nudi sul selciato rovente di quel comprensorio silenzioso, accompagnato soltanto dal ronzio delle cicale e dal suono delle televisioni portate in giardino. Ho sperimentato le prime fughe sotto il sole di quell’attesa.
Fa un caldo boia con la maschera addosso, ma senza non mi sento ancora pronto. Arriva sempre il momento in cui l’idea di esser visto e riconosciuto e giudicato mi s’infila come un ragnetto nella testa; e allora semplicemente ne sono fuori, non sono più lì, hanno vinto loro: sono entrati. Mi sforzo di sembrare all’altezza delle situazioni che incontriamo. Dissimulo.
Accordo la chitarra e mi scaldo la voce. Daniel si sistema la maschera sul volto e dice: Sei pronto? Io dico: Più o meno.
Coraggio, fa lui battendo due volte sul tamburello.
Mi guardo intorno, prendo un profondo respiro e do la prima pennata.
Scusami, nonna.
È notte e costeggiamo le fabbriche dismesse, passando come fantasmi tra i piloni delle rampe sopraelevate che una volta saranno servite a qualcosa mentre adesso sembrano le zampe spezzate di un animale morente. Se non stesse per piovere sarebbe bello accamparci lassù, coi sacchi a pelo rivolti a est per poter guardare l’alba. Le uniche luci che vediamo sono quelle del prossimo paese lungo la costa e delle stelle sopra la nostra testa, oscurate da una piccola nube temporalesca. L’asfalto si sta facendo ruvido e polveroso. Il mare, oltre le rotaie e i container, si mischia con lo sfondo del cielo. È esattamente questo spazio tra una città e un’altra, tra un porto e l’altro, ciò che chiamo Dio.
Daniel sorride e dice: Ti rendi conto? M’hanno chiamato sporco negro!
Eravamo seduti sui gradini di piazzetta delle Erbe a cucinarci un piatto di riso quando tre ragazze hanno visto gli zaini, la tenda e il fornelletto e ci hanno chiesto se eravamo dei boy scout. Daniel ha detto: No, ma possiamo diventarlo. Una di loro lo ha squadrato dall’alto al basso e gli ha detto: Zitto, negro. Ho detto a Daniel: Andiamo via. Ma lui si è inginocchiato ai piedi della ragazza urlando: Mia regina, fa’ di me ciò che vuoi! Lei lo guardava inorridita. Le ragazze spostavano il peso da un piede all’altro. Daniel si è tolto la cinta e ha iniziato a frustarsi la schiena urlando: Montami mia regina, ti prego montami! Dai tavoli osservavano la scena. Un cameriere era fermo in mezzo alla piazza col vassoio in mano. Sono arrivati cinque ragazzini. Piccoli tori con l’anello al naso. Ero sicuro che stesse per mettersi male, invece Daniel ha offerto loro del riso. Quelli l’hanno preso per pazzo. Hanno incornato le ragazze e le hanno portate via, scortate verso un nuovo spumeggiante aperitivo.
È stato divertente, dice Daniel accendendosi una sigaretta.
Una volta gli avevo chiesto se l’essere chiamato negro lo ferisse. Per niente, aveva detto lui. Mi diverte. Un negro italiano è inconcepibile. Nel nostro paese i negri possono essere solo calciatori o vu cumprà. Poi, aveva aggiunto, nessuno ha davvero il potere di ferirci. Siamo noi a permettere alle persone di poggiare il dito in un punto in cui una ferita c’è già.
La pioggia comincia a battere alla periferia di un nuovo paese e dobbiamo lasciare la strada principale e risalire le colline, dove il cemento lascia spazio a un pavimento di pietre, le case si trasformano in villette e le luci si fanno più rade. Non incontriamo nessuno lungo la strada, tranne un vecchietto che ci osserva al riparo sotto una tettoia. Gli auguriamo buona serata ma quello non ci risponde. Ci guarda passare come un’allucinazione e noi scoppiamo a ridere. Daniel dice che i fantasmi possono essere visti solo da altri fantasmi.
Poco prima di un passaggio a livello vediamo una casa con il cartello VENDESI scolorito. Il cancelletto è aperto.
Daniel dice: Seguimi.
Perché non più avanti? provo a chiedere, ma lui ha già spinto il cancello ed è entrato.
C’è un cortile con un giardino dove l’erba cresce fitta. Girando intorno all’edificio mezzo crepato le scarpe s’infangano tutte. Sul retro c’è una porticina con la vernice verde, o forse rossa.
Che vuoi fare?
Voglio dare un’occhiata, fa lui come se niente fosse. Fammi luce.
Tira fuori il tensore e lo inserisce nel cilindro della serratura, poi con la forcina fa scattare i pistoni. I suoi sono gesti rapidi e precisi; a ogni scatto mi sento più colpevole. Mentre apro lo zaino alla ricerca della torcia mi costringo a non guardare le finestre che affacciano sul cortile, da cui (sono sicuro) qualcuno ci sta spiando immobile, un diavolo in vestaglia che sa chi siamo e cosa vogliamo.
Dentro, un odore acre di muffa e terra bruciata c’invade le narici. Ci facciamo strada nel buio dell’appartamento gocciolando sulle mattonelle. Io faccio tutto quel che mi dice di fare, apri qua, punta là, hai sentito? Nel corridoio passiamo davanti a uno specchio incorniciato d’oro. Daniel dice Aspetta, poi avvicina l’accendino alla superficie del vetro. Davanti a noi appaiono due strane figure.
Il più alto ha la pelle scura e i capelli ricci e spugnosi; un orecchino al lobo sinistro; indossa una canotta bianca e dei bermuda neri. Accanto, con la torcia in mano e lo sguardo che finge di non essere terrorizzato, c’è un ragazzo bianco pallido con dei baffetti appena accennati e i capelli scuri tagliati corti e spettinati. Porta una camicia di lino beige su un paio di pantaloncini verde militare.
I due animali strizzano gli occhi, poi sorridono e riprendono a camminare. I passi risuonano contro le pareti della casa. Da qualche parte gocciola dell’acqua, leggera e costante. Troviamo quella che un tempo doveva essere una sala da pranzo. Troviamo il bagno e la cucina, con le maioliche sollevate da terra e la muffa che corre lungo le pareti. In fondo al corridoio c’è una stanza con la porta socchiusa. Ci avviciniamo, quasi abbracciati l’uno all’altro, poi Daniel spinge la porta e io punto la luce all’interno della stanza.
Sul letto sta un corpo adulto, o almeno così pare, coi piedi che creano due piccole vette sotto la superficie innevata del lenzuolo. Il resto della stanza è un caos di vestiti, scatoloni, cianfrusaglie; sembra che qualcuno si sia fermato nel bel mezzo di un trasloco o una rapina e sia scappato in preda alle lacrime, lasciando il morto steso lì.
Va’ a vedere, dice Daniel.
Mi avvicino. Con cautela, pinzo il lenzuolo e lo tiro via.
Giocattoli. Attrezzi da lavoro. Un Super Santos.
Anche al buio riesco a vedere il sorriso allargarsi sul volto di Daniel, che poi emette un sospiro e se ne corre al bagno. Lo sento spalancare le imposte e frugare nello zaino alla ricerca di qualcosa, aprire il rubinetto e spazzolarsi i denti con cura, quei denti grandi come blocchi di marmo, mentre ride a crepapelle con l’acqua che scroscia.
Nel salotto trovo alcune candele. Mi assicuro che la serranda sia abbassata prima di sparpagliarle per la sala e accenderle. Fanno un buon profumo. Appare un televisore (a tubo catodico, con manopola) e una vecchia radio. I servizi da tavola sono riposti in una dispensa a vetri. Ci sono oggetti di un altro mondo, pile di giornali di quando non eravamo nati. Una caramella Herla se ne sta lì sul tavolino, tutta sola. La scarto cercando di non far rumore. Sa di menta fresca.
Mi sdraio a fumare su un materasso che evito accuratamente di guardare. La pioggia ticchetta contro le finestre. Nessuno può vederci. Siamo noi quelli che vedono. Ieri notte Daniel ha detto che agiamo come zecche. Le zecche si arrampicano sugli alberi e aspettano; non vedono, ma sentono il calore del sangue. Si lasciano cadere su un corpo e, se lo centrano, si attaccano. Succhiano. Poi depongono le uova. E muoiono. Se non trovano un corpo, allora, si arrampicano di nuovo sull’albero, e così via. Daniel parla sempre come se fosse implicito il significato di quel che vuole io comprenda; dà per scontato che io capisca. Parla una lingua esoterica. A volte vorrei aprire la sua testa con un bisturi e guardarci dentro. Gli manca mai casa sua?
Un fragore di pentole all’altro lato della casa mi fa sussultare. Grido: Tutto bene? Sì, risponde Daniel. Sono scivolato. Guardo le fiammelle ardere sulle candele. Anche stanotte non riuscirò a prendere sonno.
Mi raggiunge poco dopo con un grosso cilindro di stoffa blu e lo butta ai piedi del materasso.
Cos’è?
Una casa. Una bella casa portatile.
Mi sporgo a vedere meglio e dico: Non capisco.
È una tenda, Vanni. Gli assi, la cerata e i picchetti sono intatti.
Possiamo prenderla?
Certo, dice lui. Dobbiamo.
Ha anche trovato una bottiglia di amaro e la sta versando in due bicchieri di cristallo. Come diavolo faccia a essere sempre così, Daniel, sempre così irriducibilmente Daniel, io non lo so.
Restiamo in silenzio ad ascoltare la pioggia, riempiendoci i bicchieri di tanto in tanto.
È il migliore dei mondi possibili, dice a un certo punto, e la sua voce ha la tipica inflessione di quando è brillo, con le parole trascinate languidamente in avanti come un corso d’acqua che incontra un sasso: la sua r moscia di Romagna antica.
Sta arrivando l’autunno, dico, ma suona come una cosa triste e mi pento subito d’averla detta.
E lui: Passami la mappa.
Apriamo la cartina sul tavolo e seguo l’indice di Daniel mentre ripercorre la strada: l’Aurelia fino a Ventimiglia, dove diventa la Provençale e infine l’Autostrada dei Due Mari; poi la Catalane che si trasforma in Autopista del Mediterráneo e prosegue per tutta la costa fino allo stretto di Gibilterra.
L’Italia sembra un cazzetto penzolante fra le cosce dell’Europa, dice lui, e la cosa mi fa ridere così tanto che a momenti mi strozzo con l’amaro. Poi poggia il dito in fondo alla Spagna e dice: È qui.
Mi sporgo oltre la sua spalla ma vedo solo deserto.
Parco naturale del Cabo de Gata?
Esatto, fa lui. Cala Bruja è qui intorno.
E come la troviamo?
Richiude la mappa e dice: Sarà lei a trovarci.
Sorride, solleva il bicchiere e lo butta giù d’un fiato. Poi si alza ed esce dalla stanza. Lo osservo scomparire nell’oscurità del corridoio. Dovrei seguirlo fisicamente?
Poco dopo riappare con un pentolone e lo poggia a terra. Afferra mappa e candela, poi si siede davanti al pentolone a gambe incrociate e mi fa: Avvicinati.
Il suo volto adesso è tutto rosso. Mi inginocchio accanto a lui.
Poggia il bicchiere, dice. Non c’è più nulla là dentro.
Eseguo; raddrizzo la schiena e mi accorgo del suo sguardo, ancora fisso su di me.
Le cose non sono le cose, dice. Sono altari, cupole, colonne, templi. E noi – solleva la candela – noi dobbiamo dire la messa.
Avvicina la fiamma a un angolo della mappa, e in una vampata l’Europa comincia ad ardere e sfilacciarsi e volare per tutta la stanza come tanti coriandoli impazziti, con la luce che illumina le pareti di questa casa abbandonata che adesso ha l’energia di una bolla di elettricità, di un vulcano in eruzione.
Quando il fuoco si spegne, Daniel apre la finestra per far uscire il fumo. L’aria umida della sera mi rinfresca le braccia.
Ti va di suonare?
Potrebbero sentirci, dico.
Piano piano, fa lui. A volume basso.
Così acconsento a tirar fuori la chitarra dalla custodia e Daniel, che so già cosa mi sta per chiedere, tossisce un paio di volte nel pugno chiuso e dice: Fuga all’inglese. Ti va?
Partire è più coraggioso di restare.
Mi aggiro per la casa studiandone gli infissi, ascoltando le gocce ritardatarie della pioggia cadere in qualche anfratto di là del muro.
Qui un tempo ci abitava qualcuno. Qui ci mangiava, ci faceva l’amore, ci piangeva qualcuno; adesso ci siamo noi che calpestiamo i morti, che camminiamo sulle rovine. Qui c’era qualcuno che adesso non c’è più: ha preso la porta, ci ha poggiato la mano sopra e l’ha aperta, si è fermato, ha guardato dentro un’ultima volta, poi ha chiuso la porta e se n’è andato per sempre, lasciando tutto così com’è.
Dopo essermi sciacquato la fronte al lavandino sbeccato del bagno, con la torcia poggiata di traverso su una mensola, torno in salotto e cado come un sacco di patate sul divano. Mi stiracchio, mi rannicchio, faccio il morto che annaspa. È il mio modo di prendere confidenza con lo spazio. Qualcosa mi fa il solletico. Scopro dei piccoli complessi di fuliggine attaccate alle piante dei piedi come nuvole. Con un gesto li faccio cadere. Rido, mi gratto. Mollo una scorreggia. Un filamento di ragnatela ondeggia perpendicolare dal soffitto. Sembra uno spermatozoo dondolante nel liquido spermatico della stanza.
Daniel?
Ha smesso di russare. Lo spazio assorbe l’eco della mia domanda.
Mi sfilo i pantaloncini e mi copro con un cuscino.
Buonanotte, mi dico.
Prendo sonno ma non so se mi addormento.
Una volta mia madre mi ha detto: Se esci da quella porta non rientri più.
L’ho presa alla lettera.
Andrea Gatti è nato a Roma nel 1992 e attualmente vive a Bologna. È laureato in cinema e specializzato in tecniche della narrazione. Suoi racconti sono apparsi su La Stampa, retabloid, Tuffi Rivista, Narrandom e nell’antologia “L’ultimo sesso al tempo della peste” (NEO. Edizioni), curata da Filippo Tuena. “La fuga dei corpi” è il suo primo romanzo, pubblicato da Pidgin Edizioni nel settembre 2021. Per leggere ulteriori informazioni o per acquistare il libro, fai clic qui.