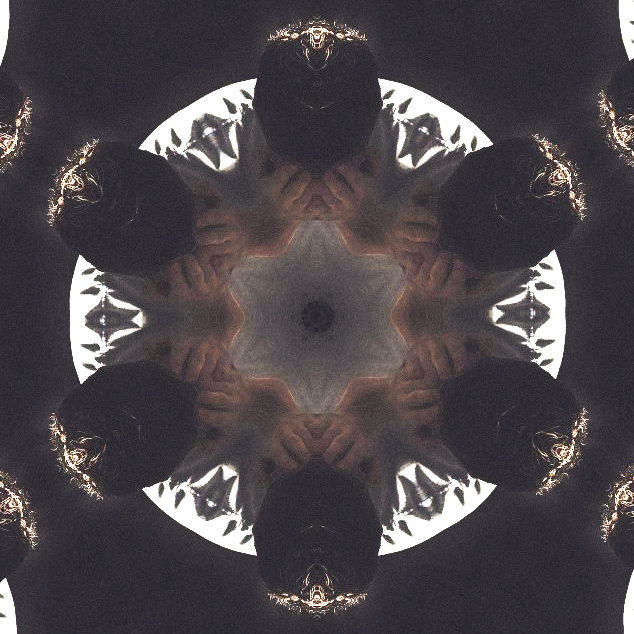L’ultimo rave
Siamo nel nuovo anno da circa un’ora e non è cambiato nulla.
Un gatto inseguito dai cani di un teknoraver si fionda sotto una macchina smantellata che si regge sui cerchioni; non riescono a raggiungerlo, quel rifugio è troppo stretto per loro, con i musi non arrivano neanche a sfiorarlo, ma non demordono e quello gli soffia contro. Io e lei invece ci tuffiamo tra migliaia di altri che tentano di entrare in un capannone industriale per festeggiare non si sa cosa. Mi guardo attorno e mi sento braccato, come quel gatto; lei mi sorride per rasserenarmi. Tutti insieme, noi e questa folla, sembriamo un corpo amorfo che cerca di ritornare nell’utero materno, che spinge e urla e addenta l’aria.
Varcare il primo cancello ha messo a repentaglio la mia esigua tolleranza. La bolgia è insopportabile, persino a Bologna che è sempre giovane. Il secondo ostacolo è più semplice da superare, basta pagare, e già che ci siamo compriamo tre pasticche da un tipo con gli occhi interstellari e la mandibola danzante. Dobbiamo divertirci, per forza.
Il rave è una testa che imbarca acqua. La testa affonda e s’immerge in un’altra dimensione. Il sapore della notte rende insolite tutte le cose e lo smarrimento esistenziale ti abbandona se sai gestire lucidità e squilibrio. Ci avviciniamo alla musica che ha mani assassine, inoltrandoci in un fabbricato ricoperto di ribellione transitoria, giochi di fuoco, bottiglie rotte, cicche spremute, stagnole annerite, chiazze di vomito, rigagnoli di urina e gente accasciata al suolo.
Prendiamo mezza pasticca a testa. Entriamo nel capannone a gomitate e spintoni, così o niente. Raggiungiamo il bancone. Beviamo birra schifosa. La drum’n’bass fa ballare tutti con tuoni ritmati e ripetitivi, un fricchettone sviene faccia in giù, due cani si accoppiano tra le risate degli spettatori, degli hipster fingono una lite e poi confrontano i vestiti, sobri intrusi attentano alle tasche e alle borse di continuo, superbe coltri di fumo fuoriescono da bocche simili a comignoli.
M’innervosisco. Ruoto attorno a lei per proteggerla da urti, approcci e tentativi di furti. La pasticca non sale, non fa effetto, ci sentiamo dei bambocci che si sono fatti fregare al primo rave. Lei vuole fregarsene e non rovinarsi la festa. Mi trascina più vicino possibile alle casse e balla. Io provo a darle ragione, provo anch’io a fregarmene. Comincio a ballare, fumando erba, ma finisco la birra.
«Tranquillo, vai a prenderle,» dice.
La assecondo, ma ormai sono incazzato. Tutto questo non mi diverte più.
Torno con due birre. Lei è sfrenata e sa muoversi. Guardarla ballare mi fa pensare al fare l’amore.
«Caliamoci anche le altre. Forse sono leggere ma qualcosa ci faranno,» dice.
«Ok,» dico.
Quant’è bella e gioiosa, forse è il mio antidoto alla depressione. Ci scoliamo le birre ballando, sudando e sorridendo. Un tizio senza volto ci passa una canna per generosità festaiola. Facciamo una serie di boccate, aspirando avidamente; la dimezziamo e restituiamo il dono. Mi avvicino a lei e la bacio come se fosse la prima volta. Per l’emozione sento la forza di gravità incidere su di me in modo differente e il mio corpo diventa leggero.
Poi di schianto sale tutto insieme, una pasticca e mezza a testa di non si sa cosa. La droga s’impossessa di noi. Tutto cambia e addio autocontrollo. Ce lo diciamo con gli occhi ed è l’ultima comunicazione reale.
Attriti. Collisioni. Sfregamenti. Bastarsi. Isolarsi. Perdersi. Sudare. Vibrare. Fregarsene. Dimenarsi. Sdoppiarsi. Estraniarsi. Occhi enormi. Mani rotanti. Baci infiniti. Pulsazioni frenetiche. Sigarette insufficienti. Proiettare visioni. Rendersi innocui. Incastrarsi ovunque. Distrarsi continuamente. Diluire la ressa. Sotto le casse. Ore come minuti. Lingue a forbice. Sapore di rancido. Scintille di catarsi. Fasi di inespressività. Affannarsi nel polverone. Ubriacarsi di adrenalina. Salti e spallate. Liquidi e rabbia. Tachicardia e iperattività. Seppellire ogni patema. Aspirare a più non posso. Il cuore in bocca. Risate felici per nulla. Passive espressioni d’estasi. Lasciarsi trasportare dai bassi. Accendini fanno il loro. Ricordi svaniscono nel nulla. Succhi gastrici in bella vista. Strisce rapide che bruciano naso e gola. Annientare il peso di quello che c’è fuori da qui.
Restare fermo è impossibile, le gambe mi scuotono senza sosta. Mi strofino su tutte le morbidezze che mi stanno attorno e ogni tanto grido qualche parola sbilenca. Subisco con piacere quest’euforia, più forte che mai, sono privo di equilibrio ma seguire il ritmo è conservazione.
Un paio di grosse tette mi propongono di sniffare qualcosa che non capisco, io accetto anche se non so cos’altro posso assumere in una sola notte senza morire. Mi avvio ma qualcosa mi afferra una mano, trattenendomi. È lei.
«Non mi sento bene, voglio respirare all’aria aperta,» dice.
Usciamo come in uno sfondamento del fronte nemico. Abbassare la temperatura corporea è una buona idea, anche per me.
«Scusa per gli approcci, non controllo le mie azioni,» dico.
«Non c’è problema, questo non sei tu,» dice.
Ci sediamo per terra. Abbiamo sensazioni altalenanti, siamo eccitati e rallentati, abbiamo freddo e caldo. Le pasticche erano troppo forti, ci hanno soltanto messo più tempo del solito a fare effetto, e quella che credevamo fosse una canna non era erba né fumo, ma altro che non conosciamo. Le due sostanze dagli effetti in contrasto ci stanno spaccando il cervello in due. Beviamo acqua e mastichiamo chewingum.
«Il tuo volto è la Guernica di Picasso, le tue braccia distese sull’asfalto sono le rotaie di un binario morto, il tuo sguardo è la lama di una ghigliottina e il sudore che ti cola dalla fronte è veleno, ma non mi spaventi. Il buio è soltanto ciò che non possiamo vedere, nient’altro,» dice.
Stiamo male. Non riusciamo a muoverci né a stare fermi, ma io sono ridotto peggio; lei ha più esperienza di me in questo campo. Davanti a noi c’è un autobus abbandonato, invaso da gente senza faccia. Lo vedo come la prima goccia d’acqua che tocca terra all’inizio di un temporale, come una lacrima d’orgoglio versata per un figlio, come la sua gonna il giorno in cui l’ho conosciuta, come un pugnale che affonda nella carne del peggior nemico, come il collo di una vergine per un vampiro, come la luna per un licantropo, come un elefante per un bracconiere, come una casa vuota per un ladro, come un buco di eroina per un tossico, come l’Oceano Atlantico per un navigatore, come l’ingresso del toro nell’arena, come unghie che graffiano le spalle nel sesso, come la resurrezione, come uno sparo. Ogni pensiero esplode moltiplicandosi.
Penso a una velocità che mi spaventa. Enormi masse d’acqua si affacciano ai miei occhi ma è soltanto un drink versato per sbaglio. Temo di impazzire. Agogno semplicità ma il delirio è ovunque. Sono tutti fatti.
«Devo rientrare, ho bisogno di ballare,» dice.
«No,» dico. E le agito un pugno chiuso davanti alla faccia.
Lei si tira indietro di scatto. Le trasmetto odio, ma dura un attimo, poi mi colpisco la gamba. Vorrei scusarmi ma mi sembra di averlo già fatto. Temo di poter compiere azioni orribili, non posso più stare lì, non mi fido di me stesso.
L’alba sembra in enorme anticipo rispetto ai giorni precedenti ma non è così. Vedo orizzonti di follia davanti a me. Oltre quelli ci sono io che guardo orizzonti di follia. E così all’infinito.
«Non dovevi innervosirti mentre ti saliva la botta. Tu non sei così aggressivo. Fidati di me,» dice.
Lo so, ma questo non riesce ad aiutarmi. Il tono della sua voce è compromesso dalle droghe chimiche e mi agita ancora di più, anche se mi accarezza per calmarmi. Ho una richiesta di salvezza in gola, un grande gesto di determinazione, tento di sputarla fuori.
«Chiama un’ambulanza. Il mio cervello è fottuto ormai, credo di poter degenerare,» dico.
Sono soddisfatto di esserci riuscito. Nessuno però mi fa i complimenti, neanche lei. So che non la ritiene una buona idea ma io non posso più reggere questi sbalzi fisici e psichici, la mia sopportazione è demolita.
Mi accontenta contro le sue necessità, mi trascina fuori e attendiamo sul marciapiede.
Ho bisogno di parlare mentre cammino avanti e indietro, svelto e compulsivo.
«Sembrano frecce stilizzate queste macchine velocissime. Dove vanno tutti? Mi dà la nausea il loro invincibile bisogno di stabilità. Questo riguarda anche me? La concretezza mi ripugna e non ho mai cercato conferme negli altri, lo sai, e mi ripugna l’obbligo di guadagnare denaro per vivere, ma elemosinarlo mi ripugna ancora di più, quindi che alternativa ho?» dico.
Lei interviene soltanto a monosillabi. O forse smascella e basta. Non lo so.
Ambulanza e breve tragitto, o così mi sembra. Non capisco niente di quello che viene detto, tutto è distorto e sfocato. Lei mi tiene le mani che non smettono di tremare.
In ospedale la corsia è spaventosa, sembra restringersi e allungarsi a fasi alternate. Lei non può scaricare l’energia in eccesso e peggiora, ma sa gestirsi, sopporta. Per starmi accanto sta facendo un sacrificio che mi commuove ma non verso una lacrima; cerco di spiegarle cosa provo ma non ci riesco.
Vedo una siringa entrare nel mio braccio quando non vedevo più niente da un po’ e faccio un salto sulla sedia, ma mi tengono in tre. Lei racconta a un medico quello che abbiamo preso.
Sono di nuovo in corsia. Anche lei. Siamo instabili.
«Non ti hanno fatto nessuna iniezione, hai solo bevuto un calmante. Mi hanno trattata come una tossica di merda,» dice.
Ora non so concepire un senso di colpa, lo farò quando ne sarò in grado. Sono un impedito che strapensa e straparla. Ho un flusso ingestibile di riflessioni che mi scappa via dalla bocca.
«Sognare è lecito ma illudersi è rovinarsi. Sembra che l’uomo abbia bisogno di farsi del male, di inventarlo questo male che si infligge, ma il male esiste perché esiste il bene, la cattiveria esiste perché esiste la bontà, il dolore esiste perché esiste il piacere. La ricerca della giustizia assoluta è utopica, si può soltanto cercare un equilibrio tra gli estremi, non una soluzione buonista da lieto fine per bambini paurosi. Per questo è stupido desiderare qualcosa che non rientra nella propria essenza psicofisica. Siamo vacche che sognano le ali, comunque non potremmo volare a causa della corporatura,» dico.
Lei non ascolta, non può concentrarsi sui miei deliri. Forse potrebbe volare anche se fosse una vacca. Ma non è una vacca. Pesa cinquanta chili, è generosa e gentile. Allora le chiedo di trovarmi un interlocutore sano mentalmente. Lei ci prova, si sposta da una persona all’altra nel reparto, e ritorna accanto a me, dopo quegli inutili tentativi. Nessuno vuole ascoltarmi.
Poi arriva il crollo fisico, che mi risparmia un’altra pioggia di pensieri incontrollabili. La mia stanchezza neuronale è categorica, l’imperativo è ricaricarsi.
Quando mi riprendo siamo a casa, ma non so come ci siamo arrivati. La mia mente non ha prodotto neanche un sogno, né tantomeno un incubo. Si è spenta e basta.
L’effetto dura da sei giorni. Soffro di claustrofobia anche nei supermercati. Non riesco a eseguire azioni che richiedono gesti misurati. Lei mi allaccia le scarpe, mi versa l’acqua nel bicchiere, inserisce i miei bottoni nelle asole, mi legge le favole di Rodari per farmi addormentare. Se fumo una sigaretta la testa ritorna al rave, con tutte le sensazioni annesse.
«Mai più… Non voglio rischiare di friggermi la corteccia cerebrale mai più,» dico.
Ma non mi crede. Sorride e mi abbraccia. E fa bene, sono ancora illogico.
Marco Corvaia è nato a Palermo nel 1980. È autore del libro di narrativa Pino se lo aspettava – Il racconto della vita e della morte di padre Puglisi e della raccolta poetica Post Somnium. Numerosi suoi testi (poesie e racconti brevi) sono stati pubblicati in antologie, lit-blog e riviste culturali. Si occupa anche di fumetto, fotografia e videoarte.