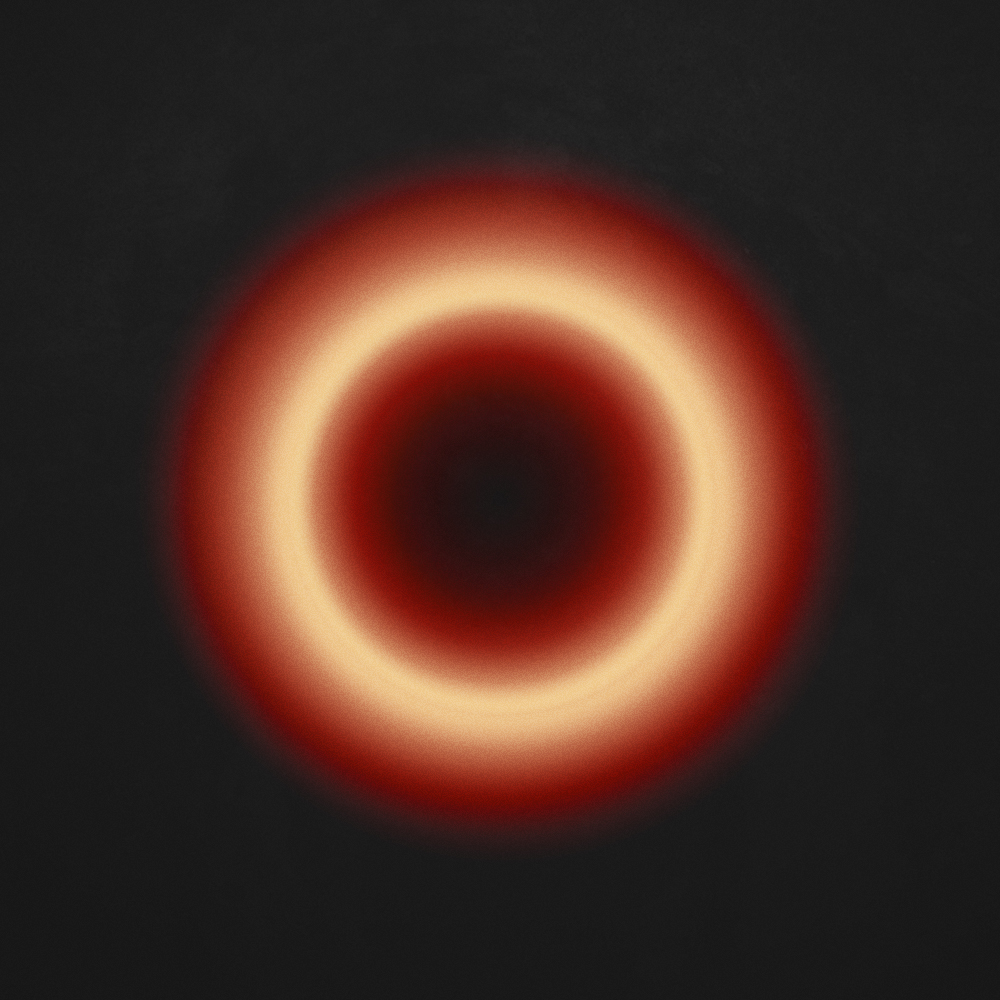Buchi neri
Me ne stavo da solo perché ero un uomo indebolito, un affare grosso m’aveva scosso e dilaniato. Un bel problema coi fiocchi!
La mia ragazza m’aveva tradito, lasciato.
Ero contuso d’amore, a brandelli… la barba di tre giorni, ascelle bagnate, un bicchiere in mano. Tu eri lì, di passaggio, per strada, a brandelli quanto me, anche tu tradita e debole. E quindi ci siamo trovati e assemblati. Io ti pagavo da bere e tu mi offrivi sigarette, sembrava una buona tattica per non soccombere.
Abbiamo messo d’accordo i nostri buchi neri e fatto combaciare ciò che non andava, come un puzzle. Ma erano pezzi che altri c’avevano portato via, non eravamo fatti per amarci. È triste dirlo adesso, lo era anche all’ora. Non lo volevamo ammettere. Quello che ci saremmo fatti, alla fine, sarebbe stato più crudele, ancora più abietto.
Brutta bestia la solitudine! L’abbiamo combattuta credendo che, insieme, sarebbe stato meglio. I nostri organi a disposizione dell’altro, quello cardiaco batteva solo per restare in vita però.
Eravamo strafatti di tocchi, ci consumavamo la pelle a furia di scambiarci. Lacci i nostri corpi in riproduzioni masochistiche e scabrose. Tu mi abbassavi le mutande e graffiavi la schiena, volevi afferrare un tozzo di tessuto, un feticcio da bruciare per salvarti e invocare perdono, o martirio magari. Io mettevo mani dappertutto, non potevo perdermi nemmeno un minuzzolo di carne – racchiuse in te ci sarebbero state tutte le donne che non avrei mai avuto. Esigevo rispetto e tu no, e me lo masticavo approfittandomene; abbassavi la guardia e ti mortificavo. Ingannavo me stesso, soprattutto, e tu uguale.
Ci pareva il modo migliore per dimenticare. Era misericordia, mi sa.
Nei tuoi occhi mi vedevo distrutto, assopito e arso da una smania che mi era stata estirpata. Tentavo il colpo di reni ma ero sempre in terra, sfatto o mostruosamente pietoso. E tu eri una donna problematica alle mie pupille, il più delle volte piangevi, ed erano lacrime anche i miei occhi. Cercavamo di farci forza e metterci su alla meglio. Sembravamo un tavolino azzoppato, quando addrizzavamo un piede l’altro crollava.
Io ero un buon giravite per sistemare pensieri ossidati. Trattenevo le crisi di livore che ti comandavano di strapparti ciocche di capelli o i deliri alcolici che traghettavano sempre le tue caviglie in espatri sentimentali. Volevi fuggire via, morire sulle rotaie di un treno. Leggevi Rimbaud.
Avevamo solo una cosa in comune. Ad abbandonarci erano state due donne.
La tua era una signora fatta, sui quarant’anni, il doppio dei miei e dei tuoi anche. Tu l’amavi, ma eri acerba, troppo cruda per colmare un vuoto. Ti piaceva il suo modo di lavare i piatti, le canzoni che ascoltava alla radio e il sapore della sua fica. Ma la verità era che volevi una madre migliore della tua, a tutti i costi. Andare con le donne la mandava in bestia – t’aveva pure cacciato di casa –, e per dispetto t’eri attaccata alla signora dai guanti gialli, con Lucio Battisti che usciva dalle finestre. Per uccidere tua madre ci andavi a letto.
La mia era una clessidra di carne, una ragazza dalle labbra morbide con un appetito sessuale profondo quanto la sua gola e due castagne per occhi che mi pungevano quando ci fissavamo. Mi sarei immolato per lei, ed ero stato accontentato.
M’ero giocato ogni cosa pur d’averla, mandato al diavolo lavoro e amici. Poi lei aveva mandato al diavolo me e io ero rimasto col naso schiacciato sul cuscino a cercare l’odore dei suoi capelli. Che bestia la solitudine!
Sei venuta a stare da me. Solo così potevamo frenare i miei attacchi di panico e le grida in piena notte, o le tue manie evasive e gli impulsi suicidi. Ti scrostavi lo smalto con le unghie facendoti scattare le pellicine a sangue, io davo baci alle tue stranezze per calmarti, ma non erano baci d’amore, erano morsi.
Per curare i traumi ci picchiavo sopra. Ecchimosi sulle cosce, schiaffi sui glutei, bruciature di sigaretta ai polsi. Non sapevo più come spaccarti, tu ne volevi ancora. Allora t’ho sbattuta sul letto e montata da dietro, tirando dritto senza pensare; il dolore ti lacerava le carni. Troppo presto ti abituasti al sadismo, la sodomia divenne letizia per te.
Ti dovevi punire, esigevi castigo e botte, una correzione morale. Ce l’avevi dentro, un coagulo di bambina in un angolo a epurare. Dovevi cadere in fallo, tu cascavi e io ce lo mettevo.
Troppo comodo per me. Il mio compito era impartire ordini, raffazzonare la superbia che s’era divelta. Il maschio virile straripava dalla mia lingua sporca di gin e bestemmie ch’era tramutatasi in uno scudiscio collerico.
Ero un uomo affamato di orgoglio perché l’avevo vomitato tutto. Legarti al letto e servirmi della tua carcassa era un lavacro; convinto di sfangarla e di reprimere il dolore ti strangolavo e ti tiravo i capelli e mi sentivo rinfrancato. Irradiavo disperazione e risentimento dentro di te in modo che li sgravassi, così da proiettarli, gettandoli in faccia alla mia aguzzina, alla donna che m’aveva spezzato.
Uno spillo il mio pene conficcato nelle tue membra come monito. Autolesionismo di seconda mano.
Poi ti inginocchiavi al mio cospetto, e io ieraticamente schizzavo nelle tue fauci. Più che dare da bere agli assetati volevo annegarli – che soffocassero tutti, così che loro penassero pure, tanto quanto noi soffrivamo. E tu gioivi a dissetarti, nel sorbire un liquido che nessuna donna avrebbe mai potuto distillare.
Salimmo sul Golgota ognuno per la propria pace, tu chiodo e io martello. Affare fatto!
Bulimici di sentimenti ci rimpinzavamo di quel sesso spasmodico, senza grazia, solo perché si doveva. E gettavamo tutto nel cesso delle nostre parole, nei requiem diluiti dalla sambuca. Cadaveri che si scavavano la fossa.
Io recitavo Céline e fumavo ai piedi del letto buttando la cenere nel tuo ombelico mentre mi sputavi addosso e rimangiavi tutto.
Passammo così settimane intere. Infilavi marshmallow tra le cosce e io li pescavo senza l’uso delle mani. Mettevi ghiaccio nel bicchiere e ci versavi dentro gin, lo bevevi e poi mi baciavi, lasciandolo colare dentro la mia gola. Ci avvelenammo.
Il pomeriggio dedicavo un paio d’ore alle mie poesie e tu leggevi ciò che avevi scritto la notte. Lì ti volevo bene sul serio, nelle tue tristi e circolari parole, quasi sempre le stesse. Il modo migliore per usare quelle mani.
Andavamo a ballare, a bere fino a stramazzare in terra, culo all’aria e tutto. Ti esibivo in giro, una mostrina alla mia tracotanza, una spilla appesa per rattoppare la ferita purulenta, e tu mi lasciavi fare. Ti piaceva che ti lustrassi, assecondando la fame di vanità e accidia che ti ingrassava. I tuoi peccati prediletti.
Poteva durare un giorno ma anche tutta la vita. E poi ci siamo scoperti ipocriti e meschini quando le mestruazioni ti tardarono, io mi versavo da bere senza riuscire a ubriacarmi e tu imprecavi e il sangue ti scoppiava solamente nei capillari. Avevamo le facce come pomodori.
Ti diedi della lurida sgualdrina, mandandoti al diavolo. Quella sera finalmente le sentisti una per una le sberle! Ero un pervertito, dicesti, un macellaio opportunista che t’aveva stuprato. I nostri occhi divennero specchi che non riuscivamo a guardare.
Per due giorni mangiammo e fumammo chiusi nella stessa stanza senza fare un cenno o dirci una parola. Pregavamo in silenzio perché eravamo due vigliacchi.
Non credo di essere stato tanto felice quanto quella mattina in bagno. Un rivolo scarlatto ti precedeva sul pavimento, eri seduta sulla tazza con le gambe divaricate e il sangue ti scolava dalle cosce; pareva una candela squagliata. Ci baciammo recuperando i giorni di magra e saltammo di gioia tra il gabinetto e il lavello. Non aspettammo oltre.
Quando ti sono entrato dentro hai serrato gli occhi, ma non era vergogna e neanche pudore. Stavamo mettendoci una pietra sopra, chiudendo per l’eternità.
La tua testa sul bianco smaltato della vasca, io sopra che spingevo, ma più che mettere svuotavo. Davo colpi sicuri, lenti e profondi, la voce ti si strozzava in gola. Quando l’ho tirato fuori era un Calippo all’amarena. L’ultimo scampolo di carne da sacrificare, la coltellata finale, il colpo di grazia. Tu hai girato la manopola e l’acqua ha preso a venirci addosso, in un battibaleno eravamo fradici, le lacrime si camuffavano tra gli schizzi, un piccolo fiume rosa turbinava giù per lo scarico assieme a grumi di sperma.
Ricordo che fui io a infilare la tua roba nello zaino, tu accendesti due sigarette e ne posasti una tra le mie labbra. Sull’uscio attesi un ultimo bacio che non arrivò mai.
Dovevi andare via. Tu eri di passaggio.
Varcasti l’androne e i tuoi occhi mi presero in pieno. Eravamo a pezzi quando ci incontrammo e adesso in frantumi. Sarebbe potuto essere amore ma fu omicidio.
Io, un altro bastardo da svilire, tu una puttana senza remissione.
Spero che ogni tanto scrivi di me con quelle mani. Io, come vedi, lo faccio ancora.
Giuseppe Midolo nasce il ventuno Dicembre del millenovecentonovantadue a Siracusa. Chef di professione, appassionato lettore, scrittore e pittore nella vita. Ha sempre scritto, alla tenera età di otto anni scriveva fiabe per addormentarsi. Torna a dedicarsi alla narrativa a sedici anni; ad oggi si contano più di quattrocento poesie, un paio di racconti e un libro pubblicato. Giuseppe Midolo infatti debutta ufficialmente nel mondo della scrittura nell’ottobre duemilatredici con il suo primo romanzo “Il frottivendolo”. Dopo la stesura di altri due romanzi, non ancora pubblicati, non ha smesso di dedicarsi alla narrativa e attualmente sta lavorando alla sua quinta opera.