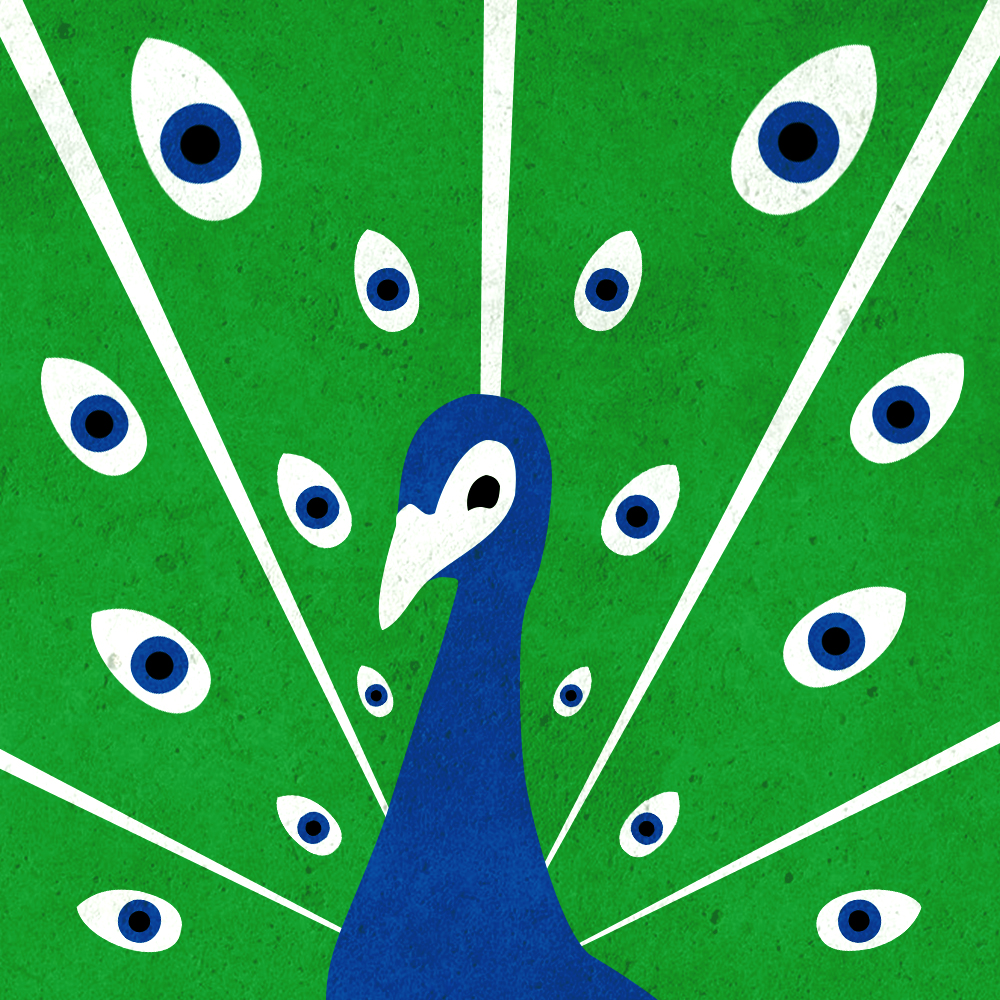Complemorte
La prima volta che ho incontrato la parola Complemorte mi ha affascinato per motivi non così diversi da quelli che mi hanno poi spinto a sceglierla come termine per descrivere un giorno dell’anno 2009 che ha segnato la mia vita in un prima e un dopo. Una cesura, un lutto, ma anche la volontà di celebrare un avvenimento che è parte integrante della mia esistenza ed esperienza di vita.
Un agosto di undici anni fa mi sono svegliata con metà del volto paralizzato. Paralisi di Bell. Faccio fatica a parlarne seriamente, perché ci ho scherzato su per troppo tempo e perché la narrazione che ho impostato riguardo questo evento è stata per molti anni plasmata dalla retorica della persona forte, coraggiosa, che si accetta così com’è. Quando sono finalmente andata in terapia, mi sono concentrata durante le sedute di EMDR su una frase che avevo detto a un’amica quando, il primo giorno di scuola, vide cosa mi era successo al volto: “Ho ancora l’altra metà della faccia per sorridere!”
Per anni ho portato i capelli con la riga di lato per far sì che la parte morta del mio viso e della mia persona fosse la prima cosa che il mondo vedesse. Mi presentavo al mio “peggio”, convinta che sbandierare la mia non conformità sarebbe stato il modo giusto per testare il reale interesse nei miei confronti di chi mi stava attorno o di chi mi stava conoscendo. Se spaventavo, se facevo orrore, se non risultavo attraente, tanto di guadagnato: mi era già difficile considerarmi come una persona meritevole di affetto, attenzioni, amicizia, stima, non volevo anche la pietà. Con il tempo è diventata solo abitudine, perché di tutte le persone che erano con me prima, adesso non me ne sono rimaste che un pugno che nemmeno ricorda com’ero. Chi entra ora nella mia vita spesso nemmeno ci fa caso, ma per anni ho ripetuto ossessivamente quella frase, che potevo essere felice così com’ero e che dovevo sfruttare ciò che mi era rimasto. Ed è vero, metà di me morì ma non morii io. Non ho mai voluto morire e non mi sarei lasciata fermare dal mio sistema nervoso.
Non conoscevo nulla del movimento body positive, figuriamoci dell’abilismo, e comunque quando li ho incontrati ho sempre pensato che la linea di pensiero che portavano avanti mi riguardasse solo in quanto persona sovrappeso che doveva avere a che fare anche con il fatto di non essere completamente in salute a causa di un ginocchio rotto.
Non ho mai pensato veramente al mio viso finché due mesi fa non è successo di nuovo. Mi sono svegliata mezza morta. Dal lato che era rimasto sano la prima volta. Mi sono svegliata mezza morta, durante una pandemia.
Il mio primo istinto continua a essere quello di riderne.
È la perfetta ironia, è successo anche quasi lo stesso giorno della prima paralisi, è un parallelismo e un rovesciamento al tempo stesso, li vedete gli sceneggiatori che ridono? E parlo volontariamente al maschile perché ogni volta che ci penso immagino gli sceneggiatori di Boris sulla barca.
Non sarebbe divertente se dopo aver finalmente fatto pace con questo trauma, mentre si stanno anche allentando le misure di sicurezza — ma non così tanto da aver permesso al sistema sanitario nazionale di funzionare di nuovo tranquillamente —, mentre sta cercando di fare pace con altri pezzi del suo corpo con cui ha un rapporto tremendo, ecco sì non sarebbe così divertente se questa qui si svegliasse di nuovo mezza morta? Ma dall’altro lato, così quando si guarda allo specchio non può nemmeno riconoscersi nell’identità che è riuscita a crearsi negli ultimi dieci anni. Così deve rivalutare tutto, di nuovo, ricostruire daccapo, in special modo il rapporto con l’alimentazione e la sessualità. Tanto lo sappiamo già che il non poter usare le labbra e le guance e il senso del gusto alterato diventeranno la scusa perfetta per tornare a rifugiarsi in un disturbo alimentare e dare di nuovo spazio alle ossessioni riguardo l’impossibilità non solo di risultare attraente per qualcunə, ma anche l’incapacità di usare il proprio corpo per dare piacere e farne esperienza come una persona normodotata. La psicoterapeuta ne sarà estasiata, un anno di lavoro in fumo. E in effetti era più arrabbiata di me: sono entrata in quello studio, quattro giorni dopo l’accaduto, già rassegnata a vivere di nuovo la sensazione di essere un mostro. La vergogna di quel ghigno, l’incapacità e il rifiuto di piangere perché non volevo nemmeno compiere lo sforzo di fare una smorfia di dolore. Non riuscivo a smettere di pensare che fosse capitato di nuovo perché me lo meritassi. Perché per me non c’è scampo da me stessa, perché alla fine è vero che non mi merito niente e i miei meccanismi di difesa sono l’unica strada percorribile per avere una parvenza di accettazione. Non ho ancora capito se cercavo, e cerco, accettazione dal mondo esterno o da me stessa. La prima volta ho faticato molto, anche se non lo ammetto facilmente, per guardarmi allo specchio senza concentrarmi solamente su quella che consideravo la mia parte “buona”. È anche il motivo per cui mi sono accorta con quasi tre giorni di ritardo che la paralisi stava tornando: ero così rassicurata dall’avere una metà sana e una malata, che quando ho finalmente guardato il mio riflesso per intero non volevo credere a ciò che vedevo, al crollo dell’ultimo avamposto della mia normalità.
In ogni caso, almeno stavolta sapevo cosa mi aspettava: sei giorni di antivirale, ogni sei ore. Dieci giorni di cortisone, un botto di cortisone perché i sessanta chili dei diciassette anni sono ormai un lontano ricordo ma gli effetti collaterali me li ricordavo benissimo tutti (quello che non ricordavo, e che nessuno stavolta mi ha detto, era di scalare il dosaggio durante la fine della terapia; dopo aver passato quattro giorni in withdrawal da cortisone, penso che ogni mia curiosità sul consumo di droghe sia completamente e certissimamente svanita). Collirio ogni tre ore, bendaggio notturno per evitare che la cornea si secchi e corra anche il rischio di perdere l’occhio. Prenota le visite con otorino, oculista, neurologə. Attaccati al CUP per cercare un ospedale che abbia posto per una risonanza. In piena pandemia. Sparpaglia messaggi a chiunque conosci per cercare qualcunə con cui fare fisioterapia. Con i centri chiusi, perché c’è una pandemia.
La burocrazia della malattia è tra le cose più crudeli con cui abbia mai avuto a che fare.
Mi sono concessa di piangere solo una volta, in bagno, mentre mi preparavo per andare al pronto soccorso. Mi sono messa a urlare affondando la faccia nell’asciugamano. E poi non ho pianto più.
Dopo la prima paralisi ho cercato disperatamente le tracce di qualcosa di normale in me, nella mia faccia, qualcosa del prima di quella morte a cui potermi aggrappare, su cui potermi concentrare ogni mattina per non far crollare i castelli di carte della mia stabilità mentale. Guardarmi, studiarmi. Esercitarmi nelle espressioni: alza le sopracciglia, aggrottale. Fai un’espressione di disgusto, dilata le narici, scopri i denti come un cane che ringhia. Sorridi. Sorridi! Sorridere era una delle cose che faceva più male. Prova a fischiare, forza, sporgi le labbra in avanti, come se stessi per dare un bacio.
Ma che ne so di un bacio? Non ne ho mai dato uno. Non ne ho mai ricevuto uno.
Non ho mai saputo cosa si provasse a incontrare qualcunə che volesse starmi così vicinə, prima di morire e risvegliarmi come il mostro che avevo paura di sembrare. Non ho mai potuto fare a meno di chiedermi che cosa si provi a baciare una persona con delle labbra che fanno esattamente ciò che comandi loro, e a oggi continuo a chiedermi se la prossima volta che mi capiterà di baciare qualcuno sarà come avere di nuovo un primo bacio. Non che il primo primo sia un gran bel ricordo. Se non mi chiedo più perché con tutti i miei difetti piacessi comunque a quel ragazzo, è solo perché ho capito in seguito che gli faceva molto comodo sfruttare le mie insicurezze (e proiettare su di me le sue) ma non sono più arrabbiata o addolorata per come sono andate le mie avventure sentimentali adolescenziali. In un certo senso, se non avessi avuto la paralisi, forse non mi sarei mai spinta ad agire. Tutte le mie esperienze romantiche, anche quelle che di romantico avevano molto poco, sono accadute dopo. Non ho ancora capito come incasellare questa constatazione nel quadro generale delle cose, se prenderla come una prova che il mio aspetto esteriore conta molto meno di quanto creda. È molto difficile arrendermi al fatto che mi considero secondo dei criteri che non utilizzerei mai per valutare un’altra persona, e allora perché continuo ad applicarli a me stessa?
Non ho molte fotografie di me prima della prima paralisi, e di quelle che ho ne tengo solo un paio a portata di mano. Non sono mai riuscita a smettere di arrovellarmi su come sarebbe andata la mia vita se avessi potuto sorridere di nuovo. Se non fossi cresciuta con quella piccola morte senza rinascita, se non avessi dovuto di nuovo imparare a esprimere le mie emozioni. Adesso quando mi guardo non so mai cosa vedrò. Quando mi esercito il mio sguardo diventa asettico e preciso, pronto a cercare qualsiasi anomalia di cui parlare poi con il fisioterapista. Altre mi chiedo se l’identità passi necessariamente dal volto, se non posso ovviare a questa condanna di avere delle fattezze che non riconosco. Mi faccio un sacco di foto e copro con un dito prima una metà di viso e poi l’altra sperando di non trovare due persone diverse. Mi alleno a mettermi in posa. Mi tiro su un angolo della bocca per vedere come sarebbe sorridere veramente, chiudo un occhio per nasconderne l’inespressività. Cerco di ascoltare la voce di chi mi vuole bene e sa vedermi come io non riesco, perché dentro mi sento twisted and unkind.
Dall’anno scorso ho deciso di raccontare queste cose per motivi che in tutta sincerità si mescolano e non mi sono ancora del tutto chiari. C’era molta stanchezza, c’era molta rivalsa. C’era il grandissimo desiderio di far sentire la mia voce e di raccontare quello che avevo vissuto, non per sbatterlo in faccia a chi mi stava attorno, ma perché ogni giorno incontro le vite di sconosciutə su internet e ho capito che come loro erano riuscitə a darmi nuove prospettive, forse potevo essere in grado di fare altrettanto.
Storco sempre il naso ora quando mi si dice che sono una persona forte, quando mi si dice che sono una persona coraggiosa a raccontare questo mio dolore, le difficoltà, che infondo speranza. Che sono bella. Che non si vede niente della mia “anormalità”. Io non ho speranza. Né coraggio, né forza. Non sono bella. Non voglio essere bella, non me ne faccio niente. Io sono stanca di vivere in un mondo dove la narrazione di ciò che viviamo è impostata sul guarda che nonostante tutto ce l’ho fatta, sono validə, posso sedermi al tavolo con voi, persone normali. Io non ho fatto proprio niente. Io vivo con me, con il mio corpo, con ciò che vi è accaduto, con le persone che ho accanto fisicamente e non. Ogni giorno che mi sveglio e non sono mezza morta è un giorno in cui voglio imparare a rispettare e dialogare con questo vaso di creta che mi contiene e mi permette di fare cose, e dove vorrei metterlo a disposizione per tuttə quellə che vorrebbero costruire un mondo dove non sia necessario specificare la validità a esistere di nessunə.
Carmen Di Santi è nata a Roma dove vive e sta terminando gli studi in traduzione dallo spagnolo. Scrive su molti quadernini che spesso lascia a metà per anni, canta ancora nel coro del suo vecchio liceo e quando riesce cerca di imparare dal mondo tutto quello che può.