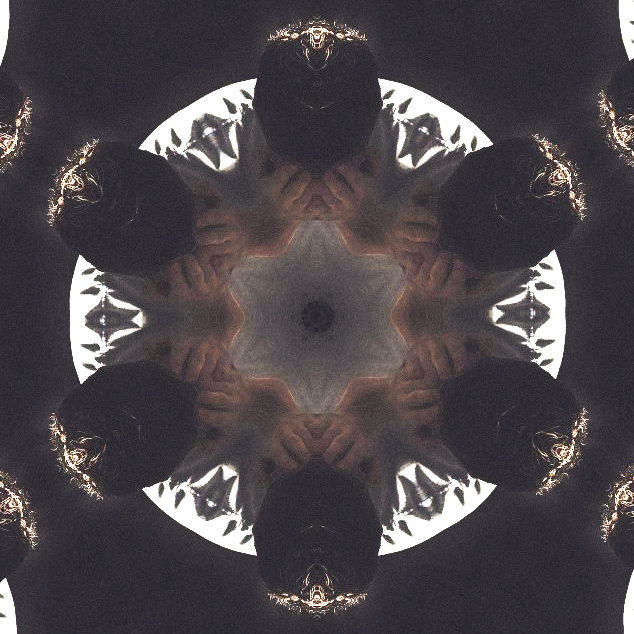Cronaca di un desiderio
Quel che so con certezza è che la mia vita è iniziata quando avevo da poco compiuto diciassette anni, un pomeriggio in cui, per l’ennesima volta, mi trovavo in casa di Medea la figlia di nessuno, Medea la problematica, la ripetente, l’abbandonata dalla madre, l’allontanata da un padre troppo affettuoso, l’accolta dal nonno materno. Quel giorno, invece di lasciarsi come sempre aiutare con la versione di latino, si era stesa sul letto, tirandosi giù i jeans. Ricordo con maniacale precisione le sue cosce per come erano allora e nella mia mente Medea è ancora imprigionata in quell’incontro purtroppo irripetibile. Inquieto, diffidente, isolato, condannato a mangiarmi le parole, non mi mancava nulla per diventare l’oggetto delle fantasie di una ragazza emotivamente gelatinosa e alla ricerca di qualcuno su cui esercitare il potere di cui si sentiva depositaria. Ricordo lo sguardo di mio padre, che aveva capito e forse sentito tutto accostando l’orecchio alla sottilissima parete della mia stanza, che confinava con quella di Medea. Era severo mentre io, rannicchiato sul letto, cercavo di comprendere cosa fosse accaduto al mio corpo e come potessi riprendermelo, perché già non mi apparteneva più.
La mia vita iniziava quel giorno e tutta questa storia è per me così seria che non posso parlarne apertamente. Sarebbe inopportuno, anzi, da spudorati. Io, per poter dire la verità, ho bisogno di sminuzzarla e amalgamarla con altri ingredienti.
Mentre aspettavo con ansia la grande intuizione che prima o poi avrebbe impresso una qualche direzione alle mie giornate, tutti i pomeriggi mi presentavo a casa di Medea. Lei apriva la porta e portava l’indice alle labbra. Passavamo alle spalle del nonno e andavamo a chiuderci nella sua stanza. Il latino era una scusa per abbandonare la mia scrivania e andare da lei nella speranza che mi concedesse di accedere al suo corpo e, per mezzo del suo, al mio. Ma i conti già allora non tornavano e ogni giorno rientravo a casa più povero e ignorante di prima. Non era più la bambina che urlava e scalciava perché non voleva che me ne tornassi a casa, lasciandola sola col nonno. Adesso, invece, silenzioso per non urlare, rigido per non crollare a terra, ero io a lasciare la sua casa convinto che presto mi avrebbe ferito mortalmente. Mia madre mi guardava con lo sguardo pieno di vergogna di chi aveva capito tutto. Non paga, mi faceva visita persino nei sogni, dove aleggiava a braccetto con Medea, che mi fissava con gli stessi occhi pieni di furore con cui mi faceva entrare nella sua stanza. Il mio misero intelletto collassava sui manuali e i fogli bianchi dei miei quaderni, sapendo che lei, con quello stesso sguardo, andava a perdersi nel mondo e fra gli innumerevoli uomini che lo affollavano.
Leggevo e studiavo senza sosta e il tempo che mi restava lo impiegavo per controllare Medea. Premevo l’orecchio contro il fondo del bicchiere e auscultavo la parete per carpire qualcosa delle sue segrete conversazioni. Prendevo a calci e pugni il portoncino blindato della sua casa e con la bava alla bocca pretendevo di sapere con chi avesse parlato, mentre lei con un sorriso svuotava di senso la mia povera vita esposta al giudizio di mio padre, la cui sagoma prendeva forma nel pianerottolo. Troppo occupato col fantasma di Medea, senza che quasi me ne accorgessi, perdevo ogni contatto con le poche persone che ancora mi davano retta. Solo Fabio Perez, antico compagno di scuola, si ostinava a seguirmi. Terminato il liceo con voti da capogiro approdavo all’università fra i sorrisi di tutti quelli che scommettevano su un mio imminente crollo. Come un ratto mi muovevo circospetto, fuggendo dello sguardo di mio padre, che spesso sorprendevo a frugare nei miei cassetti, in cerca di chissà cosa.
Ero solo parzialmente pronto per quel nuovo periodo della mia vita. Avevo sì letto e studiato come un pazzo, riempito agende di appunti, rubato per poter comprare libri e ancora libri, ma sapevo che non sarebbe stato sufficiente. Ero invasato, quasi allucinato. Spesso, la sera, quando ero in procinto di sprofondare nello sconforto, non potevo fare a meno di bussare alla porta di Medea, che non si curava nemmeno più di nascondere quanto fosse stanca di vedermi strisciare fino a lei. Era troppo persino per uno come me e così, una sera che l’avevo incontrata per le scale in compagnia di uno stronzetto pieno di tatuaggi, ero letteralmente impazzito. Le urlavo contro che non doveva più parlarmi o guardarmi, giuravo che l’avrei presa a calci in culo e non so più nemmeno io cosa. Lo stronzetto si nascondeva dietro di lei, immobile e con la schiena schiacciata contro la parete. Stavano per chiamare la polizia, quando mio padre era arrivato e davanti a tutti mi aveva tirato dentro casa per i capelli, lui sì prendendomi a calci in culo. Mia madre piangeva. Medea si era limitata a fissarmi.
Erano seguiti mesi di morte apparente, conditi di dolori allo stomaco, tachicardie, penne consumate e occhi umidi su pagine sature d’inchiostro. Non ricordo come, ma in quel periodo ero stato preso a rimorchio da una certa Fiamma Satì, una mora piena di problemi, figlia traviata di professori universitari. Di giorno mi faceva rimbalzare per i corridoi della facoltà, obbligandomi a seguire assurdi seminari, la sera mi trascinava per feste e locali. Facevo di tutto pur di non pensare a Medea. Ero pazzo, e l’unico timido argine a quella follia erano gli occhi severi di mio padre, ancora capace di tenermi sveglio, la notte, piegato sul piano della scrivania. Inglobavo lessico, concetti, interi sistemi di pensiero e riempivo quaderni su quaderni di appunti di ogni genere. Ero in un tale stato di eccitazione e così in difficoltà che Medea, una sera, provando pena, mi aveva stretto i polsi e con la forza mi aveva portato a casa sua per farmi sedere sulla sedia a dondolo del nonno. Mi aveva tagliato le unghie e i capelli cresciuti fino a rendermi ridicolo. Quella sera, sfinito, mi ero limitato a ringraziarla, prima di addormentarmi su quella sedia vecchia e tutta scricchiolii che sapeva di minestrone. Medea mi mancava e, purtroppo, lei ne era pienamente consapevole.
Non so ancora come, ma in quel nulla che era la mia vita, i giorni e i mesi potevano comunque passare e, di fatto, passavano. Alla terza tesina di seguito che le scrivevo, Fiamma aveva deciso di invitarmi nella sua casa al mare. Dovevamo preparare un esame ma ci eravamo limitati a bere, fumare, mangiare lo stretto indispensabile, starcene sotto le coperte e camminare sulla spiaggia sferzata dal vento dopo ogni orgasmo che, di fatto, ci rendeva sempre più estranei. Sorprendentemente, però, ero stato obbligato a chiudermi in bagno per rispondere a Medea che, non vedendomi a casa, mi chiamava per sapere dove fossi e quando avrei fatto ritorno. Non volevo farmi sentire da Fiamma – Mi controlli? bisbigliavo. E lei rispondeva di sì, e io avevo voglia di mettere la testa nel cesso e tirare lo sciacquone per fugare ogni dubbio, per essere certo che tutto fosse vero – Torna a casa, diceva con un filo di voce, per la mia delizia. Fiamma mi prendeva per mano. Le sue erano piccole e fredde. Mi piacevano. Quei giorni erano degni di essere vissuti e ricordati, ma dovevo tornare. Al mio rientro, però, Medea sembrava già non aspettarmi più. Camminava all’ombra di uno sconosciuto decisamente più grande di noi, uno che mi faceva paura solo a guardarlo. Avevo iniziato a farmi scortare a casa da Fabio Perez che, senza che me ne accorgessi, metteva le radici nelle crepe sempre più profonde che attraversavano le mie giornate e la mia stessa vita. Lui mi seguiva per le scale del mio palazzo, Fiamma si prendeva cura di me nel mondo. Nella mia stanza, però, il fantasma di Medea dominava incontrastato.
Come per magia mi ero ritrovato a scrivere la tesi di laurea. Una nuova determinazione sosteneva le mie giornate. Persino mio padre se ne era accorto. Lo vedevo dai suoi occhi che brillavano attraverso lo spiraglio della porta accostata. Fiamma veniva spesso a trovarmi. Si stendeva sul mio letto aspettando che finissi e allora, se la tensione che mi attraversava si faceva insopportabile, capitava che mi alzassi per toglierle le mutande. Quindi tornavo a scrivere di asimmetrie dell’incontro e della magnificenza del volto dell’altro. Medea, dall’altro lato della parete, era tornata a essere la vicina di casa abbandonata dalla madre e sottratta all’aderenza del padre. Alla bambina, però, si era sostituita la giovane donna che adesso picchiava sui tasti di un vecchio pianoforte. Tradita e abbandonata, i suoi esercizi erano convulsi, pieni di violenza, accordi–schiaffi, note–pugnalate. Tradotto in note, il suo risentimento faceva tremare i vetri delle finestre, mentre io, sul letto, mi scioglievo nel corpo di Fiamma e sognavo la fine di tutto. Quello, in fondo, era il basso continuo delle mie giornate – il sentimento della fine imminente di quello che era solo un sogno.
Qualcosa scavava per venire fuori e quel qualcosa, scavando, corrodeva, destabilizzava. Non è questo quello che voglio, ecco cosa mi dicevo. E così, una sera, incapace di seguire i dettami del demone che mi ordinava di non farlo, avevo accostato l’orecchio alla parete e con le nocche avevo bussato, comunicando con un linguaggio antico, l’unico che potesse dire a Medea qualcosa del mio desiderio. Lei aveva continuato per settimane a picchiare sul suo pianoforte prima di decidersi a rispondermi, bussando a sua volta. Ricordo distintamente quella sera in cui, grazie al codice della nostra prima giovinezza, ci eravamo dati appuntamento sul pianerottolo, la sera in cui lei mi offriva l’occhio violaceo e il labbro gonfio, tornando a essere Medea l’abbandonata, Medea che se l’andava a cercare, Medea che immancabilmente tornava a cadere nello stesso errore. Ci eravamo seduti sui gradini e io le avevo stretto il braccio attorno alle spalle, che avevano sussultato per ore, fino all’alba. E così Medea tornava a me, decisa a riversarmi addosso tutta la sporcizia accumulata negli ultimi tempi.
Barcollante per le tachicardie, sempre sul punto di crollare per la stanchezza, tornavo a casa e la trovavo seduta sulle scale a leggere uno dei libri sottratti dalla mia stanza – Spiegamelo, diceva. E allora mi voltavo verso Perez, che mi seguiva ovunque, e gli facevo cenno di andarsene. E mentre lui svaniva per le scale senza proferire parola, io iniziavo a parlare. Seduto accanto a lei, parlavo e spesso mi addormentavo col capo poggiato alla sua spalla. Sapevo che qualcosa doveva accadere. Il tempo passava.
Dopo settimane in cui mi ero rinchiuso in casa recitando monologhi e tentando di controllare tic di ogni genere, ero pronto per discutere la tesi. Fiamma aveva scelto il mio completo di lino e mio padre mi aveva rifilato un vecchio paio di scarpe. C’erano stati il rito, la lode e poi, senza più argini, tutto aveva iniziato ad andare velocemente, sempre più velocemente. Mentre la mia tesi finiva in fondo a uno scaffale, inesorabilmente consegnata al passato, io quella stessa sera venivo trascinato, già ubriaco, in un locale per una festa in mio onore. Seduta davanti a me c’era Medea. I capelli nerissimi le cadevano sulla schiena come una cascata di inchiostro, grondando propositi che non comprendevo. Beveva, seguiva Fiamma con lo sguardo e con scatti improvvisi, piegandosi sul tavolo per raggiungermi e sbattendo il culo in faccia a Perez che l’aveva portata lì, mi prendeva per la cravatta, che avevo dimenticato di togliere. Io ero inerme, lei puro agire. Il suo corpo pareva sconfinato e più diventava grande, più io sprofondavo nell’angoscia. Fiamma non riusciva a toglierle gli occhi di dosso. Come me, era devastata da Medea tutta corpo, Medea la sensuale, la divoratrice di uomini e, se possibile, di donne. Alla non so quale ennesima birra, si era alzata per andarsene – Ti aspetto a casa, aveva detto. Quella fase della mia vita finiva nel momento stesso in cui Medea, voltandosi, rovesciava una sedia a terra. Sapevo di aver chiuso con Fiamma e tutti gli altri, ma, lo ammetto, non ho pensato a loro neppure per un istante, quella stessa notte, mentre me ne stavo seduto sui gradini di casa fingendo di dormire col viso affondato fra i seni di Medea, che sapeva di tabacco e birra e chissà che altro. Una sola domanda risuonava in me – E adesso?
Scomparse le persone, gli edifici, le aule, i professori, per l’ennesima volta, pur consapevole dei rischi, mi aggrappavo a lei. La rincorrevo all’università o in biblioteca, perché stava giocando alla studentessa universitaria. Mentivo a mio padre, dicendo che andavo in cerca di lavoro. Passavo le mie serate seduto sui gradini di casa. Leggevo libri su libri aspettandola, senza che fosse disposta a soccorrermi. I messaggi che le inviavo bussando alla parete rimanevano senza risposta. La seguivo ai concerti, senza biglietto, e mentre lei era dentro con i suoi amici io restavo fuori ad aspettarla e poi, quando usciva, si perdeva nel mondo, infilandosi in macchine piene di uomini, ma in cui non c’era posto per me, che rimanevo per strada, solo. Tornavo a casa a piedi e a ogni angolo, dietro a ogni cespuglio, mi pareva di scorgere le sue mutande abbandonate. Ero sfinito. Presto il volto di mio padre era tornato duro. E così, dopo che le mie aspirazioni accademiche finivano nel nulla, mi mettevo a studiare con una tale determinazione che dopo sei mesi, due scritti e un orale, mi ritrovavo terzo in una graduatoria definitiva che diceva al mondo intero che sarei diventato un professore. Mio padre tornava a sorridere e Perez, che aveva provato con me senza farcela, mi faceva i complimenti, incapace di abbozzare anche solo un sorriso. Iniziava così una nuova fase della mia vita, tornavo ad avere qualcosa da fare, a respirare e, forse, a prendermi una pausa da Medea. Dopo mesi passati a marcire senza un fine, senza un obiettivo, mi gettavo in una vita nuova, caricandola di tutto il senso di cui ero capace. Il ripiego, per l’ennesima volta, diventava ragion di vita.
Seguivo corsi, tenevo diligentemente il conto delle ore del mio tirocinio e cercavo di stare alla larga da Medea, anche se non sempre studiare come un pazzo e scrivere tutte le follie che mi passavano per la mente sembrava bastare. Cercavo Perez tutte le volte che veniva a bussare alla mia nuca la sensazione di girare a vuoto, di non riuscire a macinare tempo e mondo. Gli ordinavo di mollare qualsiasi cosa stesse facendo, ma non serviva a nulla, perché l’unica cosa capace di scuotermi di dosso quel brutto senso di disagio era Medea e la possibilità di dormire sulle scale col volto fra i suoi seni. Tutte le altre donne mi facevano ormai paura e solo per disperazione avevo concesso a una certa Norma Dalser di farsi largo attraverso le crepe delle mie giornate. Ne era venuto fuori un breve periodo che era stato come tirar la testa fuori dall’acqua, un rifugio contro lo spettro del naufragio. Seguivamo i corsi, andavamo a cena, al cinema e cose del genere. Tutte le sere ricevevo chiamate da Perez, ma adesso non avevo tempo per lui. Con Medea era diverso, però, perché lei era convinta di poter disporre della mia stessa vita. E così, non appena io smettevo di bussare alla parete, iniziava lei, con i suoi colpi nervosi, pieni di senso. Con i tappi di cera alle orecchie passavo le mie serate a preparare relazioni sul problema della didattica. La mattina uscivo di casa prestissimo, per non incontrarla, e al rientro salivo le scale a occhi chiusi pur di non vederla. Poi, una sera, l’avevo trovata seduta sulle scale con Perez. Non parlavano, entrambi persi nelle rispettive faccende. Perez, nel vedermi, si era limitato a salutare Medea con un cenno del capo. Ti aspettavo, aveva risposto alla mia domanda – Che ci fai qui? Ma la trappola era già scattata. Riprendevo così a bussare alla parete, mi piazzavo dietro alla porta di casa e dallo spioncino controllavo i movimenti sul pianerottolo. Uscivo e rientravo a qualsiasi ora, sicuro di sorprenderli a fare chissà cosa per le scale o sulla terrazza condominiale. Chiamavo Perez per invitarlo ai miei corsi, ma lui non rispondeva mai, e poi, quando tornavo a casa in uno stato di tensione insopportabile, lo trovavo al pianerottolo a leggere con Medea al suo fianco, terribilmente vicina, prossima – Mi cercavi? e si tirava su in piedi, sovrastandomi con la sua altezza e serenità d’animo. Non avevo mai notato, prima di quel giorno, quanto fosse alto. Non ero crollato solo grazie ai corsi, agli esami, alle relazioni, al tirocinio, a Norma. Non ricordo altro, perché non può essere ricordato qualcosa che, in fondo, è solo un’allucinazione.
Con la pausa estiva tornavano però i dolori allo stomaco, la pelle d’oca, i giramenti di testa. Più morto che vivo, solo, in canottiera, costume e infradito, tutti i giorni mi lasciavo andare sui sedili di un trenino che portava al mare. Fra la gente accalcata e sudata mi pareva di scorgere Perez e Medea. Li vedevo sulla spiaggia, dietro ai vetri degli hotel, sulle macchine che sfrecciavano col rosso. Norma doveva partire. Le avevo chiesto di rimanere. Aveva sorriso. Le avevo chiesto di portarmi con sé. Era diventata seria. Senza nulla e nessuno cui aggrapparmi mi perdevo in quella disperatissima estate fatta di crisi respiratorie, bolle, eritemi, letture feroci, bevute colossali e lunghi viaggi fino a quel mare in cui forse avrei fatto bene a svanire una volta e per tutte. Non era accaduto. Grazie a una incomprensibile forza di volontà, allo studio, alla scrittura e non senza il fondamentale apporto di certe goccette che mi aveva prescritto la dottoressa, ero riuscito a rimanere in vita. Superata quella terribile prova andavo dritto sparato verso l’abilitazione. Sei dimagrito, mi aveva detto Norma, alla ripresa dei corsi. Già, ero dimagrito. Perché, poteva forse concedersi il lusso di ingrassare uno che aveva passato due mesi nella più completa solitudine, sudando come un porco, a casa, parlando con i libri, le pareti e il proprio volto riflesso allo specchio? Per quale motivo non doveva dimagrire uno che si svegliava tutte le mattine col cuscino bagnato, gli occhi rossi, lo stomaco affaticato per la birra, il caffè e le doppie porzioni di kebab cariche di salsa piccante? Come poteva stare uno che l’aveva chiamata per tutta l’estate, mentre lei gli rispondeva a stendo dopo uno o due giorni?
Stabilizzato dalle goccette e grazie a certe chiacchierate con una dottoressa tutta corsi, master e specializzazioni che per quattro soldi si sciroppava quello che mi passava per la testa, finalmente capivo che dovevo darmi una regolata. Ero andato dal barbiere il giorno del mio ventiseiesimo compleanno e avevo tenuto botta riuscendo a non piangere lì davanti agli altri clienti, accorgendomi di quanto mi facesse bene fare cose normali. Parlavo meno, camminavo più lentamente, dormivo con la televisione accesa e salutavo con un cenno del capo Medea. Era stato così che dopo un paio di mesi, subito prima della pausa natalizia, Norma si era fatta nuovamente sotto per dirmi che potevamo vederci per un caffè, se ancora lo volevo. Va bene, avevo risposto, mantenendo la calma. Ero riuscito ad aspettare la sua chiamata, che era arrivata dopo una settimana. Qualche volta mi sedevo ancora accanto a Medea, sulle scale. Mi limitavo ad aprire l’agenda e andare avanti col mio diario. Solo se ritrovavo Perez seduto al mio posto perdevo per un attimo il controllo. Allora passavo dritto e correvo in bagno con i crampi allo stomaco, ma queste non erano niente più di deboli interferenze che solo di poco disturbavano i miei piani e, in quel periodo, la stesura della mia tesi sul ruolo dell’insegnante.
L’esame finale era arrivato e, come da programma, era stato una pura formalità. Eravamo venti corsisti e a fine mattinata avevamo festeggiato con un pranzo rumoroso che si era protratto fino a che non eravamo stati cacciati via dal ristorante, ognuno per la sua strada. Mi sentivo tranquillo perché avevo l’impressione di essermi comportato come una persona normale, o quasi. Tornavo a casa leggero, quel tardo pomeriggio di una tiepida giornata di fine aprile. Respiravo lentamente e cercavo di non pensare troppo ai mesi che mi aspettavano e che, in qualche modo, avrei pur dovuto occupare. Ero sprovvisto di oggetti, consapevole che l’enorme energia che mi portavo dentro rischiava di ingolfarsi per l’ennesima volta, col rischio di cadere nuovamente nello sconforto. Volevo solo tornare a casa per riposare e vedere come stava mio padre, che negli ultimi mesi si era smarrito in un labirinto fatto di analisi, brevi ricoveri e prescrizioni mediche. Potevo riuscirci, non fosse stato per Perez, che mi era sbucato davanti, precedendomi per strada. Camminava, ostinato a non fermarsi, mentre io lo chiamavo e lo strattonavo. La gente si voltava, lui no, mentre io alzavo sempre più la voce. Non si era fermato neppure dentro il palazzo, mentre la mia voce rimbombava per le scale. Non si era voltato prima di entrare in casa di Medea, chiudendosi alle spalle la porta blindata lasciata accostata per lui. Oh, che rumori infernali e al tempo stesso celestiali arrivavano fino a me, mentre io frignavo con l’orecchio incollato alla parete della mia stanza. All’ennesimo acuto di Medea, ero dovuto correre alla finestra per vomitare il pranzo. Dopo non so quanto tempo, sulla strada, era comparso Perez. Si era fermato, alzando gli occhi verso di me, lasciandosi guardare per qualche secondo, poi si era voltato e se ne era andato via. Aveva ottenuto quello che voleva. Non so bene perché lo avesse voluto con tanta ferocia, ma era riuscito a ferirmi a morte. Iniziava così un lungo periodo di vacanza, fatto di una solitudine disumana, capace di stupirmi tanto era totale e senza scampo. Di certe brutte giornate che mi sono toccate in sorte dopo quel giorno, però, preferisco non parlare.
Lavoro da diversi mesi. Ogni giorno mi alzo alle sei e per arrivare a scuola mi tocca un viaggio di più di un’ora, fra autobus e metropolitana. Studio molto, ma in modo nuovo, per altri e non solo per me stesso. Ho comprato un tavolino da campeggio e l’ho sistemato sotto la finestra. Preparo schemi, mappe, riassunti e scrupolosamente, giorno dopo giorno, annoto sulla mia agenda quanto mi sembra degno di nota. Ne verrà fuori qualcosa di monumentale, se sarò costante.
Attutite, mentre lavoro, scrivo, penso o inutilmente cerco di dormire, dalla parete giungono a me le disperate richieste di Medea, che a modo suo mi supplica di ritornare da lei. Sono riuscito a ridurle a delle eco lontane, queste richieste, dopo che col primo stipendio ho fatto istallare una parete isolante. Se la incontro per le scale, mi limito a salutarla con un cenno del capo e nulla più. Non posso permettermi di concederle la libertà di gettarmi nuovamente nello sconforto, poiché probabilmente non sarei in grado di riprendermi, non per l’ennesima volta. Torno a casa e apro la mia agenda, ma i conti non tornano, mai. A tratti penso che solo lei possa aiutarmi. Mi affaccio alla finestra per prendere una pausa dal lavoro e spesso vedo Perez giù per strada. Guarda verso di me, Perez–cane–randagio, forse nella speranza che io lo riprenda con me. Allora chiudo le imposte e torno al mio tavolino, come adesso, e alla mia agenda, a questa vita che non può ridursi a cronaca della vita, né risolversi in queste gambe incrociate sul tavolo appena lustrato nell’attesa di qualcos’altro. Mio padre è malato e il suo sguardo, non più severo, è pieno di interrogativi, forse di attesa d’aiuto, del mio aiuto. Non mi piace l’idea di perdere il suo sguardo, soprattutto adesso. Per settimane Medea, fuori di sé, mi aveva chiesto un figlio. Cambierebbe tutto, aveva pianto, mostrandomi le braccia piene di tagli e bruciature. Voglio un figlio, aveva ripetuto abbracciandomi e facendomi perdere l’orientamento in quella bizzarra geografia del dolore che era il suo corpo. Lo voglio da te. Era tornata da me, Medea in cerca di attenzioni, Medea la svitata, Medea la schizzata. E così avevo ceduto e mi ero sciolto in lei, disperatamente. Queste ultime settimane sono state per me un susseguirsi di tachicardie e allucinazioni, di spossatezza e conati di vomito. Oggi, per la prima volta da quel nostro disperato incontro, Medea non ha bussato alla parete. Il calendario parla chiaro, i conti finalmente tornano. Il mio seme ha fallito, lei ha fallito. Non è stata in grado di trattenermi in sé e questo mio povero corpo è tornato a me. Sono libero, certo, ma cosa altro desiderò adesso?
Tommaso Aramaico vive e lavora a Roma, dove insegna filosofia e storia nei licei. Ha pubblicato tre raccolte di racconti: Il posto di ciascuno (Officine Editoriali), Infinita perturbazione (Officine Editoriali) e Rovesci (Nulla Die Editore) e un romanzo intitolato Ringraziare (Delos Digital). Cura un blog (www.tommasoaramaico.com) dove c’è tutto quello che c’è da sapere su di lui.