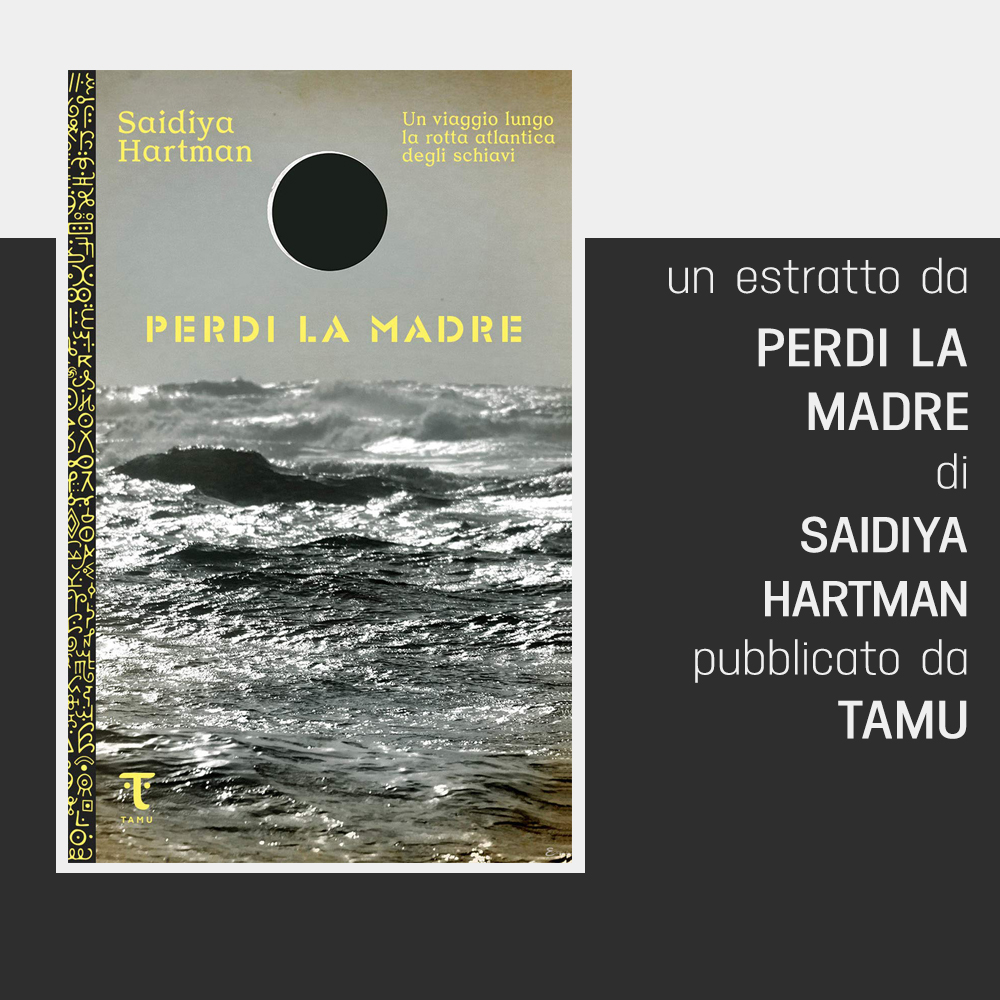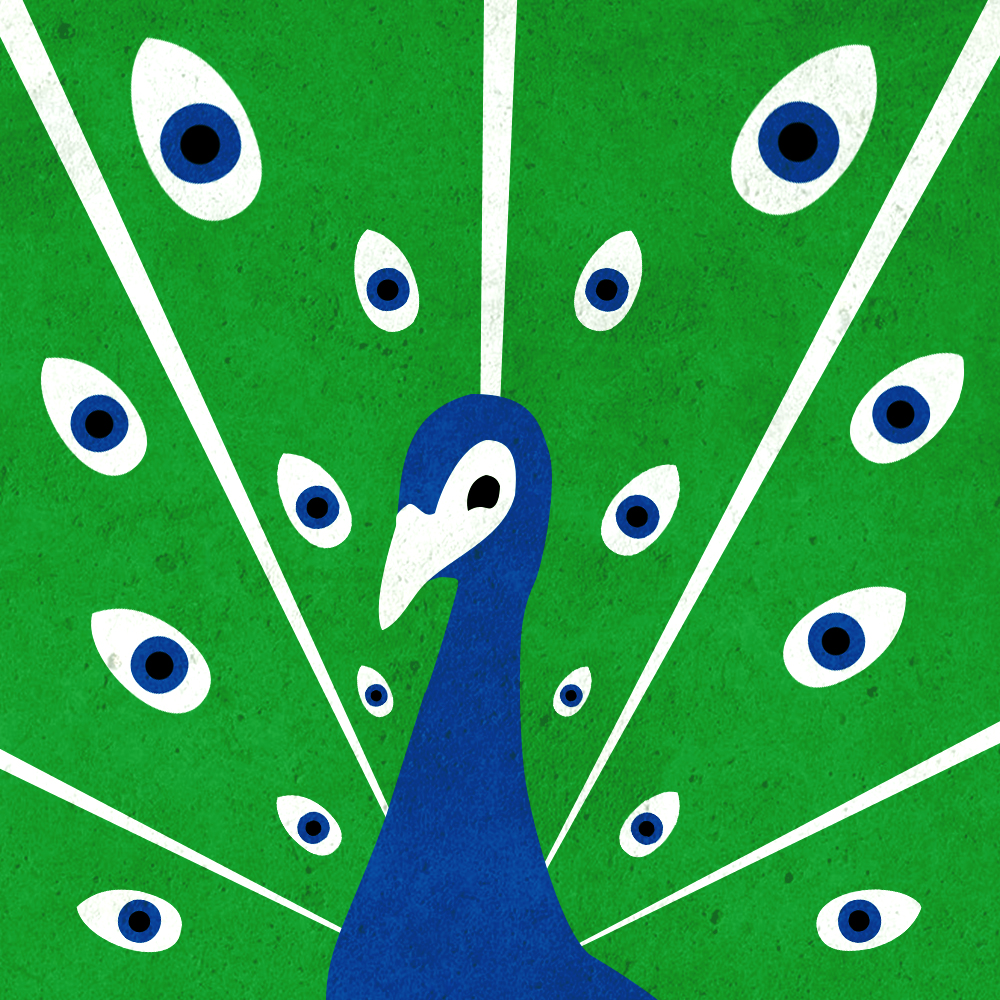Perdi la madre (estratto)
(Estratto dal libro “Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi” di Saidiya Hartman, tradotto da Valeria Gennari e pubblicato da Tamu Edizioni. Per saperne di più, visita il sito dell’editore qui.)
Ero venuta in Ghana in cerca di stranieri. La prima volta, nell’estate del 1996, solo per alcune settimane come turista interessata ai forti degli schiavi arroccati lungo la costa, e la seconda volta per un anno intero, a partire dall’autunno del 1997, come ricercatrice Fulbright associata al Museo Nazionale del Ghana. Il Ghana era un luogo come un altro per iniziare il mio viaggio, poiché non ero alla ricerca del villaggio ancestrale ma dei barracoon. In qualità sia di ricercatrice sulla schiavitù che di discendente di schiavi, volevo disperatamente reclamare i morti, e cioè fare i conti con quelle vite interrotte e distrutte nel processo di produzione di merci umane.
Volevo affrontare il passato, sapendo che i suoi rischi e le sue insidie costituivano ancora una minaccia, e che delle vite erano ancora oggi appese a un filo. La schiavitù aveva istituito un metro di misura degli esseri umani e una classificazione di vite e di valore che devono ancora essere smantellati. Se la schiavitù rimane una questione aperta nella vita politica dell’America nera, non è a causa di un’ossessione antiquaria per i giorni andati o per il peso di una memoria troppo duratura, ma perché le vite nere vengono ancora svalutate e messe a repentaglio da un calcolo razziale e da un’aritmetica politica consolidatisi secoli fa. È questa la vita postuma della schiavitù – opportunità manomesse, accesso limitato alla sanità e all’istruzione, morte prematura, carcere, povertà. Io pure, sono eredità della schiavitù.
Nove rotte di schiavi attraversavano il Ghana. Seguendo le tracce dei prigionieri dall’entroterra alla costa atlantica, volevo ricostruire il processo attraverso il quale furono distrutte molte vite e nacquero gli schiavi. Mi misi a seguire le orme di più di settecentomila prigionieri, passando per le società dei mercanti della costa che fungevano da intermediari e da agenti nella tratta degli schiavi, per le aristocrazie di guerrieri dell’entroterra che catturavano persone e rifornivano di schiavi la costa, per le società del nord che subivano razzie e saccheggi. Visitai i forti e i magazzini costruiti dagli europei lungo i cinquecento chilometri del litorale che va da Beyin a Keta, i mercati di schiavi messi su dai potenti stati dell’interno che depredavano i loro nemici e sottoposti e guadagnavano dalla tratta, le città fortificate e le comunità saccheggiate dell’entroterra che assicuravano il continuo flusso di prigionieri.
Avevo scelto il Ghana perché possedeva più segrete, prigioni e galere di schiavi di tutta l’Africa occidentale – celle strette e buie sepolte sottoterra, celle cavernose con le sbarre, anguste celle cilindriche, celle umide, celle improvvisate. Nella corsa all’oro e agli schiavi che iniziò alla fine del quindicesimo secolo, portoghesi, inglesi, olandesi, francesi, danesi, svedesi e branderburghesi (tedeschi) costruirono cinquanta avamposti permanenti, forti e castelli progettati per assicurarsi il proprio posto nel commercio africano. All’interno di queste segrete, dei depositi e delle celle gli schiavi venivano imprigionati prima di essere trasportati al di là dell’Atlantico.
La mia presenza in Ghana non era giustificata da nessuna ragione di sangue o di appartenenza, ma solo dal cammino degli stranieri spinti verso il mare. Non c’erano sopravvissuti nella mia stirpe o remoti parenti di cui ero venuta in cerca, né luoghi o persone del periodo precedente alla schiavitù a cui poter risalire. Le tracce della mia famiglia si perdevano attorno al secondo decennio del diciannovesimo secolo.
Diversamente da Alex Haley, che aveva abbracciato come propri gli estesi clan di Juffure e innestato la sua famiglia nella genealogia della comunità, e che fu acclamato come il figlio perduto e ritrovato, io ero andata in Ghana in cerca dei sacrificabili e degli sconfitti. Non ero venuta ad ammirare le meraviglie della civiltà africana, a inorgoglirmi per la corte reale degli ashantei, ad apprezzare quei potenti stati che mietevano prigionieri e li vendevano come schiavi. Non avevo nostalgia di origini aristocratiche. Al contrario, avrei cercato la gente comune, quei migranti involontari e forzati che crearono una nuova cultura nell’ostile mondo delle Americhe e che si reinventarono, facendo della spoliazione un’opportunità.
Nel momento in cui i prigionieri arrivavano sulla costa, spesso dopo aver percorso centinaia di chilometri ed essere passati dalle mani di mercanti africani ed europei, e si imbarcavano sulla nave schiavista, erano già degli stranieri. In Ghana si dice che uno straniero è come l’acqua che scroscia sul terreno dopo un acquazzone: si asciuga presto senza lasciare traccia. Quando a Elmina i ragazzini mi avevano battezzata come straniera, non avevano fatto altro che chiamarmi con il nome dei miei antenati.
«Straniera» è quella X che sostituisce un nome vero e proprio. È il segnaposto di colei che manca, il marchio del passaggio, la cicatrice tra nativo e cittadino. È sia una fine che un inizio. Annuncia la scomparsa del mondo conosciuto e l’ostilità del mondo nuovo. Il desiderio e la perdita che quell’etichetta evocava costituivano tanto la mia eredità quanto quella degli schiavizzati.
Riluttante ad accettarne il dolore, avevo provato a disfare il passato e a reinventare me stessa. In un atto di auto-costruzione volto ad annientare la presa dei miei genitori su di me e a sacrificare la figlia che avrebbero voluto, al posto di quella che ero, cambiai il mio nome. Abbandonai Valarie. Lei era la principessa che mia madre avrebbe desiderato che fossi, tutta seta e taffetà, zucchero e spezie. Era la ragazzina viziata che mia madre sarebbe stata se fosse cresciuta nella casa di suo padre. Valarie non era un nome di famiglia ma un nome che mia madre aveva scelto per me con l’intento di mitigare la vergogna di essere la figlia illegittima del dottor Dinkins. Valarie era un nome oppresso dal desiderio di cotillon, abiti confezionati ed estati al lago. Era un nome d’apparenza, tutto d’oro all’esterno, tutto crudezza e rabbia all’interno. Cancellava la povera ragazza nera che mia madre si vergognava di essere.
Perciò, al mio secondo anno di college adottai il nome Saidiya. Riaffermai la mia eredità africana per liberarmi dai grandi piani di mia madre. Saidiya mi affrancò dalla disapprovazione dei miei genitori e potò i rami borghesi della mia stirpe. Non importava che all’inizio fossi stata rifiutata. Il mio nome istituiva la mia solidarietà con la gente, estirpava ogni testimonianza di «negri virtuosi» e dei loro impegnati illegittimi eredi, sancendo il mio posto nelle file delle ragazze nere povere – le Tamika, le Roquesha e le Shanequa. Ma soprattutto, infranse le speranze di mia madre. L’avevo trovato in un libro di nomi africani, significava «colei che aiuta».
A quel tempo non mi ero resa conto che il mio tentativo di riscrivere il passato sarebbe stato vanificato, così come era stato anche per mia madre. Anche Saidiya era l’invenzione di una persona che non sarei mai stata – una ragazza non contaminata dalla macchia della schiavitù e da un fallimento ereditato. E neppure sapevo che lo swahili fosse una lingua immersa nel mercantilismo e nel commercio degli schiavi, che si diffuse attraverso le relazioni commerciali tra mercanti arabi, africani e portoghesi. La storia riprovevole di élite e gente comune e padroni e schiavi che avevo provato a rimuovere con l’adozione di un nome autentico veniva perciò inavvertitamente preservata.
Capii troppo tardi che la frattura dell’Atlantico non poteva essere sanata con un nome, e che le strade percorse da questi stranieri erano quanto di più vicino a una madre patria potessi trovare. Immagini di familiari calpestati e persi lungo la strada, abitazioni abbandonate di cui la terra si era riappropriata e paesi svaniti alla vista ed espunti dalla memoria erano tutto ciò che avrei mai potuto sperare di rivendicare. Con questo obiettivo mi misi in viaggio sulla rotta degli schiavi, territorio reale con le sue coordinate oggettive e allo stesso tempo regno metaforico di un passato immaginato.
Saidiya Hartman insegna letteratura africana americana e storia culturale alla Columbia University. Nelle sue opere intreccia una meticolosa ricerca storica a una narrazione che recupera dall’oblio le storie di personaggi senza nome – le prigioniere sulle navi schiaviste, gli abitanti dei ghetti di New York e Philadelphia agli inizi del XX secolo. Il suo lavoro mira a far riemergere «la testimonianza di vite, traumi e fugaci momenti di bellezza che gli archivi storici hanno omesso o occultato». Con questa motivazione nel 2019 ha ricevuto il prestigioso premio MacArthur.