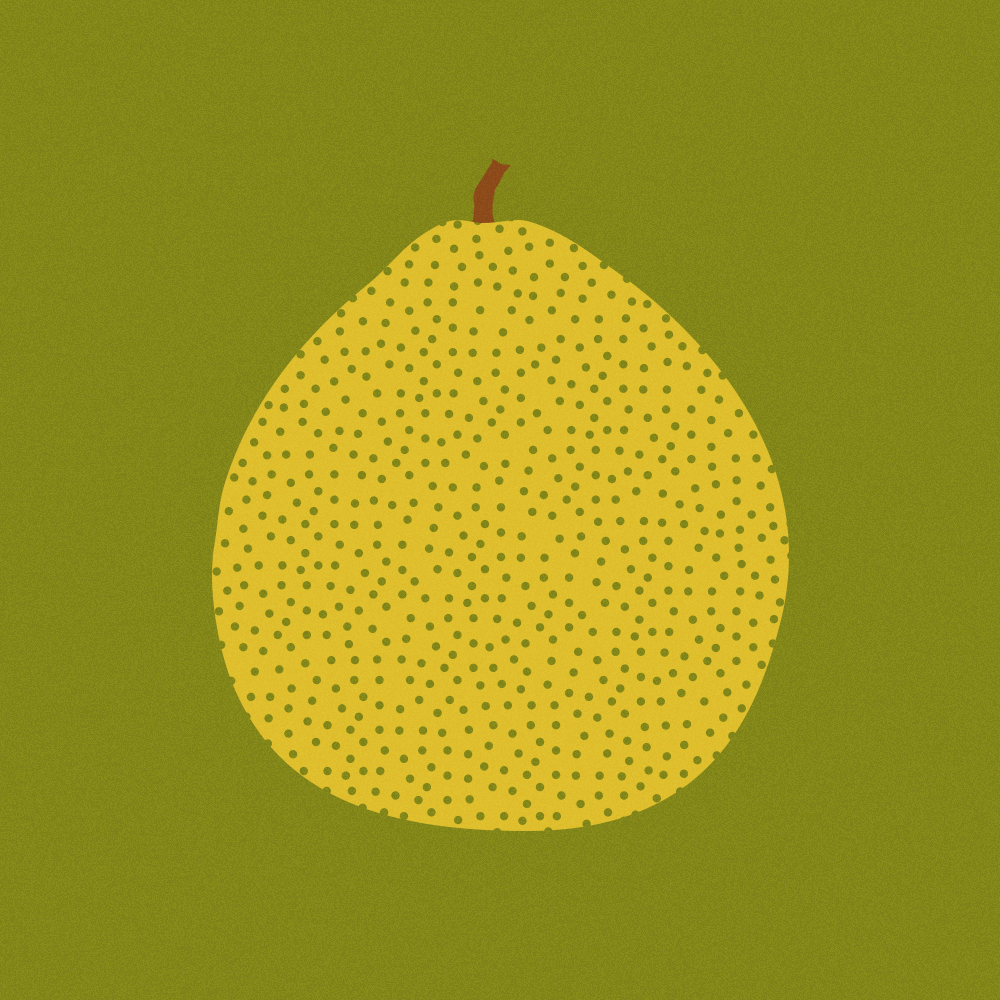Pomelo
Qualche metro al di sotto dei piedi, il mare risplende tenue. Trapassando con lo sguardo la superficie maculata, riesco a scrutare il fondale sabbioso dilaniato da canini salmastri. Le mie dita, sensibili alla pressione della mia acrofobia, si arcuano sugli scogli taglienti. Al largo del piccolo golfo di Torre Pozzelle il mare è nervoso.
Altri ragazzi, anche bambini – diamine! – da postazioni frastagliate sicuramente più vertiginose della mia, si gettano in acqua con destrezza. Qualche timoroso che non sa farlo “a pesce” si getta comunque senza esitazione, raccogliendo le gambe al petto. Li guardo, questi ragazzetti di almeno dieci anni meno di me, dotati di intraprendenza e coraggio. Provo una certa invidia, ma osservo da mezz’ora i loro movimenti confidando nella mimesi visiva: quindi fletto appena le gambe anche io, inarco la schiena, poi roteo le braccia per portarle avanti alla testa e m’incuneo. Ci sono, penso.
Ho il viso parallelo all’acqua vetrosa. Un pesce dalle scaglie diamantine s’aggira sinuoso al di sotto del mio scoglio. Allora, l’intraprendenza si liquefa. I piedi si serrano ancora una volta. Sanno che sto per farlo, ho necessità di piegarmi ancora un po’. Respiro, conterò fino a dieci – mi dico – quindi giù, non importerà arrivare con la pancia, l’importante è lanciarsi.
I miei pensieri sono frantumati dal rumore di un corpo che infrange la barriera azzurra. Dall’acqua, lucido come un arcangelo, spunta fuori un ragazzo di undici, forse dodici anni, dalla carnagione olivastra e il baffo appena pronunciato. Sembra me alla sua età, solo che lui ha avuto coraggio, io alla soglia dei trent’anni sono incuneato dalla vertigine e dall’imbarazzo.
Desisto, mi rimetto dritto e guardo attorno: nessuno ha badato a me, nemmeno Bianca che dal fondo della scogliera guarda affascinata il suo pomelo fluorescente.
Neanche questa volta mi tufferò a pesce. La guardo, mentre sta per tagliare il frutto, ma chiamo il suo nome. Torniamo a casa, dico solamente.
Quando torniamo da Torre Pozzelle saliamo sempre attraverso un sentiero stretto, marcato dai roveti e dagli esili muretti a secco. La strada si ingobbisce verso l’alto, mostrandoci l’asfalto plasmato dal caldo. Con la calce esangue a riflettere il sole d’agosto, casa di Bianca è letteralmente un fortino candido in mezzo alla vegetazione ispida della macchia mediterranea. E tra l’altro, benché suo padre provi a tenere a bada gli arbusti, quelli ricrescono con più acrimonia e determinazione.
Il giorno prima del nostro arrivo, in quest’eden grottesco di albicocchi storti e ulivi nodosi, i genitori di Bianca avevano trovato un frutto nuovo, che ci hanno subito messo sotto il naso al nostro arrivo.
Sul tavolo in cucina abbiamo cominciato a congetturare su possibili innesti o novelle specie fruttifere; abbiamo concordato nel considerarlo un pomelo, ma non lo abbiamo aperto per scoprirlo con certezza, colti da una specie di timore reverenziale. La vera sorpresa però è arrivata la notte, quando una volta spente le luci di casa, tra i canti corali di cicale, quel frutto ha iniziato a brillare di luce propria. Una tenue luminescenza ha circondato la buccia e i pori profondi, rilucendo nella penombra azzurrina della luna. Ammaliati, siamo rimasti a fissarlo per un tempo interminabile.
Quando finalmente sono andato a dormire, mi sono chiesto se avremmo mai avuto il coraggio di mangiarlo.
Sono già passati due giorni, io e Bianca l’abbiamo portato con noi al mare cercando vicino la riva l’audacia di privarlo della sua corazza spugnosa, ma entrambe le volte siamo ritornati a casa con un nulla di fatto. Anche adesso, che risalgo il sentiero verso casa mentre i grilli cantano il loro repertorio vespertino, mi sento dilaniato contemporaneamente dal desiderio di sbucciarlo e il timore di poterlo rovinare per sempre.
Arriviamo a casa che Bianca ha sete, ma abbiamo finito l’acqua, i suoi sono scesi in paese con l’auto a recuperarne un po’.
La guardo: le labbra sono terre brune e aride. La pelle olivastra, avvampata dal sole, ospita rigagnoli di sudore. Ora Bianca è vistosamente stanca, si denuda, gira una sigaretta e mi dà le spalle, lasciando cadere il peso su una sedia dal legno blu, in direzione della finestra dove esplode il cielo di un azzurro acido. La sua schiena nuda, levigata come i frutti delle vigne, ha un qualcosa di lievemente mistico. Il vento mi porta il suo profumo tenue.
Cerco il tabacco anche io, ma il pomelo mi chiama come una ninfa. Improvvisamente il suo canto filtra attraverso l’aria rovente. La sua buccia, tutto sommato, dovrebbe essere facile da intagliare e poi strappare, ci metterebbe poco a donarmi l’acqua contenuta nel flavedo, ingabbiata dalle venuzze gialle che si ramificano nei suoi organi zuccherini. Sarei dissetato, ritrovato, asceso a una nuova esistenza. Ma nel momento stesso in cui infilo l’unghia del pollice nella porosità della sua scorza fluorescente, Bianca mi chiama. Ho il pomelo nascosto dietro le spalle, dalla sua sedia non vede, quindi lo risistemo delicatamente sulla credenza. Allontanandomi scorgo la mezza luna della mia unghia sulla scorza porosa. Bianca preme il filtro con ciò che rimane della sigaretta nel portacenere, poi dice: Andiamo a fare una doccia.
Abbiamo evitato di metterlo affianco alle mele, perché l’etilene potrebbe velocizzare il processo di putrefazione. Io e Bianca lo guardiamo con fare curioso, ma adesso anche preoccupato. Nonostante siano passati tre giorni è ancora integro, senza grinze sulla buccia, con la patina luminescente intatta e il profumo denso dei frutti esotici. Lo reggiamo tra le mani, di fronte al mare cobalto di Torre Pozzelle che si stringe nell’imbuto del golfo. Ho un certo tedio a pensare di dovermi infilare nell’acqua, ma Bianca insiste, quindi ci dirigiamo verso la scogliera.
Lasciamo il pomelo sull’asciugamano. Entrambi, mentre ci allontaniamo, mostriamo i segni di una dipendenza affettiva, o di una fame animalesca. Ma poi le sue mani mi spingono verso il lato opposto, provo quindi a baciarla controbilanciando l’affezione malsana per un frutto con quella per un essere umano: e per un po’ funziona. A occhi chiusi, le labbra salmastre e le guance riscaldate dal sole mi portano in una dimensione nuova in cui l’estate è perenne e i frutti, bioluminescenti o melanici che siano, si possono sbucciare.
Poi Bianca si stacca, riapro gli occhi e le comunico con una certa fermezza che l’avremmo fatto oggi, stasera. Quindi con la felice consapevolezza della fine della storia procedo verso lo scoglio che ho preso come trampolino. Da qui il mondo sembra allontanarsi con un risucchio profondo. Incuneato come una freccia, con la testa tra le braccia, chiuso in questo guscio allungato di carne, il punto di vista cambia. Ogni cosa si deforma, s’allarga prima e s’allontana poi, procurandomi una certa agitazione vertiginosa. Quindi ritorno diritto per constatare che il mondo non si sia effettivamente appuntito. Piegandomi però nuovamente avverto la sensazione scivolosa di ritrovarmi in un imbuto acquoso, scosceso, frammentato da corpi carbonatici. Puntellata da coralli e madrepore, questa parete acquosa è una scoscesa verso l’inferno.
Mi gira la testa, vorrei vomitare, ma un lampo istintivo lungo gli arti spinge il mio corpo in direzione della superficie. Vortico nel vuoto in modo storto, senza un senso dell’agire e colpisco l’acqua con la pancia.
Sotto la superficie, avvolto dal blu osservo l’arrivo del corpo piccolo e sinuoso di Bianca. Sorride e pronuncia parole scritte da fila di bollicine perlacee che le sfuggono dai lati della bocca. Poi, con la stessa destrezza da ninfa, risale verso la superficie pinneggiando cautamente.
Appena fuori, le onde si infrangono sul nostro viso: è il saluto liquido del mare.
Nemmeno oggi sei riuscito a tuffarti a pesce, fa. Lo dice con un tono bonario, quasi compassionevole. Rispondo con un moto sconsolato delle spalle e ritorno verso il fondale. Trattengo il respiro fino ad acquattarmi sul fondale, sfiorando appena il cuore sabbioso del mondo. Poi pinneggio verso l’alto, in direzione di una volta celeste e lattiginosa.
Oggi è davvero bella l’acqua, dico, ma Bianca col suo profilo acuminato guarda verso la scogliera. Una nuvola di gabbiani si sta dirigendo verso il nostro asciugamano. So cosa sta per succedere, inizio a nuotare per uscire, mi aggrappo alla scogliera senza l’accortezza che ci vorrebbe per non tagliarsi i polpastrelli, dai quali invece iniziano a colare sottili rigagnoli rossi. Arrivato su, le mie dita pulsano mentre compio gli ultimi passi prima di accorgermi del marasma di ali, piume e gridacchi, che si ammantano nervosi attorno al nostro asciugamano. Sembra un tempo lunghissimo, poi quella nuvola bianchiccia com’è arrivata se ne va. Sull’asciugamano indiano rimane la buccia sventrata del pomelo, con brandelli di polpa colorata, qualche piuma candida. Seguo con lo sguardo lo stormo che si allontana verso l’orizzonte, brilla adesso di una bioluminescenza divina.
Dall’acqua, Bianca mi guarda e capisce l’avvenuto. Il suo viso brilla tra le onde placide come l’unico frutto luminescente a cui anelare, allora corro verso il trampolino e con uno slancio di cui non ho coscienza, senza alcuna vertigine, sono una freccia verso il mare, quindi risalgo dal fondale azzurro e il sorriso di Bianca è lì ad aspettarmi.
Bel tuffo a pesce, fa.
Antonio Potenza (1993) è un giornalista di Forbes Italia. I suoi racconti sono apparsi su Nazione Indiana, La Nuova Carne, Morel-Voci dall’Isola, Rivista Blam, Suite Italiana, Spore e Lahar Magazine, Il Rifugio dell’Ircocervo. Altri saranno pubblicati da Piegàmi, Voce del Verbo e Micorrize. È stato editor di Sundays Storytelling. Ha fondato Salmace.