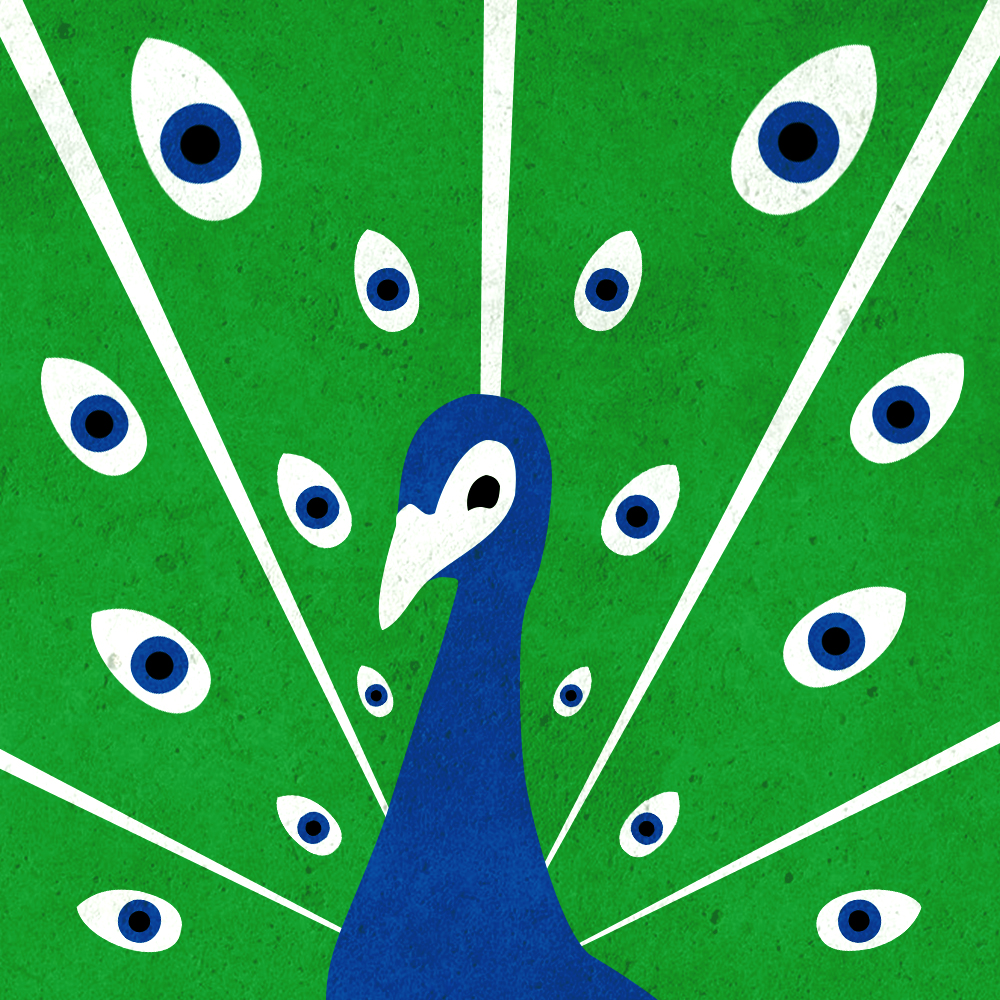Odio l’estate
«Odio l’estate,» ripetevo tra me e me. Simile a un mantra risuonava tra labbra e palato, appena percettibile ad anima viva, forse una leggera vibrazione, un soffio. Me lo immaginai trappato alla maniera tanto in voga alla radio e che avrebbe fatto venire la pelle d’oca a Bruno Martino. Un sorriso mi rasserenò il volto. Sbuffai. La fronte iniziava a imperlarsi di sudore; valigetta alla mano, sudavo aspettando l’autobus che mi avrebbe riportato a casa dopo una interminabile giornata di lavoro.
In ufficio l’aria condizionata aveva annullato ogni stagione portandomi lontano in quelle lunghe ore, verso i climi artici che tanto agognavo. Ma messo piede fuori dalla porta l’estate era tornata con la sua prepotenza togliendomi le forze e il respiro. Faceva dannatamente caldo. Allargai la cravatta e sbottonai il colletto della camicia per non soffocare.
Attendevo l’autobus alla solita fermata. Boccheggiavo, simile ad un pesce, cercando di concentrarmi sui particolari delle cose intorno a me, futile tentativo di distrarmi dai pensieri ossessivi: un’auto bianca che sfrecciava veloce e solitaria, una bicicletta rossa in lontananza, un biglietto di carta ai miei piedi, le locandine variopinte alla fermata, ma vuoi per la temperatura e per l’afa, vuoi per uno strano caso, a quell’ora la città era stranamente deserta. Io continuavo a sudare, passando la valigetta da una mano all’altra, ripetevo il mantra, sbuffavo nervoso, ma niente, dell’autobus ancora nessuna traccia. Qualcosa vibrò all’altezza del petto facendomi il solletico. Il cellulare, pensai. Lo lasciai vibrare fino a quando si fermò, non avevo voglia di parlare. Guardai la tabella degli orari, guardai l’orologio. L’autobus aveva tre minuti di ritardo. Allungai lo sguardo fino in fondo alla strada, ma niente. Calciai un sasso che andò a schiantarsi contro un bidone a poca distanza producendo un simpatico suono di lamiera.
Alzai gli occhi al cielo. Non stavo per imprecare, non era mia abitudine, ma cercavo di certo un segno. Il sole si diffondeva uniformemente con una luce rosea, probabile rifrazione dovuta allo smog cittadino. Quel cielo fermo incombeva su di me e sui miei pensieri e calava quel posto in un’atmosfera irreale, da film di fantascienza. Era lo stesso posto di sempre, solamente più caldo, considerai. Caldo, caldissimo, con un’umidità che mi arricciava i capelli e mi inzuppava la nuca.
Proprio sul palazzo di fronte stava attaccato un enorme manifesto. Non l’avevo notato al mio arrivo, e nemmeno nei minuti che avevo passato alla fermata fino a quel momento. Ne fui rapito.
Un volto sorridente, una giacca di ottima fattura, una camicia bianca e una cravatta che mi facevano provare un gran caldo e, sopra tutto, una scritta: “IL NOSTRO BENE È IL VOSTRO BENE”. Scoppiai a ridere. Ci voleva una certa supponenza per scrivere simili frasi. Vuote parole. Inoltre, considerai, non c’erano elezioni in vista. Nel nostro paese non era mai capitato si andasse a votare in piena estate[1]. Quel manifesto mi sembrò strano, un po’ inquietante, come quelli che si trovano nei paesi in cui scarseggia la democrazia…
Lo stridore dei freni dell’autobus mi risvegliò dalle mie considerazioni politiche, la porta si spalancò davanti a me lasciando fuoriuscire una zaffata d’aria condizionata profumata che mi portò un po’ di buonumore. Con una certa eccitazione allungai la gamba verso gli scalini e mi catapultai all’interno. Presi posto tra le prime file senza badare agli altri passeggeri e, incredibilmente, non appena il bus riprese la sua corsa, mi addormentai.
***
Quell’uomo si era liquefatto proprio davanti ai miei occhi senza fare il minimo rumore, lasciandomi impietrito, ammutolito, sudato, e ora mi trovavo solo, afasico, turbato, in mezzo a quel nulla reso ancora più schiacciante dalla calura e dal sole che batteva forte, senza avere la minima idea di cosa fare.
L’uomo aveva iniziato a vibrare un poco appena scesi dall’autobus. Io ero sceso dalla porta centrale, lui dalla porta davanti, ma se fosse già sul mezzo quando ero salito o se l’avesse fatto in seguito proprio non saprei dirlo. Mi camminava accanto, valigetta alla mano, a pochi metri. Lo osservai con la coda dell’occhio, osservai la strana vibrazione che accompagnava i suoi movimenti. Qualche passo ancora e la vibrazione era aumentata di intensità imperlandogli la fronte di sudore. Poi, così come aveva iniziato, si era fermata. Il sole, l’umidità eccessiva, l’aria condizionata sull’autobus, pensai, erano sicuramente stati la causa di ciò che definii “malessere”, una piccola crisi passeggera, anche se anomala.
L’uomo si fermò a riprendere fiato. Continuava a vibrare, impercettibilmente. Mi fermai un attimo pure io. Lo guardai ancora. Aveva la fronte madida, il corpo piegato in avanti e una smorfia dipinta sulla faccia. Gli chiesi se avesse bisogno di aiuto. Ma non rispose. I suoi occhi incontrarono i miei per una frazione di secondo e un sorriso fanciullesco spiccò dalle sue labbra.
Sopra la sua testa l’enorme pannello pubblicitario che segnava la metà del mio percorso verso casa e che in genere invitava all’acquisto di prodotti in super offerta. Ora, come per quello vicino all’ufficio, identico a quello, spiccava nuovamente il volto sorridente e la scritta “IL NOSTRO BENE È IL VOSTRO BENE”.
Io e l’uomo ci guardammo ancora. Qualcosa vibrò all’altezza del suo petto. Ebbe un fremito che si trasformò in una convulsione, poi prese a sciogliersi, così, senza dire una parola né emettere un lamento.
Lo guardavo mentre continuava a liquefarsi poco a poco sul terreno rovente e scomposto fatto di terra secca, pietrisco e laterizi, punteggiato d’erba qua a là.
Non riuscivo a distogliere gli occhi da quella scena.
Non saprei dire quanto tempo ci volle per vederlo completamente sciolto al suolo, simile ad un noto ricoperto al cioccolato o ancor di più ad un sacchetto di zuppa surgelata dimenticato fuori dal congelatore. Multicolore. Un aggrumato da cui proveniva un leggero gorgóglio, forse un ultimo guizzo vitale. A terra ormai non rimanevano che i vestiti dell’uomo: in quella poltiglia emergeva qua e là, la sua valigetta, il suo completo grigio, la camicia celeste, la bella cravatta, molto simile alla mia.
Non riuscivo a capire se l’odore che si sprigionava da ciò che mi stava davanti fosse l’odore più schifoso e nauseabondo o il profumo più soave ed esotico che le mie narici avessero mai annusato. Restai lì e lo respirai a fondo. Intorno nessuno, nemmeno un frullo d’ali.
Che avrei potuto fare? Che avrei dovuto fare?
Non c’era anima viva intorno a noi.
La fermata dell’autobus stava proprio davanti ad un campo dalla recinzione ormai divelta. Al suo interno un cantiere abbandonato resisteva alla natura, una Postdamer Platz post ideologica: incompiuto, anzi appena abbozzato, ricordo di una ristrutturazione edilizia frettolosa, probabilmente fuori legge e sinonimo di crack finanziario. Nelle fondamenta ora c’era un laghetto dalle acque putride in cui ad una certa ora gracidavano le rane e a fargli da contraltare, tra cespugli e siepi che crescevano rigogliosi un po’ dappertutto, le cicale. Le siringhe dei tossici spuntavano dal terreno simili a fiori post industriali e i preservativi usati, ormai cristallizzati al sole estivo, davano prova di una intensa vita sessuale cittadina. Era raro che qualcuno all’infuori di me scendesse a quella fermata e attraversasse il campo. Io, abitavo a poche centinaia di metri e preferivo scendere lì, fare quattro passi a piedi tagliando per il campo, senza correre il rischio di sostenere una conversazione spiacevole alla fermata successiva sicuramente più affollata.
Ma quel giorno dall’autobus eravamo scesi in due…
E quell’uomo si era liquefatto, senza apparente motivo. Aveva vibrato e si era sciolto sotto i miei occhi: ora mi ritrovavo solo, davanti a una pozza di sangue, umori, vestiti e qualche non ben precisato pezzo solido.
Risi nervosamente. Ero turbato dalla mia visione.
Quel poveraccio stava lì sciolto a terra tra sassi e cespugli e nessuno avrebbe potuto fare nulla per lui. Tutta una serie di domande si impossessò di me, forse era colpa del caldo… forse il troppo sole… forse…
Alzai gli occhi al cielo e incontrai ancora il volto sorridente del cartellone. Lessi la frase, “IL NOSTRO BENE È IL VOSTRO BENE”. Scoppiai a ridere istericamente e tutto a un tratto iniziai a vibrare. Prima il petto, poi la vibrazione si estese al corpo intero. Con sempre maggiore intensità. Mi piegai in avanti. La fronte si imperlò di sudore…
Intorno a me il caldo, il sole, il silenzio, la terra, i sassi, l’erba secca e quella poltiglia umana di cui non conoscevo nemmeno il nome.
«Odio l’estat…» pronunciai a labbra serrate, ma non ebbi il tempo di terminare la frase.
[1] Eccettuati il 26 e 27 giugno del 1983
___________
Massimiliano Nuzzolo è autore dei romanzi “L’Agenzia della buona morte”, “Fratture”, “L’ultimo disco dei Cure”, delle raccolte “La felicità è facile” (racconti) e “Tre metri sotto terra” (poesie). Curatore e autore dell’antologia “La musica è il mio radar” per Mursia, ha prodotto alcuni dischi tra i quali “L’esperienza segna” dei Soluzione.