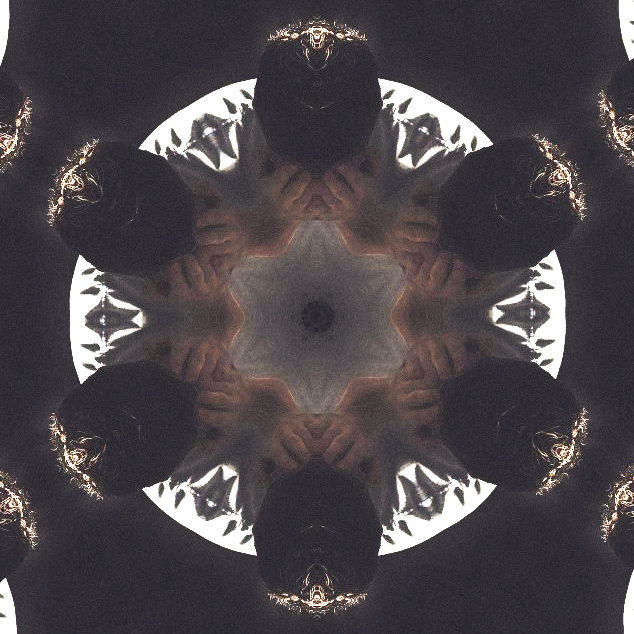Cambio casa spesso #2
La seconda volta che cambiai casa avevo da poco avuto il menarca – in ritardo rispetto al resto delle signorine mie amiche – e avevo incontrato una persona, un uomo adulto che non ingeriva le creature marine e soprattutto non mangiava il cervello degli agnelli strappandolo loro dal cranio arrostito come facevano alcune delle persone dalle quali ero stata educata a sopravvivere. Per appassionarci, io parlai di George Perec mentre lui mi parlò di Raymond Queneau. Proseguimmo almeno per un’ora senza ravvisare che l’immaterialità della conversazione non fosse la stessa: questo credo mi convinse potessimo innamorarci meglio di chiunque altro fosse vivo sulla crosta terrestre che si espandeva verso il vuoto sotto i margini delle nostre ossa ammonticchiate e protese mestamente verso i soffitti bassi del decadentismo industriale. C’era già stata la gentrificazione e le persone erano mediamente più alte e più povere di quelle che le avevano generate, noi non facevamo eccezione. Lui infatti mi raccontò al futuro di un tumore che avrebbe di sicuro avuto a causa di una trave portante che stava in camera sua e che sentiva causargli male sin dentro le cose che pensava. Questo mi aveva addolorato perché sapevo quanta musica riuscisse a contenere la sua testa e non mi piaceva l’immagine del cemento sospeso e incombente sui componimenti tardo-romantici. Mi chiese di andare a vivere nel suo scantinato – lo stesso della trave cancerogena – dove c’era una finestra che dava sul marciapiede e permetteva ai passanti di guardare quello che accadeva dentro lo scantinato e a noi di guardare quello che accadeva fuori: perlopiù tutti sputavano bile con impeto, a qualsiasi ora del giorno, spesso lasciavano cadere caramelle colorate che si scioglievano col sole e venivano calpestate da qualcuno che imprecava e se le portava altrove. Dentro, invece, eravamo così poveri da non possedere altro che noi e delle catene, così cominciammo a volerci odiare e credo che lui sapesse odiarmi meglio perché mi aveva rapita. Almeno così ci dissero delle persone persino più adulte di me e di lui. Ma questo solo dopo: prima diventammo pazzi guardando fuori dalla piccola finestra finché il moto e il tempo non ci apparvero insopportabili. Infatti stavamo fermi a lasciare che l’inedia ci divorasse. Trovammo infine una striscia di cartone e coprimmo la finestra e iniziammo a vivere nel buio pensando ai paesaggi lunari interiori che potevano arginare le nostre inconclusioni. Per farmi capire come sarebbero stati confortevoli, mi metteva le mani sulle costole e mi stringeva la cassa toracica fino a farmi credere che mi sarei avvolta su me stessa e sarei sparita nella stasi che precede una tragedia, e tra le sue mani avanzava ancora un po’ di spazio in cui lasciavo pian piano cadere le parole che credevo di dover dimenticare. Un giorno mi bucò un occhio con un ago arroventato e da allora quel bulbo divenne la mia principale piattaforma di osservazione e proiezione. Quando lui lasciava che il sole mi toccasse, riuscivo a proiettare i miei organi interni denutriti e un racconto di Ambrose Bierce in cui ci sono un lampo di luce e un collo spezzato. Il lampo di luce mi faceva riempire l’occhio di polvere mentre il collo spezzato mi faceva tremare la pupilla e lui sembrava affascinato dalla distorsione spontanea che applicavo ai miei ricordi. Io avrei voluto trattenerli intatti il più a lungo possibile, ma quelli procedevano autonomi a stiparsi in ambienti botanici incantati dove le immagini diventavano terra e foglie. Non avevo la forza di scavare o respirare, anche perché le pareti dello scantinato si stavano scrostando e rilasciavano una sostanza che ci seguiva dappertutto e non potevamo evitare di inalare. Ci appesantiva e ci faceva strisciare e rendeva le nostre viscere un unico blocco compatto. Poi lui fece un commento su Dalì, qualcosa sul fatto che fosse un ciarlatano dedito al sensazionalistico, e mi fece ridere perché non sapevo restituire in altro modo quanto ci fossimo ridotti. Non ricordo come tornai indietro, ma avevo un corpo diverso che tutti notarono e io dissi che era stata la pubertà. Attirai un tipo che voleva regalarmi un cavallo ma cambiò idea perché il cavallo era morto colpito da un fulmine mentre pascolava ed egli mi propose allora della legna e gli chiesi cosa dovessi farmene e mi disse che potevo bruciarla per scaldarmi e allora mi sentii sollevata che non fosse riuscito a cedermi il cavallo, ché lo specismo è una forma autoconsolatoria fin troppo barocca e lo so perché ricordando questa storia ho avuto una crisi al lavoro e mi sono chiusa a piangere nella cella frigorifera e quando si è diradata la coltre di umidità che avevo tra le ciglia ho visto una creatura squartata che mi ha fatto sentire meglio in un modo che ho trovato orribile.
Sara Verdecchia vive a Napoli e si considera insignificante, il che è comprensibile, naturalmente, ma non per questo è meno triste.