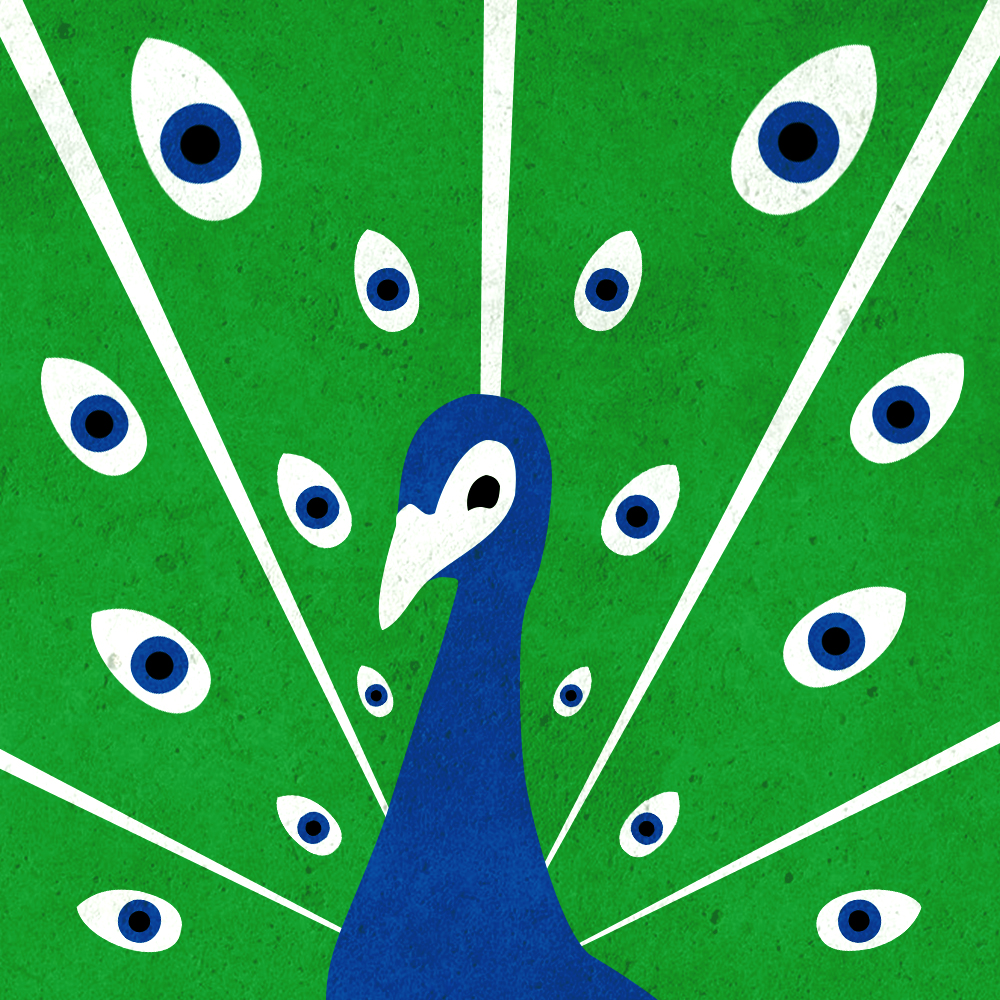La scimmia in tasca
Prima di scrivere questo racconto avevo un gruppo. Per i novizi che non sapessero distinguere una strofa da una barra: facevamo spoken word, che più o meno rappresenta la morte civile per chi fa rap e uno sporco compromesso per i Roberto Sanesi del nostro tempo.
La nostra chitarrista si era da poco diplomata al conservatorio di Torino in musica elettronica e fin dalla prima volta che l’ho conosciuta avevo capito bene con chi avessi a che fare: “Non devi. Mai. Cagarle il cazzo. Mai.”
Questo mi ripetevo, mentre parlavamo seduti sul prato dell’idillio che le nostre parole, condite dalla sua esperienza compositiva avrebbero, di lì a poco, creato tante incomprensioni. Ma è stato più forte di me: l’arte, come mi spiegarono il primo giorno al DAMS, non è un processo democratico. Lo capisci quasi subito, dal momento in cui metti piede nella saletta prove e tra un pezzo e l’altro scherzi col fonico sul fatto che presto cambierai l’industria culturale con una tua canzone: non si potrà cambiare il mondo, ma almeno il mercato è mutabile, pensi.
Ma Francesca no. Francesca ha ribadito sin da subito che lei voleva ristabilire un contatto, che voleva riabituare il fruitore all’ascolto, che i Pink Floyd erano “pop” e che la melodia lei non la utilizzava per principio, perché è una roba da tamarri nel caso migliore. «Mentre vedi qui – ora passami i cavi – si deve sentire l’essenza – scusa puoi tenermi la chitarra un attimo? – però parliamoci chiaro: questa nuova data quanto è pagata? Perché se non mi danno almeno cento sacchi, per me va bene la stima e l’affiatamento, però sai, è un momento complicato per tutti e non riesco proprio a proseguire.»
Rimango di stucco sulla punta del divanetto e le spiego che per me si tratta di recuperare qualcosa dalle spese – sostenute da noi tre, non da lei – a fronte dei concerti che dovevamo ancora fare in vista della promozione del disco dopo due mesi di lockdown, per cui non si poteva nemmeno portare il karaoke alla sagra di paese, figuriamoci la weltanshaaung dell’essere umano in rapporto alla cultura e all’arte.
Ma lei risponde «No, io sono una persona RA.DI.CA.LE,» scandisce bene le parole per non essere fraintesa, «e questa cosa non la voglio più fare.»
Appoggio le braccia sulle gambe e scuoto la testa in disapprovazione. Gli altri ordinano altre due birre dal menu elettronico sul cellulare. Lei sbotta:
«Oh, ma allora devi proprio farmi incazzare? Lo capisci che per me è un momento cruciale, che dobbiamo parlarne, non puoi fare l’intellettuale frustrato! Insomma, parliamone!»
Sì, certo, anche io ne vorrei parlare. Ma di sicuro non in questi termini e non con tutto l’alcol che mi sono bevuto prima di arrivare in questo buco per sopportare il suono della sua voce – la cadenza grave, lo scazzo ragionato e mascherato da empatia auto-riflessiva – quando invece sapevo benissimo cosa stesse per dire ancora prima di entrare.
Gli altri mi guardano come si guarda un uomo prima della fucilazione: è sempre stato un problema irrisolto tra me e lei, non posso certo sperare di avere un supporto, ché mi sono sempre percepito come il detentore della verità di ‘sto cazzo, quindi ora si godono lo spettacolo nel vedere come me la cavo con questa supposta superiorità quando la testa che rotola è la mia.
Mi alzo in barba a qualsiasi regola di distanziamento, mi faccio spazio tra i cani e chiedo alla barista un altro cocktail arancione. Sopra al bancone ci sono due scimmie, una bianca che tiene una lampadina nella zampa sinistra, fissa nel suo stampo in ceramica, l’altra penzolante dal soffitto, però di colore mogano scuro.
«Perché quella bianca sta in piedi e quella nera si arrampica?» domando alla barista, che tra la musica alta mi risponde solo un «Cosa?»
«Lascia perdere… Quanto devo?» faccio io, frugando nel portafogli.
«Cinque.»
Mollo la banconota sul banco e succhio gelido il mio drink dalla cannuccia.
Alla radio del locale in filodiffusione danno vecchi brani jazz – roba da boomer, che potrebbe piacere a mio padre – Billie Holiday o qualcosa del genere.
L’alcol entra in circolo e fa il suo giro. Immagino questa venditrice scafata del centro dire “Guardi, nelle scimmie bianche – come può vedere – c’è un interruttore a pulsante, dunque può spegnerle e accenderle quando vuole. Nelle nere, invece, c’è un circuito differente, quindi se vuole spegnerle le consiglio una doppia presa, altrimenti rimangono accese tutto il tempo.”
Scatto verso la finestra e osservo i canottieri remare di gran foga sul Po di colore giallo chimico malgrado il grigiore delle nubi in cielo; è da una settimana che va avanti il temporale, vorrei solo dormire e risvegliarmi l’anno prossimo – vi prego, ditemi che è un incubo – ma c’è una vita da affrontare.
Torno al tavolo con la sbornia ad addolcirmi i lineamenti. Gli altri difendono la faccia come possono: «Vedi io…» «Su molte cose non ero d’accordo, però…» «Ci si potrebbe lavorare…» ma ormai non ho più la forza né la voglia di stare a sentire. Mi concentro sulla voce di Billie e comincio a capire cosa ci trovino i sessantenni di tanto eccezionale. Lascio che tutto scorra. È inutile remare controcorrente.
Francesca bofonchia un «senza rancore» e poi grandi strette di mano. Usciamo tutti e quattro, l’aria è carica di umidità. Cerco di nascondere il tremore alle mani quando accendo la sigaretta tra le labbra ansimanti da pessimo attore quale sono.
Un aereo graffia il cielo grigio con la sua scia e non riesco ad allontanare il pensiero che presto anche Elisa mi lascerà – un abbandono nell’abbandono – e che implicitamente mi stia dicendo “O me o questa lercia città piena di borghesi e di figli di operai che hanno troppa nostalgia della catena di montaggio,” cani bastonati alla pressa di un progresso che s’inceppa.
Una volta, prima del lockdown, prima degli inni dai balconi, dei menu elettronici e del teatro solidale, Elisa mi chiese:
«Ma perché li odi così tanto?»
«Si odia sempre ciò da cui si proviene.»
Lei aveva annuito e ci eravamo addirittura compresi, in quel momento sospeso dalle ansie per il futuro, nei mesi di convivenza forzata a seguire, quando ci eravamo scoperti ad amare i reciproci difetti, come due ladri che stessero rubando dallo stesso scrigno. Però adesso era lei ad avere l’opportunità di andarsene, di ricominciare. Era lei la scimmia bianca.
L’abbandono di Francesca mi sembra, a confronto, la replica di un teatrino demente. Come quando il vecchio Dan – sempre prodigo di grandi teorie sulla cultura e sull’arte – mi disse: «Vedi caro mio, tu non capisci che le persone non sono pedine nelle tue mani, non ci muoviamo a tuo piacimento su una scacchiera.» Poco tempo dopo se l’erano bevuto per un giro di spaccio nella cantina del suo negozio, dove avevano scoperto una serra coperta in cui coltivava marijuana – piccola mossa che non aveva previsto – e adesso, dopo due anni, sta finendo di scontare la sua pena agli arresti domiciliari con obbligo di firma. Per il resto, il ragionamento non fa una grinza. Avevi ragione Dan, ma il tuo gioco non era diverso dal mio: volevamo rimanere gli unici re, e abbiamo perso entrambi.
Le persone come Francesca non sanno cosa si nasconda dietro la scorza, nella pancia di questa città – non sono interessate a scavare tra i cunicoli del suo intestino; pensano a galleggiare sulla superficie di vette più alte, ignorando la fauna sottostante.
Ci salutiamo, stretti nelle giacche, con la voce rotta ma senza rimpianti. Prendo il 16 appena in tempo, prima che cominci il diluvio. Niente piagnistei stavolta: ho già ingrossato abbastanza le pozzanghere di vomito alla moda di San Salvario. Me ne torno in silenzio in periferia, con il cuore gonfio e la scimmia in tasca, tra le persone vere con problemi veri, distanti da quelli di noi rockstar mancate degli anni ’20, quando una chitarra effettata e un programma su Ableton potevano ancora decretare il successo o l’insuccesso di un rapporto – e forse qualcosa di più.
Davide Galipò (Torino, ’91) si laurea in Lettere nel 2015 all’Università di Bologna con una tesi sulla poesia dadaista nella neoavanguardia italiana. Nello stesso anno dà alle stampe la raccolta di poesia visive VicoL0 – Giornale in scatola inesistente. Nel 2016 è tra i finalisti del Premio Alberto Dubito con LeParole e nel 2017 alcuni suoi testi sono stati inclusi nel volume Rivoluziono con la testa (Agenzia X). Dirige «Neutopia – Rivista del Possibile.» Ha pubblicato racconti su diverse riviste cartacee e online, tra cui il blog «SPLIT» di Pidgin Edizioni. Il suo ultimo progetto di spoken word music, Spellbinder, ha ottenuto una menzione speciale al Premio InediTo ed è stato segnalato tra i migliori progetti di videopoesia dal Premio Dubito. Dal 2019 organizza il festival di poesia e street art Poetrification, che si svolge nel quartiere di Barriera di Milano. Nel 2020 Eretica Edizioni ha dato alle stampe la sua prima raccolta di poesie, Istruzioni alla rivolta. Attualmente vive fra Barcellona e Torino, tiene corsi di scrittura non creativa e lavora come operatore culturale presso il circolo “La scimmia in tasca”.