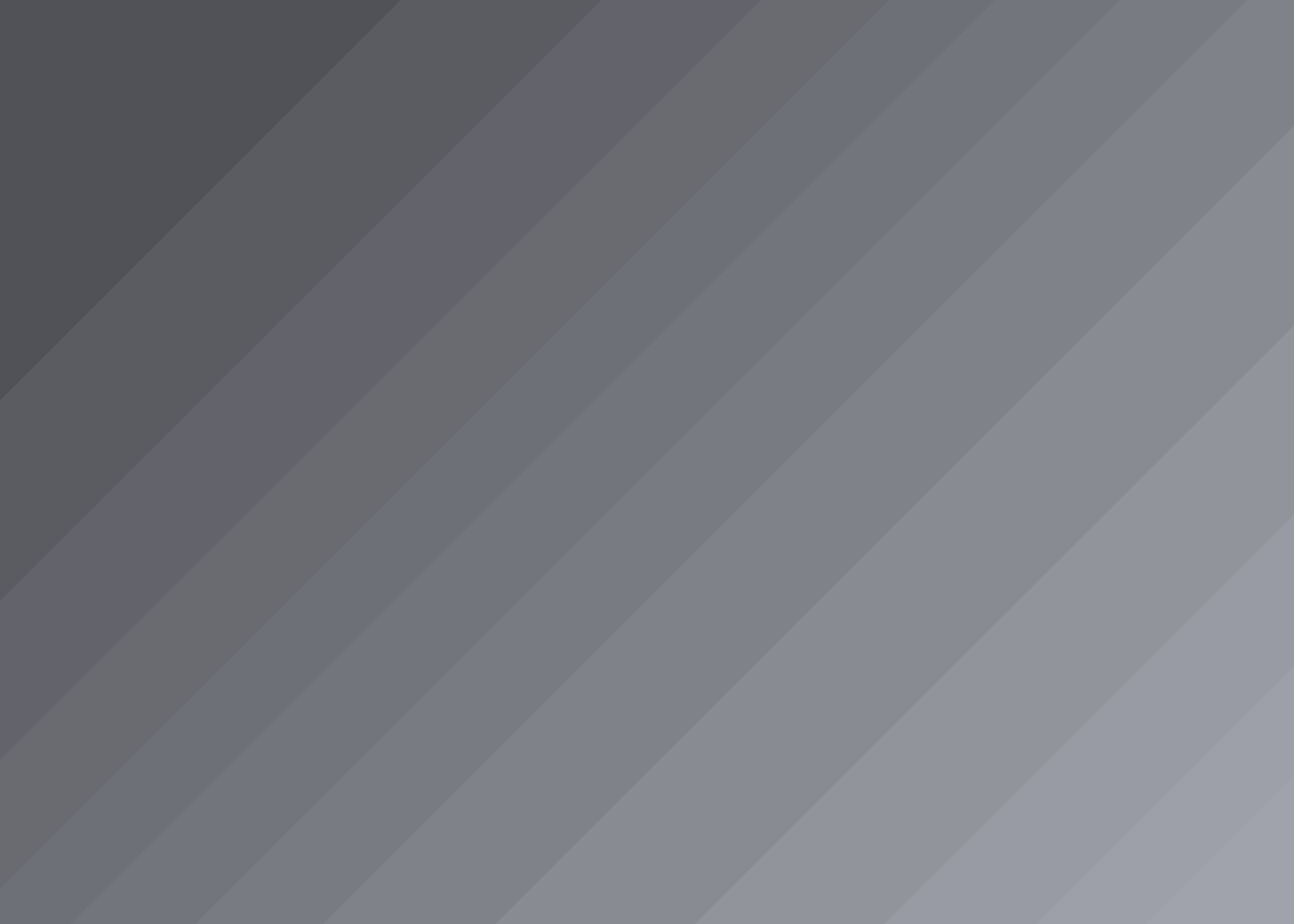Mufasa
La prima volta che ne ho visto uno avevo circa cinque anni.
Mio padre usciva dalla doccia e lo notai: zuppo, ballonzolante, la proboscide di un elefante che dondolava a qualche passo da me. Era circa lo stesso periodo che vidi il Re Leone, e l’enorme foresta di pelo folto a fargli da criniera mi ricordò subito Mufasa. Era il 1998 e ai miei occhi non aveva nulla di speciale: l’unico reale pene di cui ero a conoscenza oltre al mio, che era solo una piccola fisarmonica e che ero a malapena cosciente di portarmi dietro, diametralmente opposta a quella che penzolava tra le gambe di mio padre. Non riuscivo a creare un collegamento tra quello che avevo visto quel giorno e quello che avevamo io o i miei cuginetti: noi giocavamo in giardino ed eravamo soliti tirarci giù i pantaloni e fare la pipì insieme sul prato per non costringerci a interrompere il gioco trascinandoci fino al bagno di casa, e diventavamo improvvisamente come quegli angioletti di pietra che gettano acqua a fontanella. A parte annaffiare il giardino, non sapevo cos’altro ci si faceva con quel palloncino sgonfio. I bambini più grandi ne facevano un grande affare: intuii che quello che avevo tra le gambe aveva qualche funzione importante perché era sempre al centro della conversazione. Era fonte di grasse risate, misteriosi liquidi magici, e trasformabile a seconda del tempo o dell’umore. I ragazzi parlavano spesso di darlo a qualcuno, alle ragazze nello specifico: darlo, farlo sentire, ficcarlo. Non era neanche chiaro se le ragazze lo volevano o cercavano, ma i ragazzi sembravano convinti che tutta la fauna femminile del vicinato meritasse quel dono, pur senza richiederlo a gran voce. Uno dei miei cugini più grandi una sera mi disse dove andava ficcato, e la memoria potrebbe ingannarmi sul monologo originale ma mi affiderò a dei passaggi chiave: le bambine avevano un buco e in quel buco finiva un semino, e da quel semino ero nato io, e quello era l’unico modo, l’avevano fatto tutti e a quanto sosteneva prima o poi l’avrei fatto anche io. Gli urlai contro che era un bugiardo: non è possibile, perché devo farlo anche io? Perché sì, mi rispondeva lui, perché lo fanno tutti, è così che funziona. Più continuava a darmi quelle risposte, più io mi disperavo implorandolo di fornirmi un destino diverso. Era inconcepibile: la mia piccola fisarmonica per annaffiare il prato produceva semi che diventavano bambini, semi che andavano nelle patatine delle ragazze (impossibile pescare termini più rispettabili, all’epoca non ne esistevano altri). Perché poi? In quale occasione quotidiana avrei dovuto seminare nel buco delle bambine? Ah, certo, quando si faceva l’amore. Ma fino ad allora, sapevo solo che significava abbracciarsi senza maglietta sotto le coperte vicino a un caminetto per ragioni di trama. Facevano così nei film, e sembrava pacifico seppur vergognosamente intimo a tal punto da spingere mia mamma a coprirmi gli occhi. Decisi che quelle di mio cugino erano menzogne dette solo per spaventarmi, convincendomene così tanto da dimenticarle e non pensarci mai più.
Primi anni duemila, Toxic era alla radio, e a lezione di judo avevo scelto che mi piaceva una ragazzina. Lo sceglievo sempre quando mi piaceva una ragazzina: i miei occhi la percepivano rassicurante come una cena di Natale e accogliente come una famiglia per orfani senza tetto. Lo sceglievo e annunciavo con un filo di voce negli spogliatoi, dove i ragazzi più grandi erano nudi a un centimetro da me e presumibilmente giocavano a far volare l’elicottero che portavano tra le gambe, ma non posso confermarlo perché i miei occhi lo coglievano di sfuggita prima di tornare a rivolgersi al muro e non perdere di vista l’obiettivo: vestirmi e tornare a casa veloce come una lepre. Un ragazzo un giorno si tirò giù le mutande e se lo prese in mano, largo come il manico di un martello, e tenendoselo stretto mi urlò: devi fargli sentire questo. Niente di nuovo rispetto quanto mi era sempre stato detto, ma questa volta ci feci caso: era diverso, non timido e glabro come lo ricordavo, bensì sfrontato, disinvolto, ingombrante e fiero di essere sbandierato al mondo. Accennai un sorriso come piccolo ringraziamento a quel minuto di attenzioni, chiusi il borsone e tornai a casa. Senza rendermene conto mi portai in testa anche quella nuova immagine: era il secondo che vedevo, forse il più vicino a Mufasa del 1998. Questa volta però non una proboscide che penzolava davanti ai miei occhi indifferenti, era qualcosa che mi provocava formicolii e scariche elettriche, e mi costringeva, volente o nolente, a prestare attenzione anche a quello che succedeva tra le mie, di gambe.
A sedici anni i miei denti erano storti e pieni di ferraglia che si incastrava negli zigomi se sorridevo troppo, il mio corpo emanava odori di cui non ero proprio consapevole, tanto che mia madre mi invitò a usare il deodorante, e al liceo venni a conoscenza di tutto e niente. Una mia compagna di classe mi raccontava che lei e il suo ragazzo l’avevano fatto sopra una lavatrice e, stando alle sue descrizioni, lui aveva un siluro tra le gambe. A detta sua, si trattava sempre di esperienze sconvolgenti, meritevoli di essere raccontate alla prima ora, appoggiati al bordo della finestra e dondolando le gambe sulla sedia, ogni volta un racconto più memorabile del precedente. Non potevo non chiedermi cosa provassero: che incantesimo subiva il loro corpo su quella lavatrice, cosa significava prendere ripetutamente il siluro tra le gambe e cosa si provava nel darlo all’altro. Se ne parlava così tanto nei corridoi, e sembrava avere un’unica e sola destinazione, senza contemplare nessun cambio di rotta: la vagina. Finita l’ultima ora, tornavo a casa con lo zaino su una sola spalla, perché convinto che chi lo teneva su entrambe fosse strano e scemo, e dopo pranzo mi gettavo sul letto, lasciando che mi tornassero in mente le storie della prima ora. Smettevo di pensare dove metterlo e dove prenderlo, e mi focalizzavo sul miracolo stesso. Il miracolo per me era stare tra le braccia di un ragazzo più grande di me, alto come una quercia secolare, avere l’onore di tirargli giù i pantaloncini da basket, e farmi governare da quello che aveva tra le gambe, qualunque cosa significasse. Il miracolo era non restare sullo sfondo, cogliere anche io lo sguardo di uno di loro e lasciarmi travolgere dal suo corpo, facendolo diventare una cosa sola con il mio. La testa viaggiava oltre terre lontane al pensiero di essere protagonista, anche io, di quei racconti. Non avevo la minima idea di cosa comportasse, ma ero convinto che fosse l’unica cosa in grado di trasformarmi in una persona, rendendomi davvero parte integrante del mondo.
Passai la maturità con sessantaquattro e il primo contatto ravvicinato con un pene che non fosse il mio arrivò una notte al secondo anno di università. Condividevamo lo stesso letto ed eravamo entrambi ubriachi. Scusa se ho il respiro pesante, gli sussurrai dormendogli sul bicipite. Scusa se ho l’erezione pesante, mi disse lui prendendo la mia mano e certificandomi la sincerità delle sue parole. Era giunto il mio momento e non sapendo da dove iniziare preferii circumnavigare il ciocco di legno senza mai decidermi davvero a raccoglierlo. Ormai erano passati sessanta minuti e il mio benefattore si era addormentato. Il ciocco di legno era tornato alla forma soffice di un pane cinese, e realizzai che il mio piano di circumnavigazione era fallito. Ma non potevo arrendermi, era il mio momento e quella notte avrei scoperto l’America. Così, afferrai il toro per le corna, ricordando che non era troppo diverso dal mio, e lo risvegliai riportandolo allo stato di grazia. Il giorno dopo sapevo di aver scoperto un nuovo continente che avevano già conquistato e colonizzato in abbondanza molti altri prima di me. Ero uno dei tanti che si ostinava a credere di aver avuto tra le mani qualcosa di speciale. Da lì in poi, accadde un’altra volta, e altre dieci ancora: a casa dei nonni, sulla moquette, nella vasca piena di glitter, al secondo piano al centro di Firenze. Mai sulla lavatrice. Non c’erano vagine di mezzo, ma scoprii che i ragazzi potevano funzionare seguendo leggi simili a quelle che provavo io, anche loro con addosso dei jeans sempre troppo stretti e abbottonati per gestire le incontrollabili conseguenze di due carezze sul collo. Non si tratta solo di lasciarsi governare dal corpo dell’altro e scoprire di poter fare lo stesso, definire la gioia sul suo volto, rendergli presente la propria fierezza nell’accoglierlo dentro di me. Ma è la recita che lo precede, il campo magnetico generato tra la nostra pelle, lasciar sparire ogni convenevole e vederlo trasformarsi in qualcosa che neanche i nostri occhi possono permettersi di riconoscere. Quando mi spoglio insieme a lui, chiunque esso sia, divento un’altra cosa, una creatura che non sapevo di conoscere ma che porto sempre dentro di me, addomesticata per stare in pubblico ma pronta a dimenarsi una volta spente le luci e chiuso il sipario. A volte credo che quello è il solo e unico momento in cui due persone sono davvero sullo stesso piano. Quello che abbiamo tra le gambe ci tiene ancorati l’uno dentro l’altro, attorcigliati in un nodo prima di esplodere e andarcene da un’altra parte, ritornando ognuno da solo nel proprio corpo.
Una volta io e un ragazzo abbiamo cominciato a farlo nonostante la mia testa fosse da un’altra parte. Pensavo che occorresse spogliarsi e affidare la responsabilità alla creatura per dimenticarmi di stare male. Ma nonostante la danza fosse iniziata da un pezzo, la creatura rimaneva a dormire: lui era dentro di me, e io ero sempre io. Ero io al mio peggio: ero quello che continua a dar la precedenza a tutte le macchine anche quando si trova sulle strisce pedonali, quello che chiede scusa a chi gli pesta i piedi in metro, quello che ha paura a passare vicino a un gruppo di maschi eterosessuali rumorosi a tarda notte, io che dimentico cosa sto dicendo, io che sbaglio parole e congiuntivi. Rassegnato ma ormai in trappola, per la prima volta finii per guardare l’altro con gli occhi di tutti i giorni e senza miracoli: vidi le smorfie ridicole, i versi esagerati, l’impegno smoderato nel darmi tutto il suo corpo nonostante non sentissi niente. Fu lì che la vidi, la creatura allo scoperto, smascherata da ogni trucco e in tutta la sua inutilità. Eppure, ci ricasco ancora. Ci sono giornate che voglio solo quello e la creatura si muove e scalpita dentro, bisognosa di essere liberata. Penso ancora di trovare un miracolo in quell’atto: uscire dal mio corpo, unirmi a una legge più grande di me, più grande delle mie bugie e delle mie paure. Sembra quasi che il pene dell’altro abbia il potere di ricordarmi cosa mangiare, come vestirmi, cosa pensare, che strada prendere, dandomi il permesso di esistere alla luce del giorno e ritornare nel mio corpo, perché validato dal suo tocco magico. A volte, nel pieno dell’atto, mi piace immaginare per una frazione di secondo di farlo al centro di un ristorante pieno zeppo di persone, di buttare in faccia agli altri tavoli la realtà, di far vedere loro quello che siamo veramente, mentre loro scelgono quale forchetta usare, selezionano le parole adatte, mostrano le verità che vogliono, ma è quello che tengono tra le gambe a svelarli per ciò che sono davvero. Ma se c’è verità è che siamo rimasti solo noi, due corpi in una stanza che le persone agli altri tavoli non hanno neanche la fantasia di varcare. Credo di trovare un tesoro nei tuoi pantaloni, una leggenda, un mito in grado di svelare il mio posto nel mondo, ma è un abbaglio, un’allucinazione che sembra durare una vita ma sono solo quindici minuti. Non è più il 1998, ma se mi concentro riesco a ricordarlo e salvarmi all’ultimo minuto : è una proboscide con la criniera e non ha nulla di speciale.
Riccardo Conte nasce a Roma il 28 Maggio del 1994. Cresce in una fattoria dell’agro pontino, tra mucche, galline, e mascolinità tossica. Si laurea nel 2019 in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza di Roma. Oggi segue un master in Arti e Mestieri del Racconto presso la IULM di Milano. Legge Sally Rooney, ascolta Giuni Russo, e pensa almeno una volta al giorno alle sorelle Rohrwacher. Nella vita vorrebbe scrivere storie per far sentire se stesso e gli altri un po’ meno soli.