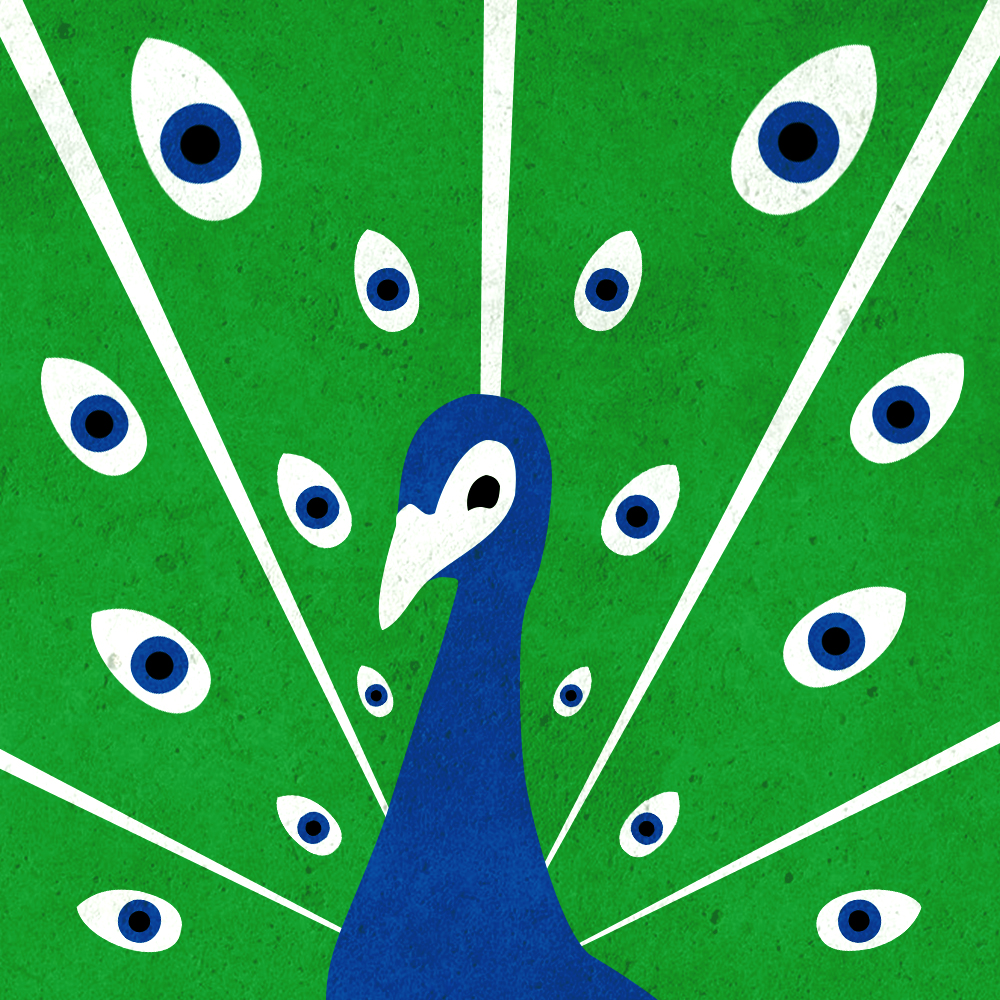Non è ancora successo
Elia arriva davanti al locale verso le sei di sera. Marco lo aspetta in piedi accanto all’entrata, in attesa di iniziare il turno. Ha le mani in tasca e guarda verso un punto fisso all’orizzonte. Indossa una camicia bianca che sembra viva nell’aria tiepida di maggio. La luce che sfuma nella sera imminente si riflette sulle lenti dei suoi occhiali a goccia, nascondendogli i profondi occhi azzurri.
«Si può sapere perché mi hai fatto venire fino a qui? Non potevi spiegarmi tutto per telefono?» dice Elia, spazientito.
«Ti saresti fatto negare,» dice Marco, girandosi lentamente verso di lui. Gli occhi azzurri ricompaiono e sembrano carichi di accuse.
Elia sostiene che non è vero ma non riesce a ricambiare lo sguardo.
Il pomeriggio cede il posto alla sera. La luce arancio acceso del sole in picchiata riverbera sull’asfalto del parcheggio vuoto antistante il locale. L’aria odora di stagione che cambia.
Marco estrae un pacchetto di sigarette dalla tasca posteriore dei jeans. Ne sfila una direttamente con la bocca e l’accende.
Soffia una boccata di fumo che si disfa nell’aria in volute lattiginose ed evanescenti. «Noi domani scendiamo a Gallipoli. Te lo ricordi che domani è un anno esatto, vero?»
Elia sospira e si porta una mano agli occhi. Sente l’aria farsi improvvisamente fredda. Il brusio del traffico è un mormorio lontano e quasi ipnotico. L’ultima luce del giorno si allarga nel parcheggio come scintillante sangue rappreso.
«Non so se me la sento,» dice Elia.
«Eri il suo migliore amico.»
«Lo eravamo tutti.»
Marco prende un’altra boccata dalla sigaretta. «Eravamo tutti suoi amici… Tu eri il migliore amico, è diverso.»
Una coppia passa davanti al locale mano nella mano. Si ferma e si volta a guardare la porta d’ingresso.
Marco solleva la mano con la sigaretta e mostra il palmo. «Non siamo ancora aperti. Tra un quarto d’ora circa.»
La coppia si dilegua in silenzio.
Elia si passa una mano tra i folti capelli castani. «Il fatto è che… rivedere tutti… rivedere sua madre… Sul serio, Marco, io non so se ce la faccio.»
Marco muove qualche passo e si avvicina ai vasi di Pitosforo che costeggiano la vetrata del pub. Le piante sembrano malate, scheletriche. Passa una mano tra le foglie secche e ingiallite. «Ci pisciano su,» dice.
«Cosa?»
«I clienti. Fanno il pieno di birra e quando trovano la fila al bagno si svuotano nei vasi.»
«Che schifo.»
«L’hai detto.» Marco aspira fumo dalla sigaretta ormai al limite. «Quindi, tornando a noi… Domani vieni di tua spontanea volontà o devo trascinarti di forza?»
Marco risponde alla punta della sigaretta che diventa brace. «Parli bene tu ma io… È una cosa difficile da spiegare. Insomma, se proprio lo vuoi sapere… non è ancora successo, ecco.»
Marco inarca le sopracciglia.
Elia distoglie lo sguardo. «Silvio è morto da un anno e io non sono ancora riuscito a versare una sola lacrima, ci credi? Neanche al funerale. Ti sembra una cosa normale? Chiunque al posto mio sarebbe sconvolto e invece… è come se non provassi niente. A volte stento persino a ricordare il suo volto.»
«Ognuno reagisce al dolore come meglio crede.»
Elia si guarda intorno, come a cercare conforto nei pali della luce che costeggiano la strada o nell’insegna del pub che tra poco si illuminerà di verde elettrico. «Io non ero “ognuno” per Silvio, lo hai detto anche tu. Non ce la faccio a rivedere tutti gli altri. Ad affrontare sua madre e a scoperchiare il vaso dei ricordi. Già mi vedo lì impalato come un fesso, senza una lacrima, una parola dolce. Che ne so… Un gesto di conforto, una manifestazione di dolore. Ho paura di fare la figura dell’impostore, e anche un po’ stronzo.»
Marco getta il mozzicone a terra e lo schiaccia sotto la scarpa. «Farai una figura peggiore se non ti presenti.»
Stefano, il padrone del locale, esce per sistemare alcune sedie all’esterno. Sembra affaticato e nervoso e la luce si riflette sulla superficie calva della sua testa, striata da un riporto unto simile a graffi di tigre. Si volta verso Marco e lo fulmina con uno sguardo sul punto di trasformarsi in insulti sull’atroce andante.
«Devo andare,» dice Marco. «Vuoi entrare e farti una birra?»
Elia scuote la testa. «Mi faccio un giro e poi vado a casa. Chiara stacca tardi e voglio farle trovare la cena pronta.»
Marco sorride. «Ma che bravo fidanzatino. Senti, noi domani partiamo alle otto. Vedi di esserci altrimenti mi arrabbio, chiaro? Dacci un taglio con queste stronzate sul pianto greco. Alle sette e mezza sotto da me. Ti offro pure la colazione.»
Elia fa per rispondere ma Marco è già una schiena che si allontana e sparisce nel locale.
Alcune auto entrano nel parcheggio. Il parabrezza riflette porzioni di cielo e geometrie di città.
Ognuno si muove al centro della propria vita ed Elia pensa a Silvio, morto giusto un anno fa. Si ricorda il suo volto.
La panchina è dura e troppo fredda per una serata di maggio. Gli fa male il sedere. Elia osserva alcuni ragazzi giocare a basket nel campo di cemento vicino al parco. Le suole di gomma delle loro scarpe squittiscono nei passaggi corti.
Una signora passa con un cagnolino nervoso al guinzaglio. Le finestre dei palazzi di fronte iniziano a illuminarsi come occhi ammiccanti. Il traffico è un respiro irregolare che s’avvicina per poi ritirarsi, come una risacca di rumore bianco.
C’è stato un tempo in cui quel parco era la loro fortezza, il punto di ritrovo, il bazzico. Interi pomeriggi trascorsi con Silvio e gli altri a guardare le ragazze della palla a volo che passavano di lì dopo l’allenamento. Le prime canne fumate con la schiena poggiata contro i murales sbiaditi e le frasi oscene scritte a caratteri spessi.
Pensavano a un sacco di cose.
Nessuno pensava che sarebbe mai morto.
Un aeroplano sorvola il parco lasciando dietro di sé una linea di vapore bianco che taglia il cielo in diagonale, simile a un doloroso graffio troppo superficiale per produrre sangue.
Elia immagina i passeggeri all’interno. File di gente seduta a leggere, guardare film dai piccoli schermi sul retro dei sedili, osservare il mondo dal finestrino.
Si domanda quanti di loro abbiano perso qualcuno. Un amico, un genitore, un figlio. Si interroga con quanta facilità siano riusciti a sputare fuori il dolore, ad affrontarlo da persone normali. Quante lacrime sono riusciti a versare. Quante ne versano ancora.
Era dai tempi dell’adolescenza che non si sentiva così maledettamente diverso, così tagliato fuori dal mondo.
Il telefono gli vibra in tasca. Elia lo estrae e legge il messaggio di Marco: “Domani alle sette e mezza sotto da me. Non fare scherzi. Silvio avrebbe voluto così.”
Sente una strana morsa alla bocca dello stomaco ma nessuna ondata di lacrime sulla rampa di lancio.
Getta uno sguardo all’orario sullo schermo.
Con gesto forzato si alza dalla panchina. Mentre si massaggia la schiena dolorante ripete a se stesso che deve preparare la cena per Chiara.
Lo accoglie il silenzio ovattato della casa vuota. Elia getta le chiavi sul mobile in soggiorno e si dirige in cugina, muovendosi sicuro nella penombra che cede il posto al buio. Non accende la luce. C’è nell’aria quell’odore dolciastro tipico delle abitazioni che aspettano il ritorno dei proprietari dalle vacanze.
La testa di Elia è una girandola di pensieri che si rincorrono e azzannano come cani randagi nella canicola di qualche polveroso paesino abbandonato.
Si affaccia alla finestra e guarda fuori attraverso il suo stesso riflesso evanescente. I lampioni si accendono gettando una luce giallo melone sulla strada grigia e sporca. Le antenne delle televisioni si stagliano contro il tramonto come scheletri di soldati nel turno di guardia. Pochi schiamazzi di ragazzini che corrono verso la cena che li attende.
Domani deve andare. È passato un anno e Silvio avrebbe voluto così.
Una volta erano inseparabili.
Una volta erano una cosa sola.
Una volta erano.
La morsa allo stomaco si trasforma in un vuoto preciso, circoscritto tra le budella e l’anatomia nei pressi.
Una lacrima, improvvisa e del tutto inattesa, scende dall’occhio destro di Elia e gli solca la guancia.
Una sola.
Grossa e calda come una coperta usata a lungo.
Non l’asciuga con il dorso della mano. Non la tocca. La lascia lì.
Fino al ritorno di Chiara non muove un muscolo.
Giuseppe Congedo nasce ad Aprilia (LT), il 27/09/1983. Sin da piccolo si appassiona con forza ai fumetti, scoprendo prestissimo Dylan Dog e diventandone un avido lettore. Dopo un diploma in agraria ed una fugace avventura universitaria, decide di seguire le sue passioni iscrivendosi al corso di “Sceneggiatura per Fumetto” presso la “Scuola Internazionale di Comics di Roma”. Sotto gli straordinari insegnamenti di Lorenzo Bartoli, ottiene un diploma in sceneggiatura con il massimo dei voti. L’anno seguente consegue un master di specializzazione tenuto da Roberto Dal Prà. Quest’ultima esperienza gli consente di effettuare le sue prime pubblicazioni in campo fumettistico presso la rivista Icomics della Kawama editoriale. Ha pubblicato per LetteraturaHorror.it, Dunwich Edizioni , ESESCIFI, IVVI Editore e la rivista IL BUIO. Collabora, in qualità di sceneggiatore, con la Bugs Comics. Appassionato di scrittura a tutto tondo, si destreggia anche nella scrittura di racconti e poesie. Ha esercitato il ruolo di insegnante di sceneggiatura presso la “School Comics” della sua città.