La lunga strada di sabbia (parte 2)
(Leggi la prima parte)
Rosignano Solvay, luglio
Arrivo a Solvay con l’intenzione di visitare la centrale chimica i cui scarichi, nel corso di più di un secolo di operazioni, hanno reso la spiaggia di Rosignano di un bianco innaturale, accecante, e l’acqua di un azzurro artificiale. Il mare è così trasparente che ci si potrebbe leggere un libro attraverso. Tutto splende di una luce fredda, spaziale. Un cartello annuncia il divieto di balneazione ma le persone fanno il bagno lo stesso. Mi avvicino a un uomo che cammina sulla sabbia, gli chiedo se è pericoloso fare il bagno. Non lo sa, mi risponde, è la prima volta che viene qui.
Cammino per le strade deserte di Rosignano, un paese fabbrica, con le case basse e quadrate suddivise in lotti, secondo la gerarchia lavorativa: da una parte i dirigenti, dall’altra gli operai. Non c’è un bar, un caffè, un negozio. Dietro la fila di case identiche, separate dall’autostrada, si vede solo la fabbrica, fredda, imponente, una presenza irreversibile. Il tutto è circondato da un deserto, anche se di pochi chilometri, che separa il paese dagli altri centri abitati.
Quercianella, luglio
Mi tuffo da una scaletta, un azzurro freddo e chiaro mi rimane negli occhi per un momento quando esco dall’acqua, il tempo di asciugarsi al sole. Il mare di Quercianella ha il colore di qualcosa che è appena venuto al mondo, limpido come un quarzo. Poi il riposo all’ombra del gradino di una piccola cappella. Un uomo anziano legge un libro di Durrenmatt sotto un ombrellone giallo. Di fronte a me una roccia bianca di sole, sotto di me la pietra fresca, liscia come pelle.
Porto Ercole, luglio
Del monte Argentario ricordo una vacanza in famiglia. Avevo tredici anni, mia madre e mio padre avevano affittato una casa in campagna, in una zona isolata, lontana dal paese. Ricordo che una mattina mi alzai presto, e presa da non so quale urgenza, corsi alla porta. Forse mi era sembrato di sentire un rumore, forse semplicemente volevo uscire a prendere un po’ d’aria in uno dei pochi momenti in cui potevo stare sola. Ricordo la porta della casa, di legno massiccio, con un chiavistello di metallo che si chiudeva dentro il muro di pietra scura. La aprii con cautela per non fare rumore. Fuori era silenzio, il cielo grigio azzurro, la campagna umida, ancora fresca delle impronte di cinghiali, lepri. Ricordo solo il cielo, appena offuscato dalla brina, il monte, il desiderio di aprire la porta. Svenni sull’uscio.
Al mio risveglio, sono ancora sola. Tutti dormono, nessuno si è accorto che sono svenuta. Sento un dolore leggero all’anca dove ho battuto cadendo. Mi gira la testa. Aspetto un momento prima di rialzarmi. Le nuvole si muovono lentamente, sembrano seguire il mio respiro. Il monte davanti a me, blu. E il calore del mio corpo contro la pietra fredda.
Ostia, luglio
Il treno è pieno di ragazzi che hanno finito la scuola, le ragazze hanno la pancia scoperta e il costume da bagno sotto la maglietta. Salgono, si siedono, ascoltano musica, scherzano tra di loro. Poi ne salgono altri, e poi altri, finché il treno si riempie di zaini colorati, pantaloncini, scarpe da ginnastica, palloni, risate, insulti. Vorrei seguirli, fare il bagno con loro. Sono gelosa della loro leggerezza, della loro arroganza, del piacere, quasi rabbioso, che provano nello stare insieme.
Cammino nel vento leggero: una giostra abbandonata, una fila di persone in coda alla posta, due o tre bambini in bicicletta attorno alla fontana. Ostia, con i palazzi che cadono a pezzi, il lungomare sudicio, è una spiaggia di città, una Coney Island dell’anima. Mi butto nell’acqua sporca, nel cielo appannato, il sole mi brucia gli occhi.
Terracina, luglio
Un treno attraverso la campagna arida, poi una lunga attesa nel piazzale di una stazione vuota. Colline basse, le cui forme irregolari gettano strane ombre sui campi. Una volpe si affaccia dal grano tagliato. Cammino a lungo alla ricerca di un posto dove dormire. Vado verso il luogo dove la mappa segna un campeggio ma non c’è niente, solo l’autostrada, e dietro la montagna nera un tramonto che sembra avvelenato. Trovo una stanza in una pensione vicino a una pompa di benzina, un piccolo soppalco bollente, e dalla finestrella, oltre l’insegna blu, la notte di Terracina, profonda, lontana dal mare, come inghiottita nella bocca del mondo.
La mattina mi alzo appena prima dell’alba per salire sul tempio di Giove Anxur. Una lunga strada sale sopra la collina, tra le mura antiche della città vecchia, tra le radure abbandonate. Solo i gatti si accorgono del mio passaggio, sonnolenti, apatici, sbiaditi nella luce ancora flebile. Minuscole farfalle giocano tra le ombre, qualche uccello troppo lontano nel cielo chiaro. Scendo in paese lungo le mura, si ha l’impressione di entrare nelle case della gente, ancora silenziose nelle prime ore del mattino. Scendo per un vicolo e mi ritrovo di fronte a una chiesa. La facciata, bianca, è alta, poco appariscente se non fosse per alcuni dettagli che catturano la mia attenzione. Uno scheletro in mezzo alla facciata ha in mano una lancia o una freccia, come la lancetta di un orologio. Piccole ossa sporgono sotto i davanzali delle finestre, nido di colombi e piccioni in delicato equilibrio sulla sottile striscia di marmo, ricoperta di piume. La chiesa è chiusa. Chiedo a un uomo che dal bagagliaio di una macchina scarica casse di frutta e verdura se può fornirmi qualche informazione in più. “Non è quasi mai aperta, e se è aperta non c’è nessuno dentro.” E i teschi? Le ossa? “È il purgatorio. Quando uno non va in paradiso o all’inferno, ma resta qui, in questo mondo”.
Sperlonga, luglio
Arrivo a Sperlonga sotto il sole bollente. Cerco un posto per fare il bagno prima di proseguire. Mi avvicino agli stabilimenti appena sotto la piazza. Un cartello indica che questa è una “slow beach”, che come lo slow food, è un lusso per pochi.
Scendo per la scalinata di gradini bianchi, asettici. Il mare è azzurro, immateriale, come se venisse proiettato su una parete chiara di sabbia. Lascio lo zaino sulla barca di salvataggio di un bagnino. Vado a fare il bagno, gli dico, mentre poso le mie cose, in attesa di un cenno di approvazione. Vai, mi risponde il ragazzo dai capelli scuri. Mi butto in acqua e comincio a nuotare, il mare liscio sotto le mie braccia, negli occhi aperti il bianco e l’azzurro si fondono fino a diventare luce. Mi giro a guardare la spiaggia ormai lontana, le case bianche basse, arroccate sulla cima della scogliera.
Napoli, luglio
Ogni volta che esco dalla stazione di Napoli e attraverso piazza Garibaldi ho sempre lo stesso pensiero, non vorrei dimenticarmi niente di quello che mi passa sotto gli occhi, vorrei trattenere dentro di me ogni gesto, ogni volto, ogni finestra socchiusa. Ma le immagini si poggiano sulla retina come farfalle, prima di scomparire:
La strada che da Chiaia attraverso due file di aranci scende al lungomare, le panchine attraversate dal vento.
I bambini che si tuffano dal molo di Mergellina, risalgono dai gradini di pietra, si tuffano di nuovo. Per ore ripetono il gioco sotto gli occhi delle madri, sedute su sdraio gialle, immerse nel mare fino alla vita.
Un bambino che spara bolle di sapone con una pistola fuori dal finestrino di una macchina parcheggiata.
Il volto di sant’Orsola nel dipinto di Caravaggio, il ventre trafitto da un coltello, e Caravaggio che da dietro, il braccio attorno alla vita di lei, tenta di salvarla.
Le impalcature tra i vicoli del quartiere di Forcella, installate dopo il terremoto del 1980, e mai tolte. Enormi scheletri arrugginiti riempiono il vuoto tra le strade strette, le case ancora inagibili.
La fotografia del mio bisnonno, ferroviere anarchico, esposta sul camino della casa delle mie zie, nelle periferie di Napoli. Cinque sorelle che convivono in una vecchia casa di campagna, e il ritratto dell’uomo che ancora le comanda con gli occhi.
Le cinque sorelle che invasano la salsa di pomodoro per l’anno che viene, nel cortile della casa, sotto un albero di cachi.
Una chiesetta gialla sulla via per Posillipo.
Ischia, luglio
Non andrò a Ischia, penso, uscendo dall’hotel. Nella hall due donne arabe velate dello stesso color pesca siedono ai tavolini, bevono un caffè, avvolte in una nube azzurra di fumo che accompagna i loro discorsi animati. Il traghetto costa troppo, perderei tutta la giornata, e poi l’isola che ha visto Pasolini non esiste più, i lungomari scintillanti, le eleganti hall degli alberghi dove alloggiavano le attrici, gli archi di lampadine nelle feste d’estate sono scomparsi. Meglio restare a Napoli, mi ero ripromessa di tornare a Capodimonte, fare una telefonata, e perché no, riposare. In strada sono le nove e fa già caldissimo. L’odore della frutta marcia sugli usci dei piccoli alimentari mi investe assieme al tanfo dei cassonetti aperti della spazzatura lasciata sotto il sole. Una scia di macchine bollenti riempie il viale, la piazza. Guardo l’orologio, l’ultimo traghetto della mattinata per Ischia parte tra un’ora. Torno indietro, su per le scale, afferro il costume e sono già in strada. Corro attraverso il traffico, le bancarelle di frutta, i banchi di sigarette di contrabbando, i cani moribondi, i bambini che giocano a palla per strada, una coda di persone in fila per entrare alle poste, gli hotel a una stella, i chioschi di taralli, i negozi di souvenir e occhiali da sole e foulard colorati che svolazzano nel vento. Oggi al porto ci sono la guardia di finanza e la televisione; telecamere, microfono accesi, uomini in divisa controllano che tutti indossino la mascherina.
La nave mi lascia in paese, cerco la corriera per Sant’Angelo. Sull’autobus, un uomo anziano, un abitante dell’isola, si lamenta quando a una fermata una donna sale senza pagare il biglietto. “Noi che viviamo qui spendiamo quasi duecento euro ogni anno,” dice in dialetto, e continua a lamentarsi finché il conducente gli risponde, chiamandolo per nome, “Non ti finisce mai la voce?” L’autobus passa tra gli oleandri, le casette bianche, i battelli, un albergo per turisti tedeschi, un bar che vende dolci siciliani, una terrazza di canne che si affaccia sul mare. Mi dirigo verso la spiaggia, tagliata a metà da un’enorme roccia che segna la punta più a sud dell’isola. Una coppia di turisti mi passa di fianco, “You’re gonna fish? That’s so cool!” dice la ragazza americana, e i due scompaiono dentro uno yacht ancorato nel porticciolo. Cammino lungo la striscia di terra che collega la spiaggia alla roccia; dietro la parete a strapiombo, uno scoglio bianco lambito dalle onde. Mi tuffo nel mare aperto, l’ombra di un gabbiano come un coltello nel sole.
(Leggi la terza parte)
Francesca Coppola è scrittrice e filmmaker. I suoi testi sono stati pubblicati su BOMB Magazine, NY Tyrant, Fence, FU Review Berlin e altre riviste. Ha pubblicato un libro di poesie (Where the Sirens Live, 2019). Vive a Roma.

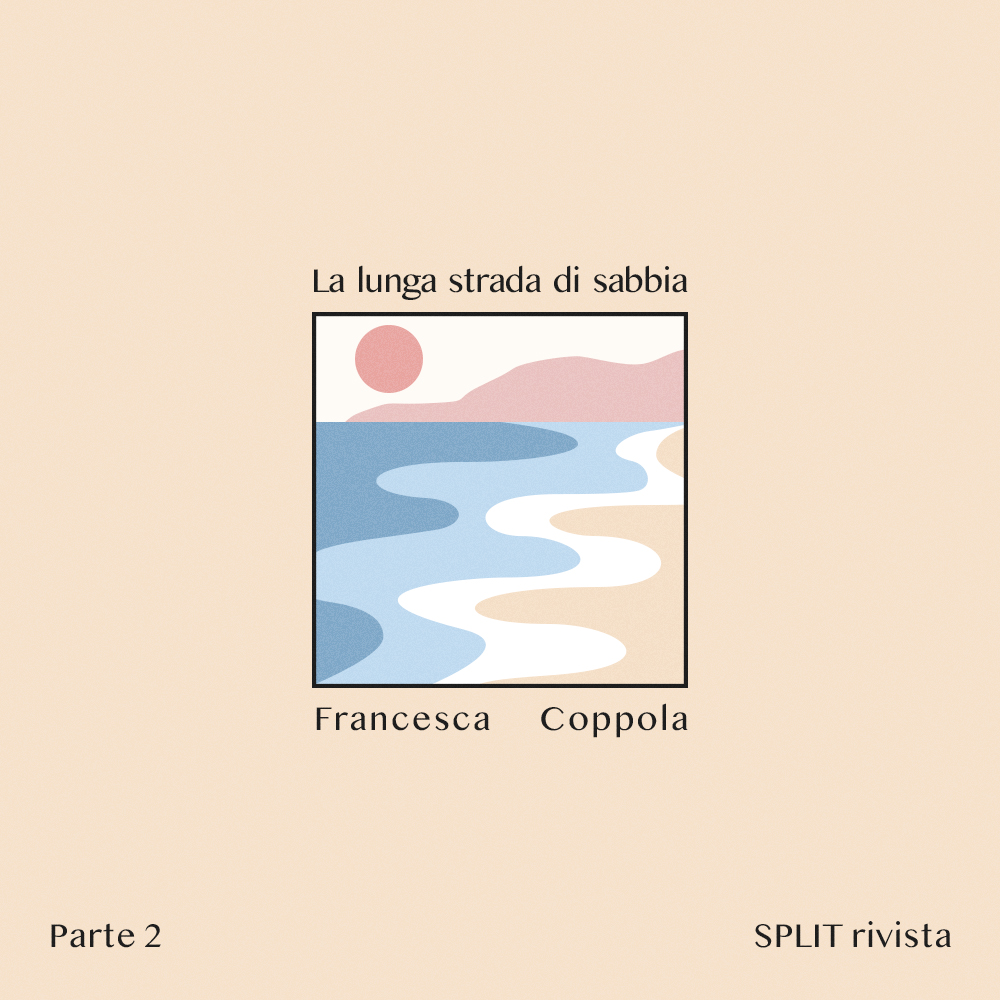



1 Commento
Unisciti alla discussione per dirci la tua
[…] (Leggi la seconda parte) […]